
Sempre più vicini all’estate, in un desiderio continuo di fioritura, “Fare Voci” anche per questo nuovo maggio continua il suo cucire territori e sguardi, narrazioni ed espressioni.
E in questo numero lo facciamo con Sandro Frizziero e il suo romanzo “Il bene che ti voglio”, vero e proprio taglio di bisturi nel rinomato Nordest produttivo, sempre più incistato e straniante.
Il Tempo presente è anche nelle quattro poesie inedite di Valerio Vigliaturo, mentre la voce d’autore trova ancora più significato con Sandro Pecchiari e il suo “Alle spalle delle cose”, e con Valeria Raimondi e le pagine de “Il penultimo giorno”.
Ricco anche il ti racconto: con il narrare di Emiliano Sabadello in “DC9” e con il “Paradosso mentale e storia breve” di Emma Gustafson.
I Margini. Di poesia ed altro sono altre due novità: Alberto Fraccacreta e “Del tutto diversi”, Diletta D’Angelo e “Defrost”.
Il Libroelibro è un ampio esplorare lo scrivere di Francesco Filippi, nelle pagine del suo “Ma perché siamo ancora fascisti? Un conto rimasto aperto”.
Le Immagini sono le dieci fotografie di Paolo Veneziani.
Buona lettura.
Giovanni Fierro
(la nostra mail farevoci@gmail.com)
Immagini ———————————
Alseno (Piacenza) 2023
Dieci fotografie
di Paolo Veneziani

Voce d’autore —————————-
In stato avanzato di tramonto
Sandro Frizziero, “Il bene che ti voglio”
di Roberto Lamantea

Alessio Gorgosalice ha una moglie, Isabella, ingegnere, un’amante, Barbara, e nonna Armida, che vegeta in Villa della Pace – una delle tante, costose e angoscianti case di riposo – nella dimensione oscura dell’Alzheimer. Nella penombra della stanza Alessio si racconta, si svela sapendo che, forse, nessuno l’ascolta, nonna Armida è altrove.
Dopo lo splendido, nero “Sommersione”, Sandro Frizziero torna in libreria con il nuovo romanzo “Il bene che ti voglio” (Mondadori), e affonda il bisturi – anzi, scrive con il bisturi – in una “landa” – i politici lo chiamano “territorio” – costruita mattone dopo mattone negli anni del boom economico devastando natura, paesaggio e storia. È il Nordest vivisezionato da Francesco Targhetta, Vitaliano Trevisan, Francesco Maino, la terra arata dal “progresso scorsoio” denunciato da Zanzotto, il Golfo Padano su cui lo scrittore di Chioggia offre una premessa geopaleontologica. La terra dove “i palazzi nascevano spontaneamente come asparagi”: “Palazzi dall’alto fusto, robusti, che con la loro ombra coccolavano il sottobosco di automobilisti, di ciclomotoristi, di pedoni indaffarati e di scarrozzati disabili”.
Nel romanzo è una geografia precisa, la pianura a ridosso di Mestre, l’ex campagna che non è neanche periferia, è “località”, come la chiama Valentina Pasquon nel racconto autobiografico “Era primavera d’amaranto” (Manni), gli ex paesi – ora omologati in un’uniforme distesa di cemento, asfalto e campi di formenton – del Miranese, dove abita e si agita l’homo veneticus.
Luoghi simbolo del libro sono via Galilei a Santa Maria di Sala, dove Alessio Gorgosalice (nome un po’ gaddiano) abita, e il parcheggio dell’Alì di Maerne, anonimo come tutti i parcheggi dei supermercati, dove Alessio incontra Barbara.
Come in “Sommersione” anche qui il paesaggio è in decomposizione, dove anche il cielo è “in stato avanzato di tramonto”. Ma ci sono anche la Romea – la regionale Venezia-Ravenna – e il Polesine. Se “Sommersione” – che per un soffio non ha vinto il Campiello – è ai confini dell’horror-noir alla Poe ed è tessuto in una scrittura fitta tramata nella seconda persona narrativa – il “tu” con cui lo scrittore si rivolge e racconta il suo personaggio – “Il bene che ti voglio” alterna alla classica terza persona un “io” che Frizziero usa come una telecamera e un flusso di coscienza che registra i pensieri e gli sguardi del protagonista e il paesaggio urbano diventa caleidoscopio linguistico.
Lo spazio simbolo del romanzo è il parcheggio dell’Alì di Maerne, uno dei “non luoghi” del Miranese: “distesa bituminosa divisa in stalli, terreno lunare nero, artificiale, a grani grossi, dove sbarcare dopo viaggi interstellari, dove d’estate pneumatici e asfalto si fondono, e d’inverno invece si scivola al primo ghiaccio” e dove sopravvive “qualche patito alberello”.

Così via Galilei a Santa Maria di Sala, dove abita Alessio, “è la mia casa, dove l’inverno è freddo e nebbioso e l’estate brucia le tegole, mangia i mattoni […] Via Galilei è uguale a tutte le altre: è percorsa da SUV in leasing, da mietitrebbie quando è stagione, da furgoncini di elettricisti e da braccianti indiani in bicicletta. Sulle nostre strade, Barbara, vengono investiti più braccianti che nutrie”.
Già, pensare che sino a una decina di anni prima via Galilei – come mille altre strade della zona – non esisteva: “Al posto delle villette a schiera c’erano campi, solo terra bruna graffiata dai trattori. […] Poi il piano regolatore aveva reso i terreni edificabili: dalla profondità della terra erano sorte le villette. […] Spazio, cioè terra, convertito subitamente un denaro”.
Ecco dove il nuovo libro di Frizziero ha un colpo d’ala, dove la storia – tutto sommato anonima, uguale a tante altre – di Alessio Gorgosalice si trasforma in un’analisi desolata, un’antropologia di un Veneto devastato dal mito degli “schei”. Certo, c’è ironia in queste pagine, ma al gusto di fiele: “Insomma, Barbara, comprendi perché in via Galilei sto in paradiso? Qui nella Landa si rosicchia il rosicchiabile, si copre il copribile, col cemento, col calcestruzzo, con l’erba finta del calcetto, con le piastrelle delle corti, con i viadotti e i passanti, con i depositi e i parcheggi, con le piste ciclabili e i supermercati. Pure con le aree verdi, dove imbullonare panchine e giostrine, cestini e attrezzi per la ginnastica. Tutto è soffocato, tombinato, schiacciato, impermeabilizzato. L’architettura, però, è ecosostenibile: l’architettura è smart”.
C’è un’affinità profonda con la scrittura del trevigiano Francesco Targhetta, in particolare l’ultimo libro, “La colpa al capitalismo” (La nave di Teseo 2022), uno sguardo al Veneto degli ultimi decenni che diventa amarissima antropologia politica: “Qui nella Landa non si fa tutto per i soldi, no no, questa è una semplificazione. No, non si lavora per l’auto sportiva, per la barca a vela ormeggiata a Caorle, per la casa al mare o in montagna, per le vacanze alle Maldive. No, non è avidità, non è egoismo. […] I contadini diventarono piccoli artigiani, elettricisti, idraulici, salumai, mulettisti, rappresentanti di commercio, agenti immobiliari. Gente unita dalla soppressa con i sottaceti e dal leon di San Marco. Non è stato per i soldi, ti dico. È fede, Barbara, è questione di fede. Siamo stati disposti a sacrificare tutto, tutto quanto per arrivare dove siamo e questo è il contrario dell’egosimo, il perfetto contrario”.
Un mondo, si legge più avanti, finto, dove a essere finti sono anche gli uomini. Un mondo – è la frase amarissima che suggella la quarta di copertina – dove “non c’è niente di umano nella gente”.
È una narrazione all’acido muriatico, quella di Frizziero, ma dove l’abilità dello scrittore di Chioggia fa sempre filtrare l’ironia: non di rado, leggendo, si ride di gusto. Anche qui, come in “Sommersione”, la scrittura è vertigine: lunghi periodi in cui si mescolano sguardi all’ambiente esterno – stanza o paesaggio – a dettagli visivi – una macchia, uno strappo – o sonori – una goccia d’acqua che martella il piano della doccia. La scrittura è vortice, una sabbia mobile. Frizziero governa il magma, lo modella, lo distilla, la sintassi ha una fluidità ai confini del flusso di coscienza: narrazione e pensiero del protagonista Alessio si alternano, si fondono, catturano il lettore, lo inghiottono in un flusso che somiglia al dormiveglia.
C’è un passaggio mirabile (pagina 106) dove Isabella “è montagna alta e aspra”; Barbara “è lago immobile eppure profondo, freddo, appena inasprito in superficie da carsiche pulsioni”; “Alessio è pianura faticosamente sottratta alle acque”.
Il paesaggio urbano diventa caleidoscopio linguistico in pagine che ricordano il Francesco Maino di “Cartongesso” (Einaudi 2013) e “Ratatuja” (Ronzani 2016), mentre le citazioni sono appena suggerite, da Kafka a un diavolo bonario alla Bulgakov.

Intervista a Sandro Frizziero:
“Il bene che ti voglio” è ambientato nella “Landa”, quel lembo della pianura veneta identificabile grosso modo con il comprensorio di Mirano. Il parcheggio dell’Alì di Maerne diventa un luogo iconico, come via Galilei a Santa Maria di Sala. Ci sono anche la Romea e il Polesine. Rispetto a “Sommersione”, la cui geografia immaginaria poteva far intuire Pellestrina ma era più un luogo metafisico, i personaggi del tuo nuovo libro si muovono in un ambiente reale. Come sono nati personaggi e ambientazione?
Come è già successo in “Sommersione”, sono i luoghi del romanzo a produrre, direi quasi a emanare, i personaggi. Il paesaggio non è scenografia, ma coprotagonista del racconto. L’isola di “Sommersione” per me non è un luogo meno reale del Polesine; ma si può dire anche il contrario: i luoghi del Bene sono, similmente, il frutto di una ricreazione fantastica, un microcosmo fittizio dove esercitare uno sguardo da entomologo sulle vite degli uomini. D’altra parte, la Realtà si intravede proprio laddove si rinuncia al realismo.
Nel Bene, certo, mi sono fatto suggestionare dalle atmosfere e dal paesaggio della provincia di Venezia. La centuriazione romana mi ha fatto pensare alle profonde trasformazioni che l’uomo ha prodotto sul paesaggio; trasformazioni peraltro di cui noi non abbiamo sempre coscienza, anche solo perché ci viviamo, ci passiamo ogni giorno. Per l’insider, in effetti, il paesaggio non esiste.
Scrivo forse proprio per questo bisogno di osservare con occhi nuovi quello che vedo tutti i giorni. È un esercizio che poi ho proseguito nel percorso che mi ha portato verso il Polesine e il Delta del Po, in un Veneto liminare, dunque, frequentatissimo dalla letteratura (come non ricordare, tra gli altri, Gianni Celati o, più di recente, “Pianura”, il bel libro di Belpoliti) eppure laterale rispetto all’idea stereotipata di questa regione. Sono luoghi che parlano di noi, della crisi economica, dello “sviluppo senza progresso” che spesso caratterizza le nostre città e le nostre campagne.
Qui si muovono i personaggi e se da una parte la loro medietà li rende comuni, quasi privati di un’identità specifica, dall’altra non potrebbero esistere altrove.
Da Comisso e Meneghello, a Vitaliano Trevisan, Bugaro, Maino, Targhetta, il “progresso scorsoio” di Zanzotto – ma anche la grande poesia nei dialetti – la letteratura sembra oggi più attenta alle realtà regionali. Secondo te esiste una letteratura veneta o è solo un’etichetta editoriale?
Già da qualche anno si assiste a quello che alcuni critici hanno battezzato il ritorno in provincia. Sempre più spesso le ambientazioni urbane, le vicende della borghesia cittadina, lasciano il posto ad un recupero della dimensione locale. Ovviamente questo si manifesta in modi molto diversi, spesso come un nostalgico tentativo di tornare, almeno con l’immaginazione, a quel piccolo mondo antico che il progresso scorsoio ci ha portato via.
Il passato, per alcuni, è quindi un rifugio, una sorta di via d’uscita dall’oggi e dalle sue contraddizioni che facciamo fatica a digerire. Per me, invece, la provincia deve essere un osservatorio privilegiato da cui studiare (con i mezzi della letteratura, ovviamente) dinamiche e tendenze che interessano anche contesti diversi e più ampi. Il caso veneto, in questo, è piuttosto emblematico.
Faccio fatica a individuare un territorio più raccontato, osannato e criticato del Veneto. Nonostante la sua marginalità culturale, rispetto ai grandi centri del potere editoriale almeno, ha prodotto narratori di prim’ordine (dalla cui lista, sia inteso, mi escludo per sincera umiltà) che hanno saputo leggere nel paesaggio e nelle dinamiche relazionali gli effetti di una industrializzazione veloce e travolgente.
Non so fino a che punto si possa parlare di letteratura veneta. O meglio, temo che l’etichetta possa, in fin dei conti, essere riduttiva. Gli autori veneti che si esprimono in italiano vanno inseriti nella letteratura nazionale, nella migliore. E questo non vuol dire non riconoscere in loro un’aria di famiglia, un comune sostrato culturale frutto del cattolicesimo, della società contadina, dall’industrializzazione, della speculazione edilizia, e di tutti gli altri fenomeni che qui più che altrove si sono manifestati.

Per raccontare il protagonista del romanzo Alessio Gorgosalice alterni la prima e la terza persona, a volte lo descrivi come un regista che filma il suo personaggio, altre gli dai il microfono, registri i suoi pensieri, persino i suoi sguardi; in “Sommersione” il protagonista è evocato attraverso il “tu”, sei tu narratore che gli parli. Come nascono queste scelte linguistiche?
Scrivere per me significa sperimentare, esplorare nuove modalità narrative. Mi pare che la più importante lezione del postmoderno, che pure qualcuno vorrebbe già finito, consista nel richiamare la necessità di interrogarsi non solo su cosa raccontare ma anche, forse soprattutto, su come farlo.
Lingua e struttura, quindi, diventano essenziali quanto il cosiddetto plot. Se in “Sommersione” ho utilizzato un tu narrante, scelta non nuova a dire il vero (penso, per esempio, al Perec de “Un uomo che dorme”), nel Bene invece ho voluto moltiplicare i narratori e conseguentemente i punti di vista. Non mi sono limitato ai personaggi “umani”: ho dato voce anche ad alcuni animali (tra i più comuni quanto invisibili come le farfalline del cibo), e anche ad altri elementi naturali, come i Colli Euganei.
Mi interessava costruire un quadro d’insieme che potesse trasmettere al lettore un’atmosfera, un contesto; il paesaggio, in senso ampio, nel quale si trovano a vivere i personaggi. Confido che la conseguente frammentazione non sia un ostacolo insuperabile per il lettore, anzi, rappresenti una sorta di sfida, un “gioco” per cui deve disporre le varie tessere di un puzzle e ricavare un suo personale sguardo su quello che racconto.
Non è un caso che alcuni considerino il Bene un romanzo sul rapporto tra le diverse generazioni (il nipote, la nonna, i genitori), altri si soffermino sulla descrizione del territorio, altri ancora sul “tema” della genitorialità (negata) o sulle pulsioni sessuali del protagonista. Ciò probabilmente dipende da come si dispongono le tessere del puzzle.
Nel dipingere il paesaggio di villette a schiera, condomìni o torri scrivi che nella Landa lo spazio, cioè la terra, è “convertito subitamente in denaro“; i soldi, “i schei” nel Veneto sono una fede; nella casa di riposo la nonna Armida è una cavia; la frase amarissima evidenziata anche nella quarta di copertina sentenzia: “Dopotutto, non c’è niente di umano nella gente”. Davvero viviamo in una società così disperata?
Non mi ritengo così pessimista. O meglio, per citare Gramsci, credo di aver fatto miei il pessimismo della ragione e l’ottimismo della volontà. Avere uno sguardo critico, anche iper-critico sul presente, sfuggendo, si badi bene, ai facili complottismi, non deve inibire l’azione, la volontà di cambiare le cose, migliorarle. Io credo molto nel significato politico della letteratura che è efficace proprio nel momento in cui non fa direttamente ed esplicitamente politica e non vuole insegnare qualcosa.
Per questo mi auguro che i miei libri aprano una sorta di breccia nelle certezze che ognuno si costruisce.
Per il resto, continuo ad avere una grande fiducia nell’uomo e nella sua capacità di voler bene a se stesso e agli altri. Per recuperarla e metterla in moto però occorre togliere gli occhiali dell’ideologia dominante, sfuggire dalle narrazioni facili che offrono buoni sentimenti preconfezionati, privi di portata critica e quindi di prospettiva politica.

L’autore:
Sandro Frizziero è nato a Chioggia nel 1987. Ha esordito nel 2018 con “Confessioni di un Neet”, edito da Fazi, finalista al premio John Fante 2019. Nel 2020 ha pubblicato “Sommersione” (Fazi), classificato secondo al premio Campiello.
Suoi racconti sono usciti su quotidiani e blog letterari. È professore di Lettere nelle scuole superiori.
(Sandro Frizziero “Il bene che ti voglio” pp. 228, 18,50 euro, Mondadori)
Immagini ———————————
Castelnuovo Bocca d’Adda (Lodi) 2023
Dieci fotografie
di Paolo Veneziani

Tempo presente ————————-
Visibile, non più trasparente
Quattro poesie inedite
di Valerio Vigliaturo

La schiera degli elefanti appostati
dimora senza inservienti, luci all’alba
vengono a prenderti in fila indiana
dune desertiche, pendii scoscesi
rotolarsi nell’oasi facendo surf
sabbia penetra dentro i boxer
ci fosse qualcuna che la tolga
curasse i lividi, anni e anni
a rimarginare ferite aperte
spegni le voci di corridoio
purché se ne parli a sproposito
non era pace ma silenzio
dilaniante e tamburi battenti
preparano un’orgia di scheletri
santi come la morte incombente
un motivo per scongiurare l’aumento
allontana il nemico fattelo amico
il tempo ripercorre ogni istante
incapaci di ammettere le colpe
sarai più amabile e gentile
visibile, non più trasparente
*
Coro adiacente al palco
musica vaporizzata quiescente
il maestro dirige con finezza
braccia larghe, mani grosse
volteggiano sul coda, onda su onda
la voce si sente a stento, biascica
parole su parole, soffuse note
storie si intrecciano portentose
l’arte del bagarinaggio è morta
per sempre, si prenota solo online
ti schivano appestato dalla lebbra
il biglietto ormai è carta straccia
Appare lei una madonna
caucasica, capelli neri lisci
statuaria dal viso angelico
venuta apposta per ascoltare
il macaco astigiano dell’orchestrina
odalisca di felicità, siede sul palco
l’ammiro come fosse Giulietta
la serenata si riverbera in una milonga
torna fuori a fumare nella pausa
riaccende il fluido, miracolo estatico
nella desolazione accerchiante
c’inghiotte, e non torniamo più
*
Nel crepuscolo di addobbi silenti
barca adagiata sul molo viveronese
si avvicina la natività degli oppressi
oltre la morena innalzano nuovi detriti
strepitii sonori, effetti luminescenti
un cormorano si crogiola al Sole
ali spiegate ritto sulla roccia
come un lemure incanta serpenti
risparmia energie in contemplazione
l’inverno delle coscienze è alle porte
Stazione 11: abbandonato sulla croce
corpo dilaniato, anima a brandelli
ha salvato gli altri, non può salvare sé stesso
nel terrore di compiere un altro errore
dietro l’angolo, soluzioni per liberarlo
non gli interessa un cambiamento
giorni oscuri, sarà questo il suo destino?
*
Pervade una sensazione di pace
dal portone per una boccata
di fumo, si respira arte dei secoli
cielo gemmeo e metafisico
La vita nei quartieri italiani
un urlo nelle Luci della Città
tripudio di versi e suoni
reading da Trieste al Vesuvio
squarciavano notti messianiche
sotterranei di caves hip, perdizioni
Roma è arrivata ovunque
nel castello del dominatore asburgico
fucilato dal pennello d’esecuzione
bohémien rivoluzionario per odiata
definizione, escluso al Salon ufficiale
dal minuto e cinico imperatore
Reperti romani nella Valle di Toluca
oltre le Colonne d’Ercole il mondo
sconosciuto prima dei cacciatori asiatici
del grande navigatore colonialista
monumenti imbrattati, statue abbattute
piccole Italie culturali ecumeniche
culinarie prelibatezze di ristori
e mafie che fagocitano tutto

L’autore:
Valerio Vigliaturo, poeta, scrittore e cantante.
Ha pubblicato nel 2008 l’album “Il momento giusto” (Tomato Records/CNI music). Nel 2012 riprende la sua passione per il canto jazz, collaborando con i più importanti jazzisti torinesi ed esibendosi in concerti, festival, rassegne, come il Moncalieri Jazz Festival 2015 e il Torino Jazz Festival 2020.
Dal 2004 è direttore del Premio InediTO – Colline di Torino, punto di riferimento in Italia tra i concorsi letterari dedicati alle opere inedite.
“Dalla parte opposta” (Augh! Edizioni, 2018) è stato il suo primo romanzo con cui si è aggiudicato il Premio Carver 2018 e il Premio Nazionale di Poesia e Narrativa “Alda Merini” 2019 di Imola (BO).
“Amori & Disincanti” (Transeuropa Edizioni, 2020) è la sua prima raccolta poetica, che comprende poesie scritte tra il 2013 e il 2019, nonché quelle estrapolate dal romanzo inserite in una sezione dedicata.
Immagini ———————————
Pellegrino Parmense (Parma) 2023
Dieci fotografie
di Paolo Veneziani

Voce d’autore ———————————
Sei tu che sai vedermi da lontano
Sandro Pecchiari, “Alle spalle delle cose”
di Giovanni Fierro

Sandro Pecchiari ci ha sempre abituati ad uno stare fermo che è impossibile. Intenso nel vivere di ogni giorno, sincero nel mostrarsi nelle sue ferite, acuto nel mettere Tempo e tempi in dialogo, necessario nel trovare le parole più indicate da affidare alla sua poesia.
È figura di riferimento, per chi cerca nella scrittura la misura più prossima all’autenticità del dire.
E questo suo nuovo lavoro, “Alle spalle delle cose”, ne è ulteriore dimostrazione, ulteriore presenza nell’attenzione affidata alle parole.
“Ognuno nel proprio posto adatto/ chi nell’aria chi nel ripetere/ ogni atto/e crearsi inferni in proporzione”, è un passo importante, che ben tratteggia il fluire continuo di queste sue nuove pagine.
Luoghi e persone, accadimenti e rimanenze, dove – lo dice lo stesso Pecchiari nell’intervista che segue – “È sufficiente fermarsi per pochi secondi e farsi cogliere dalle ‘altre’ voci che ci circondano. Sono i Genius loci ai quali è dedicato il libro“.
“Alle spalle delle cose” è una mappa preziosa, che si muove nell’intimità quanto nelle coordinate geografiche, in un continuo viaggiare dove “siamo legati lungo la velocità/ alleggeriti della nostra carne”.
Ogni ricordo è un presente, una intensità che ritorna, che si ripresenta nel suo significato e nel suo vissuto, nuova occasione di lettura del sé, anche nel confronto più sincero, quando “dietro è una terra di nessuno/ sei tu che sai vedermi da lontano/ tu nella mia interezza/ e io la tua”.
Ecco, in questo libro nulla e nessuno è lontano. La distanza non esiste, è solo una dimensione percettiva che si trasforma continuamente in una prossimità, all’autore stesso e al suo scrivere, sempre più determinato nel trovare la radice più profonda: “qui si manifesta questo stare al mondo/ sentendo le giunture/ guardandosi alle spalle per capire/ dove saremmo veri”.
Se c’è una volontà, che si rende ancora più manifesta, di certo è il desiderio di trovare e riconoscere ogni possibile verità. Ma non come dato assoluto e incontrovertibile, ma come percezione del mondo, nel suo rivelarsi sempre più nel gesto acuto e palpitante, germoglio costante di stupore. Una appartenenza al vivere che fa scrivere Pecchiari di come Israel/Azrael sia “terra che attende e si rabbuia/ leccando il sudore/
e l’ombra”, portandolo a riconoscere che “non rispondo e non rispondi/ sperduti assieme nella reciproca mancanza”.
Sì, nelle pagine di “Alle spalle delle cose” è netta la sensazione che “lo sguardo entra all’incontrario/ e snida il cambio delle nuvole”; si muove di andata e ritorno, permette di guardare un paesaggio prezioso, costruito con il proprio vivere e sentire, in una trama che è volte si fa sottile ed in altre è più fitta e resistente.
Un tessuto spirituale dove si riconosce l’autore, che con il proprio fare poesia costruisce un ritratto di sé che trova il suo momento e il suo luogo, il suo genius loci che si mostra in una precisa immagine catturata nell’irripetibilità di un istante: “rotolando sassi nelle mareggiate/ un cuore che fugge assieme alle meduse”.

Dal libro:
Larice spogliante
sono un uomo per la sera
forse per una vita intera
forse, dipende
se mi estirpi l’ombra
se mi svelli da questo posto fermo
e mi trascini
ti strapperò le tende
e sporcherò il tappeto
e il letto, sappilo,
mi avvolgerò rugoso su di te
ti graffierò le parole con le mie
antiche che potresti non capire
tu sei così veloce –
hai pochi decenni
che vedo sparire con dolore –
ricordo i tuoi giochi attorno al tronco –
ora sei qui che mi inviti a casa
e la tua voce suona sempre amata
se accetto, porto con me il golfo
tutte le barche e i temporali
i nidi che proteggo
terrò anche te dentro i miei rami –
non ne sarai scontento
il fiume Timavo
*
Caesarea Marittima, Qaysariyah, Qisrin
la terra tra le dita
è caldo di scorpioni
ombra scabra nei palmeti
e vento steso sulla pelle
scoprirla e farla nuda
e scarna è stato lento
sminuire la città altera
in piatte simmetrie
il patto feroce
d’una smorfia contro il sole
uomini, cavalli e religioni
bassa forza ondeggiante
sul filo della costa
maniscalchi di vite e di rovine
ora esibisce i gangli
scoperti della storia
le scarse tracce d’esistenza
che ci spinge a brancolare
nella luce come ciechi
a godere degli avanzi masticati –
mendicanti di palazzo
Cesarea Marittima, Giudea
*
Canale
il cielo di voli di meduse
il cielo ha un bordo
il pelo d’acqua –
non si vive oltre nell’aria
non si respira la rarefazione
qui possiamo osservare
le ondate di marea
e di storie
ne immaginiamo in abbondanza
non si comprendono le barche
lassù in alto
immerse con la faccia dentro l’aria
ci chiediamo
come sanno vivere due vite
ma loro stanno sospese
nel silenzio
Canal Grande, Trieste
*
Mastello
cade e offre una semisfera d’aria –
per ogni tuffo
dentro lo zinco che risuona
privo di vestiti
senza pudore se contiene il cielo
l’acqua cela il silenzio degli uccelli
increspa le parole
genera un mare in miniatura
piove indifferentemente
tra i palmi e gli aghi delle foglie
nel colore perlato
delle navi al largo
con le barchette di carta se la cava
saranno pronte tra poco
ne sente le risa dentro casa
piove dovunque ancora
senza limiti
vorrei per sempre
il giardino dei vicini
*
Gabbeh
più pesante della vita
questo cadere nei sonniferi
e nell’alcool
finora ho sentito le tue scarpe
quelle degli amici
qualche volta i tuoi piedi nudi
ti ho guardato deporre le tue mura
i vestiti, la vita
non avevo mai toccato la tua pelle
gli anni se ne andavano
come gli acini dell’uva –
li staccavi senza grazia
mi fanno paura gli occhi così vuoti
come vivrò tenendoti caldo il corpo
il tuo separarti dalle ore
non ne sarei capace
– risparmiami
non andare –
Casa a Roiano

Intervista a Sandro Pecchiari:
Tutto il libro si muove non solo di pagina in pagina, ma di luogo in luogo, e con luoghi anche molto distanti tra di loro. Molto semplicemente, ma con grande tua intensità e sapiente senso dell’appartenenza, mi sembra che “Alle spalle delle cose” sia un vitale scrivere per creare vicinanza. Ti ci ritrovi (anche) in questo?
Per rispondere ho bisogno di un piccolo tuffo e di un piccolo corto circuito nelle reminiscenze: Gorgia, nei tanti esempi per la dimostrazione del non-essere, asseriva che non esisteva il rumore di una gran quantità di grano in caduta libera perché facendone cadere ogni singolo chicco non se ne percepiva alcun rumore.
Analogamente alcune teorie buddiste negano l’esistenza dell’io dimostrando che, siccome l’io non sta in alcuna delle nostre numerosissime parti del corpo, anche la somma non può che equivalere a zero. L’io (che percepisce e narra) è sicuramente debordante nella nostra cultura anche se è stato messo in discussione almeno a partire da Freud, ma, se lo si considera come un agglomerarsi e sovrapporsi mutevole e continuo, si riesce ad affermarlo e contemporaneamente a renderlo fluido e inafferrabile.
Quindi le persone e i luoghi più lontani, differenti e disparati sono ingredienti e componenti ineludibili di appartenenza.
Un amalgama armonico nelle somiglianze e contraddizioni, una vicinanza onnicomprensiva nella distanza.
Il tuo scrivere ha qui un fare quasi politico, di sicuro di significato sociale. Le tue parole e frasi sono un fare luogo, un riconoscere posti e provenienze, lontananze che una volta attraversate diventano prossimità. Può essere così?
Sono più che prossimità, direi che sono tutte parti vitali irrinunciabili. Il farsi luogo esplora un continuo fluire tra interno/i e esterno/i e tra tempi diversi. Quindi se ogni luogo ci forgia e ci modifica, si annullano la lontananza, l’asse spazio-temporale e la non appartenenza.
E quindi, ti chiedo, che geografia hai costruito?
La geografia che ne consegue è una specie di percezione ricostruita, sto pensando a Boccioni come riferimento immediato, luoghi come forme uniche della continuità nello spazio, sempre in movimento e fluidità. Una percezione globale liberata. La percezione quindi nota e interiorizza ogni aspetto visibile e non visibile degli accadimenti e ne entra in confronto.
In tempi di muri e nuovi confini, “Alle spalle delle cose” è un vero e proprio inno ed elogio del viaggiare. E tutto questo assieme mi sembra che sia anche la radice più profonda del fare poesia. Mi sbaglio?
Tabucchi in uno dei suoi esergo dice che si è “costretti a lunghi viaggi per vedere”. Quali sono però i percorsi da definire e organizzare? Meglio forse un percorso senza percorso che lasci la porta aperta a percezioni stupefatte. E un percorso di sovrapposizioni, un percorso “infrasottile” come esemplificato da Elio Grazioli: l’arte in generale, e in questo caso la scrittura, come “capacità dell’artista di vedere e di mostrare diversamente la realtà, viaggiando in ciò che è all’estremo della percezione, del discernibile, della differenza, ma senza essere né l’invisibile, né l’indiscernibile, né il trascendente, ma invece una presenza al limite, un possibile ma reale, o una compresenza di due stati che ‘si sposano’, dice Duchamp, dando vita a un terzo tutto da cogliere”.
È un percorso particolare, fatto invece di affinità, di atteggiamento, di sensibilità e di pensiero, scrivere ai limiti della percezione. Non un “tertium non datur”, ma al contrario un rassicurante “tertium datur”.

Questo tuo rinnovato scrivere è ancora più articolato e necessario. È molto bello accorgersi che in questo tuo raccontare i corpi si fanno paesaggio e i paesaggi si fanno corpo. Era una idea di base, esplorarli ed esporli in questo modo? O fa tutto parte del naturale processo di scrittura?
Dante diceva che “trasumanar significar per verba non si porìa”. Certo non possediamo l’erba assaggiata da Glauco nel Paradiso, che l’aveva divinizzato. Invece, a livello umano, è proprio la scrittura che ha il preciso scopo di reinventare punti di vista e rincorrerli con le parole, spostandole in un altro punto di osservazione e di focalizzazione.
Il tuo continuo trasformare i confini in frontiera, e quindi ogni limite in un respiro profondo ed ampio, si manifesta in vari modi. Ad esempio c’è in tutto il libro un continuo alternarsi di interni ed esterni, pur preservando una intimità che nutre ogni cosa che scrivi. Cosa vuol dire questo nell’identità poetica, ma non solo, di “Alle spalle delle cose”?
È vero, come abbiamo detto prima, con un extra ampliamento: l’intimità scaturisce dal mettermi da parte come io narrante e io onnisciente e lasciarmi diventare solo attento osservatore delle epifanie inaspettate che si creano.
Il libro è nato proprio dal corto circuito di due avvenimenti del tutto scollegati tra di loro:
L’aver visto per puro caso il coreografo Travis Wall con l’esibizione di Robert e il giovane J.T, nel talent “So You Think You Can Dance” del 2016. Nel balletto un finto specchio separa i due mentre eseguono movimenti speculari, in simbiosi: può essere l’uomo che si vede riflesso bambino, o il ragazzino che si immagina da grande. Ma quello che mi ha fatto trasalire è il momento inaspettato in cui il ballerino adulto afferra per le mani il bambino e lo porta al di qua dello specchio.
Questo ricordo si sovrappone immediatamente all’assembramento dei tanti triestini affollati sul Ponte Curto, guardando e commentando l’invasione delle meduse nel porto di Trieste fino dentro al Canal Grande dello scorso anno e anche parzialmente di quest’anno. Meduse tanto numerose da sembrare nuvole di un cielo subacqueo.
Il poter passare da un’altra parte ha capovolto la prospettiva e il punto di vista. Ha ribaltato la prospettiva frontale per aprirsi alla massima significazione di ogni incontro e di ogni luogo attraversato.
Così, come dice Monica Guerra nella postfazione, l’intera lettura del mondo circostante si apre a ingressi secondari, scava tunnel di senso nella memoria. Inoltre vuole essere un’esortazione alla sacra pratica del dubbio su ciò che è dato per certo, un acuirsi dello sguardo sino all’individuazione delle “giunture mal celate”, al di là della gabbia di ogni presunta – e sempre soggettiva – pennellata di verità.
E poi questo titolo, “Alle spalle delle cose”, ce lo racconti, ce lo spieghi?
Stare alle spalle significa proprio lo sbalestramento del punto di vista e la parziale eliminazione dell’io narrante a favore di una narrazione che nasce dalle cose stesse.
Questa raccolta fa i conti sulla capacità dei luoghi, cose, strade, edifici, alberi, di narrare sé stessi, prescindendo dall’io narrante dell’autore. Raccolta in cui il punto di vista non è più quella dello scrivente/io narrante/: una, per così dire,“lirica delle cose stesse”.
Chi scrive quindi è solo un “osservatore in sintonia” e ferma nella pagina queste frazioni di secondo che di solito non si colgono nel nostro correre quotidiano. È sufficiente fermarsi per pochi secondi e farsi cogliere dalle ‘altre’ voci che ci circondano. Sono i Genius loci (ai quali è dedicato il libro), i kami 神, le divinità dei luoghi, i Penati degli affetti familiari, i Lari che sono presenti sempre e comunque negli spostamenti e traslochi.
Questo osservare/osservarsi diviene emblema dello sforzo necessario a qualsiasi moto di connessione, di decodifica e di intuizione del mondo dell’altro e dell’incommensurabile valore che da questo processo può scaturire.
È quindi saper riconoscere cosa sta dietro l’apparenza “ufficiale”, nei camerini del teatro della realtà, dove ci si strucca, le indecisioni, scrostature e inaspettate sorprese e meraviglie spostandosi a lato.
In questo scollamento nascono le storie inaspettate. Nascono gli alberi che vogliono seguirci a casa, i cieli dove le meduse sono le nuvole di un mondo subacqueo, dove più ci si avvicina più ci si allontana, ma fortunatamente anche viceversa. Quanto più lontani ci si pone tanto più si viene coinvolti nel percorso della scrittura.
“Alle spalle delle cose” vive anche delle immagini contenute nelle sue pagine…
Le fotografie di Paolo Ugolini e Daniela Alpi si affiancano alle poesie, le completano come sostegno visivo, le definiscono e contemporaneamente non le definiscono, in perfetta sintonia con il libro.

L’autore:
Sandro Pecchiari, triestino, laureato in lingue e letterature straniere con una tesi sull’opera poetica di Ted Hughes, ha pubblicato le raccolte “Verdi Anni” 2012, “Le Svelte Radici” 2013, “L’Imperfezione del Diluvio – An Unrehearsed Flood” 2015 e il lavoro antologico “Scripta Non Manent” 2018, per la casa Editrice Samuele Editore, Fanna, Italia.
Inoltre in spagnolo “Le Svelte Radici”, con il titolo “Despojando Raíces” e la silloge in inglese “Kidhood” nello Special Issue, Writing in a Different Language, NeMLA, Italian Studies, The College of New Jersey, USA.
Presente in antologie e riviste in diverse lingue straniere, nel “Quarto Repertorio della poesia italiana contemporanea” Arcipelago Itaca 2020, con cui pubblica anche la raccolta “Desunt Nonnulla (piccole omissioni)”.
Collabora con diversi artisti italiani e stranieri. Si interessa ai video poetry tra Stati Uniti e Canada, con Erica Goss, videomaker statunitense e Al Rempel, poeta canadese, nel video “I’ve in the Rain”, finalista al Zebra Poetry Film, Berlino e al Ó Bhéal International Film Competition, Cork, Irlanda.
Attualmente collabora alla sezione Traduzione del sito QB – Quanto Basta dell’Independent Poetry di Faenza, con la rivista Graphie di Cesena e il blog Versante Ripido di Bologna.
Scrive saltuariamente anche per Il Ponterosso di Trieste e per Fare Voci di Gorizia.
Il libro “Alle spalle delle cose“, già presentato a Trieste, al castello di Duino, a Cervignano, Visco, Gorizia e Bologna, sarà a Firenze il 27 maggio p.v. alla Biblioteca delle Oblate, con una breve presentazione di Andrea Sirotti e in dialogo con Monica Guerra e con i fotografi che hanno fornito le immagini.
(Sandro Pecchiari “Alle spalle delle cose” pp. 84, 15 euro, Vita Activa Nuova 2023)
Immagini ———————————
Stomboli (Piacenza) 2023
Dieci fotografie
di Paolo Veneziani

Ti racconto ————————
DC9
Un racconto inedito
di Emiliano Sabadello

A Roberto Bolaño
1. È una serata splendida, come forse soltanto la fine del mese di giugno può regalare. 2. Un aereo solca i cieli, lasciando la sua scia invisibile all’occhio umano, non così ai radar. 3. Gli occhi dei radar non si sa se siano altrettanto vigili di quelli degli uomini, stasera, perché forse anche gli occhi dei radar possono avere delle distrazioni, delle bellezze meccaniche oppure elettroniche che gli possono oscurare il normale funzionamento. 4. È come la questione se gli androidi sognino oppure no pecore elettriche. 5. Passa qualche istante, e rumori di altri aerei, sono almeno due, rumori forti e assordanti, vanno ad accodarsi a quello dell’aereo appena passato. 6. È un giorno di vacanza, o quasi, e molti stanno tornando a casa, alla faccia di chi invece non se lo può permettere e ha deciso di restare dove si trova. 7. Si sentono i grilli, perché l’estate, quella vera, non quella da calendario, è incipiente, anche se la sera è ancora fresco, la sera non si può stare senza qualcosa sulle spalle, soprattutto qui, al mare. 8. Quando passa il primo aereo, anche se non troppo vicino, il frinire dei grilli viene coperto, poi torna a farsi sentire, comunque ininterrotto a chi abbia ancora un super udito, poi sparisce di nuovo, quando passano gli altri due aerei, molto più rumorosi, molto più aggressivi. 9. Ci sono tante persone che hanno deciso di farsi una passeggiata sul lungomare, o anche sulla battigia, staccando da quelle che sono le loro vite moderne, che sentono in parte ancora attaccate a quello che erano, ma che intuiscono come in via di cambiamento, insieme alla realtà, alla storia, insieme al resto del mondo. 10. D’altronde, è venerdì sera e anche se qualcuno domani andrà a lavorare, la serata è troppo bella per lasciarla scivolare davanti alla televisione, ignobile, inumana, irricordabile. 11. Un bambino francese è tra le persone che sono qui questa sera, un po’ staccato rispetto agli altri, anche se può essere soltanto il riflesso della sua estraneità linguistica. 12. Vede arrivare l’aereo nel suo campo visivo e socchiude gli occhi, come per mettere a fuoco un obiettivo. 13. Non è da solo, il bambino francese, anche se il gruppo del quale sembra far parte non parla tutto la sua stessa lingua. 14. Anzi, non sembrano parlare affatto, come immersi in una meditazione di gruppo o come intenti in qualche manovra difficilissima, che se non effettuata al bacio, causerà spiacevoli strascichi e lascerà pericolose tracce. 15. Il bambino francese, visto adesso da un’angolatura leggermente differente, sembra il vertice di una piramide, come se avesse dietro di sé un’orda di scienziati con gli occhiali schermati, in attesa dello scoppio nucleare incipiente. 16. L’aereo, il primo, è arrivato adesso quasi sulla linea retta del vertice della piramide. 17. Il bambino alza il braccio destro, con un movimento a metà fra il meccanico e l’elegante, e lo ferma davanti a sé, giusto poco più in alto della linea dei suoi occhi. Porta medio anulare e mignolo al palmo e si ferma per un istante, in contemplazione della pistola che ha appena creato. Curva l’indice verso le altre dita, lui spara in questo modo, al modo dei killer e dei mercenari, e si ferma, aspettando il momento giusto. 18. Manca soltanto un fotogramma, al momento giusto. 19. L’aereo è adesso in mezzo al mirino immaginario. Il bambino finisce di curvare l’indice verso il palmo e nel momento esatto in cui lo tocca, che è anche il momento in cui l’aereo è perfettamente davanti a lui e a tutto ciò, in questo momento il bambino emette un rumore con la bocca, bbbsssccc, lasciando poi la scena in silenzio, e sospesa. 20. L’attenzione delle altre persone che sono con lui è adesso massima, senza respiro. 21. Il silenzio dura neanche un battito di ciglia, perché l’aereo viene colpito dal colpo del bambino, ed esplode, troncandosi in due ineguali lingue di fuoco e finendo in poco tempo inghiottito dal mare. 22. L’immobilismo che sembrava aver colpito il gruppo del bambino si dissolve insieme alle vite dei passeggeri dell’aereo e in pochissimi secondi, non c’è più nessuno da quella parte della spiaggia. 23. Tutti spariti, nessuna traccia, qualche indizio, ma con il tempo sparirà anche quello. 24. Perché, forse, non c’è mai stato nessuno da quella parte della spiaggia, non c’è mai stato nessun bambino viziato francese che ha voluto far vedere di che pasta fosse fatta la sua invenzione, la pistola mentale, né una specie di piramide fatta da chi voleva assistere alla sua dimostrazione. E forse non ci sono stati mai neanche i due aerei supplementari lassù. 25. Forse non ci sono neanche i morti, ci sono soltanto i numeri. Freddi.

L’autore:
Emiliano Sabadello (Roma, 1974), è docente di ruolo di filosofia e storia al liceo classico Claudio Eliano di Palestrina, dopo aver insegnato per alcuni anni letteratura italiana e storia.
Ha all’attivo diverse pubblicazioni fra narrativa, saggistica e satira, fra le quali ci sono: “Pennywise”, un saggio su “It” di Stephen King, edito da Toutcourt edizioni; “Il male maggiore. Stephen King e la violenza contro le donne”, edito da Alter Ego edizioni; “Il denaro e le sue forme. Teorie del denaro in Marx”, edito da Il Rovescio editore; “In un mondo che crolla. L’originario, la terra e ciò che resta dello Stato-Nazione. Heidegger e Pasolini”, edito da Odradek edizioni.
Ha curato, inoltre, un’edizione di alcuni racconti di H.G.Wells, “Racconti della prima fantascienza”, editi da Alter Ego edizioni.
Ha partecipato a volumi collettivi quali: “Spinoza. Un libro serissimo”, edito da Aliberti e “Almanacco Luttazzi della nuova satira italiana 2010”, edito da Feltrinelli.
Collabora con le riviste letterarie Il corsaronero, La nota del traduttore, Morel – Voci dall’isola e Grado Zero.
Immagini ———————————
Firenze 2023
Dieci fotografie
di Paolo Veneziani

Margini. Di poesia ed altro ————————
Quando però non accade
Alberto Fraccacreta, “Del tutto diversi”
di Roberto Lamantea

L’amore è una città, e la città è un teatro. Una città di pietra antica e di pendii, ciottoli e torri, portici, fughe dello sguardo; e i boschi, le colline, i cieli. L’Università con i suoi portoni, corridoi, stanze; i collegi. I bar, i tavolini all’aperto, jazz New Orleans. La pioggia come un quadro pointilliste. Il trolley sull’acciottolato, addii mascherati da quel “ci vediamo” che è uno schiaffo. I treni persi (“saranno proprio i treni persi/ a farci incontrare”). Quando i tuoi vent’anni si allontanano anche nel ricordo, e quando ci ripensi ti accorgi che sono stati gli anni più felici della tua vita ma non lo sapevi.
Delia, Flaca, Cordelia sono i nomi femminili di quei dolci fantasmi; Delia traspare già nei primi due libri di Alberto Fraccacreta, “Uscire dalle mura” (2012) e “Basso Impero” (2016).
L’ultima silloge del poeta pugliese “adottato” da Urbino, “Del tutto diversi”, edito da Interno Poesia, è un canzoniere alla rovescia tessuto in una trama stilistica raffinata – da Luzi e Montale agli spagnoli, Dante, Cavalcanti, la lirica del Duecento rovesciata in “amor scortese” come nella poesia di p. 49.
In questo diario amoroso c’è la freschezza degli incontri anche quando si tratta di rinvii, indecisioni, glissements. C’è perfino il profumo dell’aria in questi versi, i puntini di pioggia, le prospettive dei portici e il ghiaino delle strade, il trascolorare della luce, “l’attesa e l’oblio” alla Blanchot che ricordano un libro stupendo, purtroppo mai ristampato, “Vigilia del piacere” di Pedro Salinas, offerto da Einaudi nel 1976 nella traduzione di Cesare Greppi e oggi introvabile.
Protagonista del libro è anche Urbino, la Urbino ventosa di Pascoli, quella dell’Aquilone, la Urbino di Umberto Piersanti e delle Cesane. Ed è la vita universitaria a fare da cornice alla danza d’amore; chi dice io – il poeta stesso, il suo alter ego, il suo fantasma – dà al libro la tonalità di un romanzo in versi.
Va da sé che il tessuto linguistico e ritmico è coltissimo: dall’intreccio tra botanica e linguistica (il mirabile “Orto botanico: strambotto” di p. 32) all’incantevole citazione dantesca di p. 47: “Potessi dire ai passanti vede/ perfettamente ogni salvezza/ chi la mia donna tra le donne vede./ Ma non ti volti e la realtà/ non muta i suoi piani.// O questo crede”, alla Szymborska fino a un omaggio alla “sabbia pulviscolare della parola” di Gadda. Ma qui siamo sul piano del divertimento colto, indagato da Elio Grasso nella prefazione. La bellezza di questo libro è nella delicatezza con cui Fraccacreta scrive – a volte parlando di sé in terza persona – il suo diario amoroso. Versi perfetti anche nel registro narrativo: “Era ormai buio, la notte sedeva nei posti vuoti delle panchine./ Lui si sentiva e, lo confessò più tardi, ancora si sente/ come uno a cui sembra che il mondo stesso stia tramontando/ e sia rimasta solo tu”.
È come se, in questo libro, presenza e assenza siano la stessa cosa, l’addio non ha i malinconici ori dell’autunno ma è il canto di una continua inafferrabilità: “ti chiedo perdono/ per il non vissuto insieme,/ per le assenze che saranno,/ le mancate essenze”.
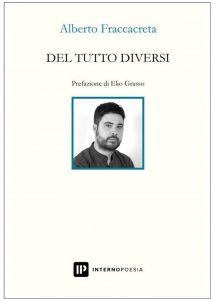
Dal libro:
Il platano di via Valerio
Se credi di entrare contro il flusso delle foglie
sulla soglia del giardino, quando febbraio
finge di rinverdirsi e coltiva nuovo gelo,
perché casualmente passasti
e non avevi altra strada,
per favore non bussare,
non essere tu.
Se ritieni di non avere presenza di spirito
e vuoi colmare i vuoti con il becco
scaltro del martin pescatore
che acciuffa di netto la preda
perché vuole esibire il bel piumaggio,
per favore non afferrarmi,
non essere tu.
Di questa esistenza non vediamo
che lo specchio deformato,
una tela ricamata e non ultimata
agli orli, non riusciamo
a scorgere il male che ci sorprende
come il vento sui vicoli ciechi
del non essere noi.
E se invece, nel guardarmi passare,
ti ha preso quel senso di distacco
da cui è colta la persona
che ha camminato per anni
separata da sé e adesso si ritrova,
allora te ne prego férmati,
cerca di essere tu.
*
I nostri incontri mancati
Esco spesso dallo studiolo
annidato in cima per incrociarti.
Scendo scale con il pretesto
di fotocopie o di stampe.
Seguo numerosi tragitti e piste,
indovinando le ore di passaggio
o sorprendendo talora i momenti di pausa –
stimolato dallo stuolo di storni,
dal volo irrequieto del cardellino.
La selva di vie gobbute
indica dorsi dove forse stai per passare.
Da ultimo, quando l’intuizione accade,
il respiro si ferma, mi guardi confusa
in un sorriso a tratti irretito,
a tratti beffardo. Vorrei
essere e non essere lì.
A pensarlo, in un breve battito
d’ali mi hai già superato.
Quando però non accade,
quando l’appuntamento è perso
e il gioco è elevato e lontano,
perché ho ritardato di una frazione
di secondo, vorrei soltanto essere
nel tuo non luogo di adesso,
nel non possesso che abiti
da qualche parte e non posso vedere.
Per favore, incrociami tu
dove non sono.
*
Highliner
Puntini di pioggia rigano l’aria
con la nebbia fumida che sale
come una signora sui tacchi
e s’impania ai bordi. Ti aspetto
sotto il portico del duomo, arrivi.
L’allucciolio
del tuo sorriso lieto sfiaccola
fin da sotto, da sotto
le statue severe, muschiate
mentre lampi di visioni di giovani ragazze
hanno anticipato
la tua venuta, ora avverata, ora già
capace di strinare le perplessità,
le piccole e miserabili guerre psicologiche,
ora ti sei già pienamente corrusca
e la foschia interiore dissolta.
Stretti nell’ombrello
giriamo per via Santa Chiara, intenti
a entrare furtivamente nell’università
o a trovare riparo tra le grondaie
con i capelli che ti s’imperlano e inzuccano
come la regina azteca di Michtlán
e la matita per gli occhi comincia sulle tempie
a emettere segni sottili simili alle tante
vocali accentate di sostantivi messicani.
Ti spiego maldestramente
tra occulte citazioni
le presidenziali americane, i grandi elettori,
le percentuali crescenti, il decisivo Nevada –
il tuo highliner intanto sborda, sporge, straripa
nel bigio ruscello
dell’accordarsi dei caratteri, nel fragoroso Mississippi
del nostro concederci,
il tuo highliner che sembra
avvolgere giulivo ormai tutta la città
e in piena comincia a esondare,
a sradicare le cimose di ogni prudenza, travolgerci
abbattendo argini di saggia salvaguardia,
per entrare infine impetuoso e vittorioso nella meno saggia
consapevolezza di iniziare a volersi bene,
di pensare per calcolo o per sbaglio
di restare insieme.

L’autore:
Alberto Fraccacreta è nato a San Severo (Foggia) nel 1989. È dottore di ricerca all’Università Carlo Bo di Urbino. Scrive recensioni e interviste per Alias, il manifesto e Avvenire.
Ha pubblicato, per Raffaelli editore, le sillogi “Uscire dalle mura” (finalista Camaiore Giovani 2012), dedicato alla città marchigiana, e “Basso Impero” (2016), poi raccolte in “Sine macula. Poesie 2007-2019” (Transeuropa 2020).
Sempre per Raffaelli ha curato il cofanetto con poesie di Adam Zagajewski “Il fuoco eracliteo nel giardino d’inverno” (2017) e, per Carocci, “Tradurre per la scena. Aulularia di Plauto” (2017).
Ha pubblicato i saggi “Fisica della parola pura. Il viaggio terrestre e celeste di Simone Martini” su Mario Luzi (Aracne 2017), “Montale errante. Cronache di una tensione religiosa” (Loffredo 2018), “Italo Svevo. Una comunicazione interrotta. Lettura di ‘Senilità’” (Studium Edizioni 2022).
Ha inoltre curato “Un segno indecifrabile (Meditazioni su Claudel)” di Carlo Bo (Succedeoggi Libri 2021).
(Alberto Fraccacreta “Del tutto diversi”, prefazione di Elio Grasso, pp. 140, 15 euro, Interno Poesia 2023)
Immagini ———————————
Sant’Agata (Piacenze) 2023
Dieci fotografie
di Paolo Veneziani

Voce d’autore —————————-
Bisogna aver la natura di chi resta
Valeria Raimondi, “Il penultimo giorno”
di Giovanni Fierro

La perdita, lo smarrimento, la ridefinizione di sé. Questi i punti focali, di un prendersi cura che poi diventa forza ed orientamento, passo successivo nello stare in una identità ancora più aderente a nuovi bisogni e desideri.
Si muove in questi ambienti personali e delicati, a volte dolorosi, il più recente libro di Valeria Raimondi, “Il penultimo giorno”.
Accompagnare una persona destinata a mancare, quando la vita trova le ultime misure, “Non potevo fare altro che contare:/ quante gocce/ quanti minuti/ le dosi, i milligrammi/ il tempo delle visite/ l’orario della cena”; in una abitudine destinata a consumarsi, a lasciare il vuoto.
E forse tutto “Il penultimo giorno” è proprio questo misurare l’assenza per misurare la vicinanza. Perché Valeria Raimondi in queste sue poesie si racconta, si mostra, rinuncia al riparo: “Potessi riparare le parole,/ vedere come è pieno questo vuoto,/ potessi allinearti un po’ le ossa/ per ricontare parte delle mie!”, che è una profonda ammissione di umanità, e una dichiarazione di poetica.
Ma “Il penultimo giorno” è anche un invito a fermarsi un attimo prima, in quel frangente in cui si vuole credere che tutto sia ancora possibile, anche la guarigione. Sono la tensione e il desiderio di aggrapparsi alla vita, anche se si sa bene che “Questo dolore grigio/ opaca gli astri/ affonda i cieli/ rovescia anche l’ultima parola”.
Non è mai un arrendersi, ma un accettare. Anche lo smarrimento che nasce dall’affetto tagliato via, dal respiro a cui si apparteneva, “Da parte di madre la scorza/ del padre la tenerezza inquieta/ delle nonne la preveggenza/ il melodramma, il copione ripetuto.// Tutti i preziosi gioielli di famiglia”, luogo dove “Vado cercando l’altra che son io/ per dire se ancora un poco mi somiglia”.
Perché poi ci si deve ricostruire, ridefinirsi in relazione alla scomparsa, trovare il nuovo proprio ritratto nella cornice del quotidiano.
Anche se il confronto rimane, ancora più profondo, per nulla cicatrizzato, sempre pronto per fare nuovamente male: “Talvolta mi nascondo dentro il sonno/ nell’umida gestazione dei raccolti/ e lì sei tu che vieni ad incontrarmi/ per nominare uno ad uno i miei dolori”.
È però un nuovo affermare il proprio essere, “anch’io dentro il paesaggio complessivo/ prendo per me il diritto di restare“.
“Il penultimo giorno” ha forza e determinazione, Valerio Raimondi trova la naturale essenza dello stare al mondo, dove quel “Voglio una vita da fiore/ un cuore di cane/ un fiuto selvaggio” è testamento di vita, promessa riuscita, perché “domani è un altro giorno intero”. Nonostante tutto.

Dal libro:
Per dono
In questi giorni bianchi, tremendi e dolci,
nelle ore dilatate di una piccola vita ancora piena,
in questa ultima culla
ogni gesto si fa intero,
le parole stanno al loro posto e l’atto, il rito ripetuto,
nasce di volta in volta nuovo.
Il dolore ha un gusto dolce, delicato.
In questo tempo verticale tu torni indietro,
ti riavvolgi, quasi scompari tra pieghe di lenzuola.
Ci chiedi scusa.
Noi diventiamo grandi all’improvviso,
abbiamo braccia sane e schiene
solo un poco appesantite.
Sono grata al mio lavoro:
un cuscino morbido alla testa, l’altro
a riempire l’incavo dei lombi sempre più scavato.
Tu lasci fare e ascolti incredula la tua voce nuova,
ma non è nuova, è solo quella di bambina.
Sì, il comodino è in ordine, la coperta ben piegata,
sì sei pettinata.
Tu lasci fare.
Ci perdoniamo tutto, interamente o in parte,
oggi sappiamo farlo.
Ti lasceremo andare, lo prometto,
ma ora siamo qui, restiamo ancora un poco insieme.
*
Ti resto accanto
anche oggi che vesto il lutto
anche nella resurrezione
anche nelle ossa ti tengo
nel passo claudicante
nell’anca che trattiene
nel respiro privo di intenzione
nelle intenzioni prive di ragione
per il poco e molto che sei stata
per il molto e troppo che ti ho amata
per le briciole di pane e l’acqua fresca
nutrimento ultimo che sfama
*
Sei tu, sono io, siamo noi.
Presenze ormai assenti ai rispettivi sguardi
assenti al pensiero, al gesto, all’altrui.
Assenti nel paesaggio a tinte forti.
In odore di allori bruciati.
Solo una scia lasciamo
uno sguardo sgomento
e alle spalle una strada.
*
Servirà infine contare tutti i passi,
soppesare di ogni tappa la fatica,
sommare slanci, cadute, aspirazioni,
arrotondare per difetto i pro e i contro,
considerare le varianti, valutare?
Non ne uscirà un preciso resoconto,
quello che tira la somma col righello,
niente prova del nove al risultato,
nessun resto sul calcolo finale.
Perché in fondo salteranno tutti i piani,
gli obiettivi, le algebre, i bilanci.
Resterà un po’ di musica a guidare
l’andare necessario e libero al contempo.
Servirà una vita intera (prendere o lasciare)
serviranno gioie piccole e l’ardire
di non sacrificare allo stupore, meraviglia,
la meraviglia di non avere niente da contare.

Intervista a Valeria Raimondi:
Queste pagine hanno a che fare, fin dall’inizio, con il prendersi cura, e con una assenza che accade e che consegna alla vita un legame ancora più forte. In “Il penultimo giorno”, misurare l’assenza è misurare la vicinanza?
Le tematiche relative alla cura credo mi appartengono, in parte per la mia esperienza professionale rivolta all’assistenza e cura dell’altro/altra, in parte perché lì va a battere il dente della mia poetica. Alcuni anni fa scrissi un piccolo manifesto, “La poesia non ci salverà”, rivendicando la possibilità della cura attraverso l’arte ma anche il rifiuto della normalizzazione; nella mia prima raccolta, “IO NO, ex-io”, indagavo invece una condizione patologica, estrema, senza prevedere una cura ma consentendole il diritto di essere rappresentata. In questa mia ultima silloge si svela forse l’altra faccia della medaglia: il prendersi cura dell’altro è evidente dal primo testo, “Per dono”, e coinvolge chi assiste e chi è assistito in un tempo di attesa.
L’assenza qui accade, come tu giustamente sottolinei, ma non si esaurisce in un lungo penultimo giorno, bensì misura le distanze del passato, o meglio le rimisura, offrendo possibilità di una rielaborazione. Ciò avviene grazie alla riscoperta della relazione figlia-madre nel momento drammatico del fine-vita.
Misurare l’assenza è misurare la vicinanza? Certamente. Il nastro della vita dell’altra si riavvolge, i ruoli si invertono, ci si incontra “in questo mezzo metro… nell’ultimo passaggio di frontiera”, nell’”ultima culla”, nell’”andare verso un utero al contrario”. Credo si tratti di un canto del passaggio dove il tempo si ferma proprio sull’orlo del precipizio.
Tutto il vivere de “Il penultimo giorno” mi sembra sia il desiderio di creare un territorio emotivo a cui appartenere, e a cui dare fiducia. È (anche) così?
Un territorio emotivo a cui appartenere, direi da cui partire, può essere una buona occasione: è possibile, come già dicevo, rileggere il passato (la fragilità di chi è nella malattia trasformerà il sé dell’”altra che sono io”).
Il tempo emotivo della prima sezione, intitolata proprio “Il penultimo giorno”, rimanda ai percorsi personali della seconda, “l’Abisso”, a quando della vera storia si perde il filo. Ma poi bisogna ritrovarlo, uscire dal territorio emotivo, riemergere un po’ più lucidi, meno fedeli ad un copione ripetuto, appena un poco distanti dall’emozione originaria.
Ciò consente un respiro, un “Ritorno”; ho intitolato così, quasi paradossalmente, l’ultima sezione che guarda al futuro, dove “caduta e volo sono coincidenti” e “servirà una vita intera (prendere o lasciare)“. Come spesso ripeto, nella poesia il poter dire non appartiene allo spontaneismo ma piuttosto ad un’autenticità che si può cercare vicino all’origine del pensiero, dell’idea-ispirazione, dell’emozione.
Ma prima, in senso generativo, viene il pensiero, l’idea, l’emozione.
Il libro colpisce già dal titolo. Perché “Il penultimo giorno” è anche un invito a fermarsi un attimo prima, a stare nel momento in cui tutto ancora è possibile. Ti ritrovi in questo?
Completamente d’accordo. Ma definirei meglio: nel tempo di questo lungo penultimo giorno tutto è ancora possibile e ciò che non si può vivere realmente (visto che nella malattia i contorni dei tempi quotidiani sono soggetti a una distorsione soggettiva) può essere scritto e fermato per un attimo, può essere dilatato; non sai come sarà l’indomani tuttavia speri che sorga nuovamente come il penultimo giorno (e non l’ultimo). “Stare” nel momento è un tentativo, l’unico possibile nel tempo scandito dal dolore.
Il tempo poi evolverà, rallenterà, si dilaterà nella ciclicità: dopo aver attraversato la dissolvenza di un’esistenza, consentirà la rinascita, ma sempre restando “nel mistero dell’impermanenza”.
“Il penultimo giorno”, “L’abisso” e “Il ritorno” sono, secondo i miei intenti, coordinate sia contenutistiche che formali.

E in questo tuo scrivere, la poesia diventa relazione e confronto. È da qui che si deve iniziare per preparare una raccolta di testi che possa affrontare il mare aperto di ogni possibile altrui lettura?
Certamente ogni altrui lettura oltre che possibile è auspicabile. Ogni altrui lettura è una relazione, mette in comune sentimenti e idee, sempre che parlare partendo da sé trovi la forma giusta, quella che consente di identificarsi ma anche di tradurre altro.
Se il compito del poeta è dire la verità questo non significa necessariamente raccontare fatti “realmente” accaduti quanto invece esprimere testi autentici sulla condizione umana.
Credo, per quanto mi riguarda, di aver sempre rifiutato l’etichetta di poesia politica, civile, sociale preferendo la definizione di poesia attenta all’umano, di vicinanza a tutto quello che ad esso non è estraneo.
A tal proposito, mi ha molto colpita e commossa la richiesta di un’amica di avere una copia del libro per donarla a chi stava accompagnando il fine-vita di una persona cara: “leggi questo libro, può addolcire il dolore, contiene le parole che cercavi e non riesci a dire“. Ecco, semplicemente così.
Nella sezione “L’abisso” c’è uno smarrimento che da subito si rivela necessario. Ha un suo tempo e un suo orizzonte. Quanto è costato, in termini di intensità emotiva, l’affrontarlo e il documentarlo?
Lo smarrimento della seconda sezione, “L’abisso”, come tu osservi, la caratterizza quale corpus con un proprio tempo e dimensione. Ho potuto affrontare tale smarrimento solo inserendolo al centro della silloge, in un certo senso proteggendolo.
Per questo non ho usato un ordine logico nella sequenza temporale delle tre sezioni: il passato segue e non precede il presente della prima sezione. Trattare e documentare certe tematiche mi è molto costato in termini emotivi, non è stata una scelta facile, ma credo che questo gruppo di liriche così dure abbia trovato il suo posto.
Vorrei anche sottolineare che anche qui continua ad emergere la presenza a specchio dell’altro/altra che è presenza tanto introspettiva quanto materica.
Il testo che apre la sezione seconda, “L’abisso” si radica, infatti, anche nella carne: “Vado cantando l’elegia di carne…”
E in queste pagine il tuo io viene fuori con maggiore determinazione, a dire che l’arrendersi non fa per te….
Non so se sono in grado di rispondere. Diciamo che nella terza sezione, “Il ritorno”, c’è l’idea di non arrendersi: il presente dopo la rilettura del passato può consentire di immaginare e costruire un futuro inteso come tornare a casa, ad una dimensione più autentica che vuole sottrarsi a un destino predefinito. Queste tre sezioni potrebbero essere tre stadi o fasi dove gli elementi sono quelli della ciclicità e della caduta, ma non dell’azzeramento.
Mi chiedo sempre cosa significhi partire dall’io per avventurarsi nella poesia. Rispondo che niente può dirsi davvero oggettivo, neutrale: ci si porta sempre dentro ciò che si esprime (vale per la produzione poetica ma vale anche per altre forme d’arte o di scrittura) con tutti/tutte sé stessi/e, con anima e corpo.
Tutto “Il penultimo giorno” è aggrappato alla vita…..
Certamente. In questi nostri tempi, dove pare tutto sia non solo frammentato ma anche perduto (nello sperdimento del tempo sulla terra), la vita infine vince sempre, vince l’amore, vince la relazione. Ai poeti spetta il compito ingrato di farsi carico del dolore, “primo grande insegnamento” e di viverlo intensamente perché la poesia si faccia vita, vita presa per intero con il suo carico di sofferenza e felicità, penetrata con passione e un po’ di consapevolezza.
La coscienza della fine del tempo esalta il vero e l’assoluto della vita, così che “ogni gesto si fa intero”. Sappiamo poi che quando si scrive si è liberi, si vive in una zona franca e si può dirottare la parola: “ciò che si perde in vita si guadagna in poesia“, mi pare di aver scritto tempo fa.
Alcuni testi dell’ultima sezione parlano di vita, non necessariamente degli esseri umani, parlano di vita che, selvaggiamente e nonostante tutto, si afferma, emerge, rivendica la sua forza. Lo scopriamo quando ci spostiamo dal nostro centro e guardiamo fuori, desiderando “una vita da fiore, un cuore di cane…”.

L’autrice:
Valeria Raimondi vive a Brescia e fa parte dell’Associazione culturale Movimento dal Sottosuolo.
Con “Donne A(t)traverso” propone un recital sulle origini della violenza di genere. Nel 2016 viene tradotta in lingua albanese con i poeti Beppe Costa e Jack Hirschman.
Suoi inediti compaiono in “Distanze” (Fara 2018) e alcune invettive nella “Gazzetta dei Dipartimenti del Collage de ‘Pataphysique”. Una sua poesia è intro dell’album musicale dei DUNK.
Nel 2011 esce con Thauma la silloge “IO NO (Ex-io)”; nel 2014 con Fusibilia “Debito il Tempo”, opera vincitrice del Premio Eros e Kairos.
Sue poesie vengono tradotte in portoghese e presentate a San Paolo del Brasile nel 2018. Nel 2019 cura per Pietre Vive “La nostra classe sepolta: cronache poetiche dai mondi del lavoro”, selezione di poesie di lavoratori e lavoratrici di tutta Italia.
Nel 2020 la sua testimonianza di lavoro e di vita nella Lombardia colpita dal Covid, “Una storia sbagliata”, viene pubblicata da MicroMega.
(Valeria Raimondi “Il penultimo giorno” pp. 64, 10 euro, Fara editore 2022)
Immagini ———————————
Milano 2022
Dieci fotografie
di Paolo Veneziani

Margini. Di poesia ed altro ————————–
Dalle finestre la calma pulita dei giorni
Diletta D’Angelo, “Defrost”
di Roberto Lamantea

C’è una luce livida, da teatro anatomico o sala operatoria – ma dove questi luoghi, con uno scatto quasi surrealista, diventano sala da pranzo – in “Defrost” di Diletta D’Angelo (Pescara 1997), il suo primo libro, pubblicato da Interno Poesia di Andrea Cati.
Defrost significa scongelare, sgelare, sbrinare, ed ecco, subito prima dei testi, la foto in bianco e nero di un bovino, un vitellino da macello, solo – nudo – davanti a muri scrostati, scuri e cupi. Possiamo immaginarlo il suo destino, a cosa è servito il suo venire al mondo, quello di essere solo un prodotto per il consumo.
Come i versi di Alessandra Carnaroli sono la vivisezione del nostro vivere quotidiano abituato a ogni violenza e acidità, il primo libro di Diletta D’Angelo ti avvolge piano nelle sue spire e ricorda la luce da obitorio di Gottfried Benn. Anatomia, entomologia, fisiologia, clinica: lame, coltelli, muri, casa-carcere: “Anatomia di una gabbia” è il bel titolo della nota al testo che – accanto all’analisi di Alberto Bertoni – offre Carmen Gallo: “Il testo poetico si rivela un vero e proprio tavolo anatomico. […] L’anatomia della tradizione letteraria […] si sovrappone al macello degli animali: una dissezione dei corpi che non ha più il compito di approfondire e di conoscere, ma di scuoiare e ricomporre un cadavere che è esposto e destinato a essere mangiato prima di putrefarsi: “il sangue assorbito da questa terra/ è marcito tra le radici, ha seppellito l’embrione della violenza””; “Questa casa è un mattatoio a cielo aperto/ lo stomaco rabbrividiva/ alle grida di ogni bestia risuonava/ l’attrezzo: era una pala, la forchetta tintinnante, due mani,/ l’occhio fatto sottile”.
C’è un testo struggente – in prosa ritmica come altre pagine del libro – dove la pietà è sottovoce tra le righe: “Tonino era un altro animale in gabbia (pestato deriso abbandonato in un sacchetto), non urtava nei fatti nessuno, solo scompigliava l’aria il suo respiro di diverso. Erano sassate ricevute per noia della gabbia sentita da tutti, riconosciuta soltanto da chi ne aveva scoperto la porta d’uscita e poi ci era rientrato”. Quell’espressione, “il suo respiro di diverso”, è un pugno sullo stomaco.

“Dicono che il sacrificio del porco fosse rituale di morte e di vita, che l’animale/ sentisse, che in qualche modo sapesse// Prima un abbraccio collettivo ché non fugga, la detersione, la depilazione con acqua bollente// Poi l’espiazione di sollevarlo appeso a una ruspa, braccato/ con una fune a pendere dal piede posteriore. Può bastare/ anche una sola persona per finire l’operazione”.
Fa pensare al toro della corrida, ferito, sfinito, umiliato, sotto lo scroscio di urla di migliaia di spettatori che incitano il torero a ucciderlo. E lui smette di lottare, dà un ultimo sguardo a questo mondo assurdo dove si è trovato a nascere, si arrende alla lama sulla giugulare, mentre chi lo uccide viene portato in trionfo.
È difficile resistere a questi versi, a questo piccolo libro che ti entra tra le costole come una coltellata, dove i gesti dell’uccidere e del mangiare sono simili, come in “Fame blu”, lo stupendo ultimo romanzo di Viola Di Grado. La pietà è nelle righe bianche tra i versi, è nei silenzi della parola, così pieni di echi, e di grida, e di crolli. È nello scrivere ostinato, innamorato e ferito, contro questo mondo.
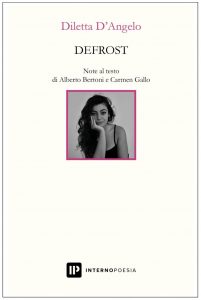
Dal libro:
Capita che piccole falene sboccino da buchi nelle porte,
che sopravvivano durante la fase larvale in strette gallerie scavate con la [bocca
che fatte a pezzi (una volta fuori dai fori di sfarfallamento)
sfamino insetti più grandi.
*
Replaced
È un ticchettio che non viene ascoltato
non sanno come non sanno
dove appoggiare l’orecchio
ormai è fatta di frammenti, della sabbiolina che senti se capovolgi
le cose rotte dentro.
*
Dalle finestre la calma pulita dei giorni
abbracciava le urla di ogni ora della notte
il rame fuso delle pieghe della testa
piaghe inconfessabili limature invisibili assorbite da tutti i ritratti
della casa vuota e sempre
così piena, così bianca.
*
Ora sembra di sbattere le ossa agli architravi delle porte di ogni stanza
la clavicola le costole l’anca le falangi delle dita
frantumate piano
senza usare la forza
A quelle porte mi appoggiavo con lo sterno e la fronte
entravo nel legno a cercargli le radici
una notte lo stipite mi spaccò in due la testa
le scosse della terra disorientano
le scosse della terra a volte ossigenano
*
Replaced
A undici anni si stendeva nelle tenebre dell’asfalto
con i fiori spezzati tra le fratture esposte
solo il cielo – riflesso negli occhi –
guardava i rivoli di plasma e di sale,
la necrosi tissutale, le grida suicide di nostra madre
suturavano una bambola riempita di sabbia
espellevano le ultime ossa
Vorrei solo dirti scusa scusa non ho saputo guardare oltre i tuoi resti
ti ho rimpiazzato il crescere vincere perdere provare
tolto il ridere vivere respirare guarire

L’autrice:
Diletta D’Angelo è nata a Pescara nel 1997. Vive a Bologna, dove ha conseguito la laurea magistrale in Italianistica.
Nel 2019 viene selezionata come autrice emergente per RicercaBO – Laboratorio di nuove scritture.
Nel 2021 ha vinto il premio Esordi di Pordenonelegge e sempre dal 2021 collabora con la casa editrice Industria&Letteratura come social media manager.
Nel 2022 ha vinto il premio Ritratti di Poesia.si stampi. È tra i fondatori del progetto Lo Spazio Letterario.
(Diletta D’Angelo “Defrost”, note al testo di Alberto Bertoni e Carmen Gallo, pp. 80, 13 euro, Interno Poesia 2022)
Immagini ———————————
Firenze 2023
Dieci fotografie
di Paolo Veneziani

Ti racconto ————————-
Paradosso mentale e storia breve
di Emma Gustafson

Se senti di paradossi senti della mia pelle che come un quadro di picasso vaga
Questi vittoriani pazzi che hanno le coperte di lino e le mani di seta
Mani di seta coperte di acqua sporca di fiumi senza un inizio
Intonacherò il volto del cielo con il sangue che magnificamente trasformerò in salsa di soia
Problema è una cosa che ha soluzione; problema è la vita e la soluzione è lei stessa
Nobile carattere dei bevitori senza sosta
Berrò nitidamente e penserò ubriacamente
Chi è diverso infetta la sua prole con il sapore del sesso distante e il suono del silenzio
lontano. E i genitori?
Voglio allargare il mio cosmo al mondo, regalarlo ai dirigenti scolastici.
Destituisci, tempo della mia specie, le ore che contano il giorno della mia morte
Le ipotesi della mia anima sono scritte, in caratteri senza lettere e senza volti, in voi che
guardate il sole
Si irrigidiscono le vertebre sotto il tuo tocco morbido
Le ossa si spezzano sulla scacchiera bianca e viola che formano i tuoi innumerevoli
commenti sulla mia pelle sporca
Sono curioso delle cose che hai dentro, delle cellule che formano i tuoi pensieri e delle iridi
dei tuoi occhi
Fuoriesci come un idromassaggio ribollente, pensiero mio…
Il cloroformio non è niente in confronto al tocco delle tue mani cloroformio i tuoi baci che
prima accendono e poi spengono mettendo in pace la mia anima a dormire senza un
soffio
Lubrificherò l’albero che ho in giardino: non piove da molto.
Quanto voglio un duttile pensiero che si plasmi nelle mie mani e che nelle tue venga
plasmato senza forma e con infinite forme mie e tue
Esibisco semi di ignoranza e cassette idroelettriche nelle lavatrici a forma di cervello fluido
e grembo di madre
Mi vesto sempre bene di un maschereccio senza eguali: ne ho un armadio pieno,
invisibile, nella mia stanza vuota che ha lo spazio occupato dal suo ingombro.
Felino è il disordine nel porta chitarre. Una nota è troppa, bisogna sorsarle poco a poco.
stoicamente guardo il pavimento e ci vedo le crepe con i topi che salgono dai buchi in un
cimitero vaporoso. Ho voglia di disgregare l’ordine e consacrare l’inconsacrabile tumulto
dei popoli nascosti nel pavimento. Sottomettiamoci tutti al grande volere dei sottomessi, io
metterò una buona parola sull’emigrazione, così che si compirà l’ascesa del secolo nuovo
e breve. Intrometterò Craxi e Barack Obama su Marte e Nettuno e l’entusiasmo fuoriuscirà
dalle loro orecchie
Berrò quindi una bella sorsata dei media nascosti in TV e assedierò le stalle delle vacche
con dentro la paglia marcia.
(Bambina gay ormai cresciuta) Sono gay come le bambine che giocano nel parco. Un
fetido profumo il tuo pensiero, signora, che come una fibra si attorciglia a me e mi toglie il
fiato e si ficca nei miei polmoni.
(futura madre di bambina gay) senza fiducia io mi preparo al parto della mia bambina gay
che canapa ucciderà, ingurgitata dalla massa con profumi di sesamo (il profumo della
signora sopra) che ingurgita i pensieri dell’iniquità, dell’intolleranza e li risputano a te mia
bambina gay, differenziata sempre, senza sosta, nella lotta contro l’autorità e che mangi e
disturbi i salami che ti sputano addosso. E ti avvedi di pregare il tuo dio come non mai tutte
le sere del mondo e che come una sola donna fai bisboccia insieme alle tue sorelle su un
biliardo in cui le palle vengono colpite senza un’interruzione e vanno dove il costruttore e
la tavola vuole. Deturpato il tuo volto dal tempo non lo vedrò mai, bambina mia. A destra
andrai quando il tuo cuore indicherà destra: questa è l’unica speranza e preghiera che
faccio al mio signore per te. Sinistra ove andrai quando la tua mente insieme al tuo cuore
indicherà sinistra e vi incontrerete.
Una parola pensata è una parola persa. (Muovetevi, bastardi.)

L’autrice:
Emma Gustafson, per metà italiana e per metà americana, è autrice di canzoni e di poesie.
Da diversi anni porta la sua musica in giro per l’Italia e per l’Irlanda, dove ha vissuto e conseguito un Master in Letterature comparate al Trinity College di Dublino.
Nel 2019 ha pubblicato per l’etichetta indipendente RadiciMusic Records due dischi intitolati “Many an Hour” e “Tales & Tunes from Towns & Hills Reviewed”.
Nel 2015 è uscita una piccola raccolta autoprodotta di poesie intitolata “Freetime Poems”.
“Le percezioni” è il suo primo libro di poesie in italiano, pubblicato per Eretica Edizioni nel 2022.
Immagini ———————————
Castelnuovo Bocca d’Adda (Lodi) 2021
Dieci fotografie
di Paolo Veneziani

Libroelibro —————————-
Oggi ci guardiamo intorno
Francesco Filippi, “Ma perché siamo ancora fascisti? Un conto rimasto aperto”
di Laura Mautone

In questo interessantissimo libro, “Ma perché siamo ancora fascisti? Un conto rimasto aperto”, Francesco Filippi analizza da un lato i motivi per cui, al termine della guerra, in Italia non si è riusciti a rielaborare il rapporto con il fascismo dal punto di vista degli atteggiamenti pubblici, delle assunzioni di responsabilità, delle operazioni di epurazione e delle leggi. Dall’altro indaga la costruzione, più o meno spontanea, dell’immagine del fascismo italiano nel secondo dopoguerra, attraverso una vera e propria possibile storia della mentalità italiana, che, sopra a uno sforzo pubblico e storiografico di costruzione valoriale, si cuce addosso un comodo abito fatto di innocenza e irresponsabilità nei confronti di un passato che non si vuole più sentire come proprio.
Una Storia di cui non si vuole avere Memoria, così conclude Filippi le pagine del preludio. Uno dei sillogismi più diffusi dopo la fine della seconda guerra mondiale è “solo il nazismo è sterminio”, “solo i tedeschi sono nazisti”, e quindi “solo i tedeschi sono responsabili dello sterminio”. Si tratta ovviamente di un ragionamento che implicitamente scarica la totale responsabilità della Shoah sui nazionalsocialisti, autoassolvendo tutto il resto della popolazione europea, dimenticando il ruolo di milioni di persone, tedesche e non tedesche, i “volenterosi carnefici” o anche i Mitläufer, che permisero che il genocidio e lo sterminio avvenissero senza opporre alcuna resistenza. In Italia questo ha portato alla falsa attribuzione della responsabilità delle deportazioni all’arrivo di Hitler.
In realtà, le leggi razziali erano state emanate molto prima del 1943 ed applicate in termini di discriminazione e esclusione dai diritti da subito. Si associa, dunque, la fase del fascismo repubblichino alla fase delle tragiche deportazioni, salvando il fascismo precedente. Niente di più erroneo e falso: il fascismo è stato razzista nelle sue più profonde pieghe, se addirittura De Gasperi, che fascista non era, durante le trattative di pace, attraverso canali diplomatici, fa trapelare l’intenzione italiana di mantenere il controllo delle colonie di Somalia, Eritrea e Libia, conquistate prima dell’avvento del fascismo, anche se […] non si spinge a rivendicare il controllo dell’Etiopia, si pone in una linea di continuità tra il passato liberale e in contrasto con quello fascista. Il nuovo governo nato dalla Resistenza e dalla lotta al nazifascismo vuole allontanarsi dall’immagine delle folle oceaniche a Piazza Venezia: quella è l’Italia fascista, è la giustificazione, oggi l’Italia è diversa.
Questa interpretazione è alla base della rimozione del razzismo e del colonialismo fascista. La ferma difesa dei criminali di guerra italiani come Pietro Badoglio e Rodolfo Graziani portata avanti dai governi repubblicani, che ne negano persino l’estradizione, ne è una palese dimostrazione. Secondo Filippi, poi, anche gli Alleati perseguono una politica volta a superare la fase postbellica, in modo da guadagnare da subito l’Italia al campo occidentale.

L’Italia cercherà di affrontare il fascismo in tre modi: attraverso i tribunali, limitandolo nelle aule e nelle piazze e dimenticandolo nella vita quotidiana. Secondo Filippi, già dopo il 1943, la parola d’ordine sarà normalizzare e semplicemente cancellare l’aggettivo fascista dalle istituzioni. Il fascismo è ufficialmente fuori legge, ma paradossalmente non vi sono azioni di carattere giudiziario nei confronti di chi il fascismo lo ha rappresentato fino a quel momento. L’epurazione di funzionari e impiegati fu applicata con il contagocce, anche perché avrebbe portato al collasso dell’apparato statale.
Inoltre, le norme per giudicare sono ancora tutte da scrivere, solo nel 1944 il fascismo sarà ufficialmente reato. La guerra civile partigiana alimenterà il clima da resa dei conti, anche per la lentezza e l’inefficienza della giustizia ordinaria che non aveva modo di distinguere tra giudicati e giudicanti.
Nel 1946 viene approvata quella che viene chiamata “l’amnistia Togliatti”: il provvedimento di fatto cancella tutte le condanne emesse nei confronti dei fascisti dai tribunali partigiani […]. L’intento è quello di una pacificazione nazionale […], il risultato è […] un enorme colpo di spugna. Quindi, sia la pacificazione, sia la giustizia saranno due obiettivi mancati: nessuno ha veramente voglia di “fare i conti con il fascismo”, né chi fa parte dello stato, né la magistratura, né la scuola e l’università, né il mondo economico e nemmeno la gente comune che vuole solo andare oltre quel terribile periodo.
La continuità tra passato fascista e presente repubblicano è evidente anche nei nomi dei protagonisti: Amintore Fanfani, cinque volte Presidente del Consiglio, democristiano, dopo aver giurato fedeltà al fascismo nel 1936, diventa professore di storia delle dottrine politiche a Milano, collabora addirittura a riviste come “La Difesa della razza” e firma il Manifesto della razza, scappa in Svizzera nel settembre ’43, rientrando poi nella DC nel periodo resistenziale; Luigi Einaudi, Antonio Segni, Giovanni Leone, tutti futuri Presidenti della Repubblica con una solida carriera universitaria durante il fascismo. Ciò non significa, ovviamente, […] una decisa adesione al fascismo, ma […] una difficoltà di “poter fare i conti” con esso. […] Molta classe politica repubblicana ha ben presente quali siano state le difficoltà nel mantenersi lontani da ogni possibile coinvolgimento col regime fascista durante il Ventennio. La storia della DC affonda, infatti, le sue radici nel sistema di potere degli anni Trenta. In altri partiti la Resistenza e la lotta armata costituiscono il punto di partenza, come nel PCI e nel Partito d’Azione.
Si assiste addirittura ad una vera e propria “epurazione al contrario”: figure di spicco dei Comitati di Liberazione vengono rimossi dagli incarichi pubblici, a causa della loro partecipazione alla lotta armata. Alcuni storici parlano a questo proposito di “Resistenza tradita”. Tuttavia la Costituzione italiana nasce antifascista e vieta esplicitamente la ricostituzione del partito fascista.
In cinque anni si prevede l’allontanamento dei “capi responsabili”: la definizione però di “capi” e “responsabili” è piuttosto ambigua. Se ci si pensa già l’assetto bicamerale dello stato rappresenta un segnale di forte discontinuità con l’epoca che precede il fascismo e il fascismo stesso.
Alla fine dall’apparato della pubblica amministrazione praticamente non viene rimosso nessuno. Inoltre, a dieci anni dalla fine della dittatura e ad appena otto dalla Liberazione nessun fascista dichiarato colpevole di reati anche gravi risulta in carcere.
Nel 1952 la legge Scelba si pone come pilastro dell’antifascismo giudiziario repubblicano, rispetto alla definizione di fascismo, all’esaltazione della memoria del passato regime, all’insegnamento nelle scuole dell’antidemocraticità del fascismo. Questa legge, però, subirà nel corso degli anni una sorta di diluizione, sostiene Filippi, con decisioni della Corte Costituzionale piuttosto ambigue sulla differenza tra “mera difesa elogiativa del fascismo” e propaganda che favorisca la ricostruzione del partito.
Nel frattempo, siamo negli anni Settanta, mentre il movimento Ordine Nuovo, che raccoglie i pezzi della galassia neofascista, viene sciolto a causa di una sentenza e entra in clandestinità, ingrossando le fila del terrorismo di estrema destra che insanguina il paese, il MSI continua a raccogliere consensi e strizza l’occhio al possibile bacino di voti della destra extraparlamentare.

Nel 1975 viene ratificata dal governo italiano la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale. Agli inizi degli anni Ottanta all’interno del discorso pubblico la retorica veterofascista è ormai tollerata. Con l’avvio del fenomeno migratorio dopo il crollo dei regimi comunisti dai paesi dell’Est Europa viene emanata la legge Mancino del 1993 a proposito di “misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica o religiosa”, che non serve a contrastare la diffusione di idee fasciste, ma a sanzionare le frange violente di movimenti antidemocratici o pericolosi per la stabilità dello stato. Si pensi alle manifestazioni razziste e antisemite di alcuni gruppi del tifo organizzato. L’ultimo provvedimento che Filippi cita è una proposta di legge dell’On. Emanuele Fiano in cui si fa riferimento alla propaganda del regime fascista e nazifascista.
Il disegno di legge è stato approvato nel 2017, ma nel 2020 è ancora in attesa di calendarizzazione per proseguire l’iter di approvazione.
La seconda e ultima parte del volume di Filippi è divisa in tre capitoli: provare a comprendere il fascismo; provare a superare il fascismo, che cosa significa davvero “fare i conti”. Per motivi di spazio mi soffermo solo sull’ultimo capitolo, ma il consiglio è di leggere attentamente tutto il libro: l’immagine degli italiani “brava gente” è frutto di una narrazione che, basata anche sull’immagine che la cinematografia italiana e non solo ha costruito, ha garantito una sorta di deresponsabilizzazione e di una tendenza a mettere tutto, fascismo e antifascismo, sullo stesso piano.
Perché quindi siamo ancora fascisti o, meglio, perché non siamo convintamente antifascisti? Perché in questi anni, nel tentativo di mantenere pulita la memoria del paese, non abbiamo affrontato con determinazione i crimini che il fascismo ha commesso anche grazie alla connivenza degli italiani e quindi oggi, dato che non si conoscono i delitti del fascismo, pare quasi che il fascismo di delitti non ne abbia commessi, conclude Filippi.
Siamo divisi tra chi non ha voluto mai essere altro, chi non ha mai imparato a essere altro e chi è rimasto colpevolmente indifferente. Ora è arrivato il tempo di fare i conti con la nostra storia, di porsele finalmente le domande e questo libro, accurato, documentato e ben scritto, aiuta sicuramente a trovare alcune risposte.

Dal libro:
Com’è possibile – ci si chiede in molti – che dopo tutto quello che è successo – dopo una guerra disastrosa, milioni di morti, l’infamia delle leggi razziali, la vergogna dell’occupazione coloniale, una politica interna economicamente fallimentare, una politica estera aggressiva e criminale, un’attitudine culturale e liberticida, una sanguinosa e lunga guerra civile … -, oggi ci guardiamo intorno, e ci scopriamo ancora fascisti? Ma cos’altro avrebbe dovuto succedere per convincere gli italiani che il fascismo è stato una rovina?
(Francesco Filippi “Ma perché siamo ancora fascisti? Un conto rimasto aperto” pp. 256, 12 euro, Bollati Boringhieri 2020)
Immagini ———————————
Iusurascu (Piacenza) 2023
Dieci fotografie
di Paolo Veneziani

Intervista a Paolo Veneziani:
La prima cosa che si nota, inevitabilmente, è che tutte le foto qui proposte sono in bianco e nero. Da cosa nasce questa decisione, e come si è sviluppata nel tempo?
Il colore e il bianco e nero sono due linguaggi diversi e credo sia molto difficile usarli entrambi.
Nonostante vediamo a colori, per me il bianco e nero è autentico, essenziale, rivelatore.
Questa intuizione mi ha portato a fotografare esclusivamente in questo modo ed è stata molto importante per la mia crescita.
Ho iniziato davvero a lavorare su forme, volumi, contrasti, equilibri come non ero mai riuscito prima. Nonostante possa sembrare una limitazione e un’imposizione, mi ha aperto la mente.
E la cosa che colpisce, da subito, è la totale assenza di presenza umana. Come mai?
Preferisco suggerirla senza inserirla.
A parte Firenze e Milano, e guardando anche il resto della tua produzione artistica, le tue immagini nascono sempre nella provincia, nei paesi. Perché questa scelta? Se scelta è…
Vivo in un piccolo paese in provincia di Piacenza.
Ho imparato, all’inizio forse per necessità, ad apprezzare quello che mi sta intorno esplorando e approfondendo queste aree della Pianura Padana, in particolare prossime al fiume Po.
Non lo trovo penalizzante, anzi, questi paesi e luoghi all’ apparenza monotoni e privi di fascino, sono diventati il mio parco giochi privato.
Mi piace pensare di essere stato l’unico ad aver notato e fotografato certi dettagli, l’unico ad averli visti cambiare con il tempo, mutare e a volte sparire.
Con questo non mi precludo altre possibilità, anzi, sono sempre alla ricerca di nuovi soggetti ma è comunque difficile trovare la stessa intimità in luoghi lontani, visitati magari solo in un paio di occasioni.

Alcune fotografie sembrano cercare qualcosa che va oltre all’immagine che testimoniano. Come un trovare una essenza più profonda, che ha a che fare con un qualcosa che ricorda il tema dell’astratto. Ti ritrovi in questo?
Certo, la fotografia è legata per forza alla realtà: in un punto nel tempo e nello spazio quel quadrato è esistito e il suo contenuto è concreto. Lavorando però in fase di composizione sulla selezione e sovrapposizione degli elementi è possibile originare un insieme che sfida la normale percezione, risultando per certi versi astratto.
E poi sembra che ogni foto porti con sé un segreto. Un silenzio che contiene in sé tutto il suo esistere. È (anche) così?
Apprezzo molto questa tua lettura. Fotografo quello che sono, difficile definire l’insieme di esperienze, preferenze, sensazioni che mi spingono a catturare e proporre un’immagine invece di mille altre.
Considerando la fotografia un linguaggio, perché provare a spiegarlo con un altro?
Propongo un estratto, un frammento, che può essere letto da ognuno in modo diverso rimanendo sempre e comunque realtà.

L’artista:
Paolo Veneziani, piacentino classe 1977, opera artisticamente dalla metà degli anni 90 come musicista/compositore. Abbandona nel 2016 questa forma di espressione prediligendo il linguaggio fotografico. Attivo principalmente su instagram con lo pseudonimo @snekula, partecipa a mostre collettive e personali a partire dal 2021.
Le composizioni dell’artista, ermetiche e spesso enigmatiche, sono prive di esseri umani e quasi totalmente di ombre.
rivista Fare Voci
curata da Giovanni Fierro
collaboratori:
Roberto Lamantea, Salvatore Cutrupi, Ilaria Battista, Laura Mautone, Luigi Auriemma, Massimiliano Bottazzo, Livio Caruso.

