
Ci ritroviamo, alla ricerca di possibili e significative scritture, immagini in movimento e sguardi che non si arrendono.
Ad iniziare dal nuovo romanzo di Federica Manzon, “Il bosco del confine”, dove si respira l’aria dell’est, il margine geografico e il margine di ogni esistenza, Sarajevo e le storie della Storia.
Per poi proseguire con la poesia necessaria e articolata di due poeti come Francesco Targhetta e Marco Bini. I loro “I fiaschi” e “New Jersey” sono due libri con cui ci si deve confrontare, testimonianze importanti all’interno del panorama poetico italiano.
E la poesia è anche nei testi inediti di Matteo Piergigli, nella premiata raccolta “Rosa del battito” di Donatella Nardin e nel volume “Di libertà e d’amore” di Laura Ricci, dedicato ad Elizabeth Barrett Browning e ai suoi “Sonetti dal portoghese”.
Il fascino della lettura è evocato in “Ogni libro è un labirinto. La biblioteca di Babele da Borges a Dante”.
Le immagini sono di Lorenzo Marabini, con una ampia scelta del suo lavoro artistico.
Buona lettura.
Giovanni Fierro
(la nostra mail è farevoci@gmail.com)
Immagini ———————————–
TUTTUNO
timBALLO di ANATRA all’ARANCIA
di Lorenzo Marabini

Ti racconto ————————-
L’aria dell’est
Federica Manzon, “Il bosco del confine”
di Giovanni Fierro

È un vero piacere leggere il nuovo romanzo di Federica Manzon, “Il bosco del confine”.
È un viaggiare ampio e profondo nelle pieghe del tempo e della Storia, ma con l’acceso sentire con cui queste sue pagine parlano del nostro oggi.
Perché il libro della Manzon è anche un lavoro che racconta ed esplora i concetti di confine e frontiera, di possibilità e di preziosità che alimentano una regione, non solo geografica ma anche dello spirito, dove si può respirare l’aria dell’est. E dove l’incontro e il confronto sono i protagonisti assoluti.
“Il bosco del confine” è Trieste e i suoi dintorni, i boschi che diventano mappe da scoprire, ma anche da inventare, le olimpiadi invernali dell’ottantaquattro a Sarajevo, l’incontro della protagonista Schatzi con il giovane Luka che sarà l’altra metà protagonista. Assieme al padre di lei, uomo per cui la libertà e la responsabilità vanno di pari passo, figura di sani ideali che hanno bisogno di continua manutenzione.
L’autrice, con questo suo ripercorrere il sogno di convivenza umana, sociale, religiosa che è stata la Jugoslavia, con Sarajevo fioritura completa ed appagante, e l’imbarbarimento che l’ha messa a fuoco nella prima parte degli anni Novanta, ci dice di come viviamo ora la vicinanza, la condivisione, l’accoglienza e il progetto Europa.
Sì, l’est che si affaccia ai Balcani e che lì compie la propria vita, che “È un paese pieno di storie complicate”, dalle radici profonde che verranno tagliate con dolore e spargimento di sangue.
In questa bella narrazione, dove Federica Manzon usa il proprio scrivere con il talento del coinvolgimento, la Storia non smette di fare male: “Mi ha chiesto di mia madre, hai sentito? Faceva finta di non sapere da dove veniamo, invece lo sa benissimo. Era una spia della polizia di Tito, uno di quelli che denunciavano la gente”.
Perché “Il bosco del confine” non è un libro pacificato, ma un raccontare che fa emergere tagli e disillusioni, ma che ha la forza di trasmettere l’umanità necessaria che è sempre alla base di ogni nuova rinascita. Anche nell’incontro tra i due giovani protagonisti del libro, dove Luka “Ora è dritto in piedi e sembra ancora più alto, un ragazzo gru migrato nella direzione sbagliata”. Basta questo ritratto per dire anche del respiro poetico di queste pagine.
Certo, la Storia, che a Sarajevo sotto assedio è stata un sogno sbriciolato e calpestato, dove il desiderio in quei giorni dannati era molto semplice: “A volte mi chiedo se potrà mai scendere così tanta neve da coprire tutto. I corpi e gli spari”. Si, ancora Sarajevo, il cui fascino non smette di risplendere, “A pensarci bene. Sai cosa ti dico? Credo che quest’uomo, questo mio amico scrive, non si sia fermato a Sarajevo per l’amore di una donna, ma si sia innamorato per fermarsi a Sarajevo”.
Federica Manzon in queste sue pagine dà fiducia ai boschi e al confronto con il senso del confine.
Sì, lei sa che proprio il confine spesso è la protezione ad una paura dell’incontro, che sempre nutre l’io ma che viene temuto. Grazie ai protagonisti del suo libro riesce a trasformarlo in frontiera, in un tempo più largo dove riconoscere e nutrire il pensiero dell’andare incontro, dove difendere il principio dell’accogliere.

Dal libro:
“Con che spirito ci guardiamo intorno quando passeggiamo nel bosco? Tra l’avventuroso e il romantico, come se guardassimo il mondo per la prima volta, diceva. Non ci importa della meta, incontriamo viandanti come noi, fuggitivi e clandestini, oziosi e inquieti, il bosco non si divide per nazionalità come una cartina geografica, hai mai visto una betulla ritrarre i rami per non sconfinare in territorio straniero?”
*
“Questi confini sono una sciocchezza, si infervorava a un certo punto. Basta andare nel bosco per capirlo. Sai cos’è un confine? Un confine non è niente, è un bordo, è un punto in cui si incontrano due tessuti, è un punto in cui la trama è esposta e si fa più sottile. Tu dimmi, vedi qualche differenza tra noi e quelli di là?”
*
“Mio padre detesta guidare eppure è allegro, ogni mezz’ora abbassa il finestrino e sporge il naso nell’aria di cristallo come un giovane attore dei film americani, un James Dean con i chili di troppo e la camicia a quadri.
‘La senti quest’aria?’ chiede entusiasta, ‘è l’aria dell’est’.
Obietto che mi pare uguale a quella di casa e lui si batte una mano sulla coscia, ‘Esatto!’. Ride di ottimo umore.
Radio Capodistria manda musica americana. Mio padre fischietta i ritornelli, ogni tanto fa qualche deviazione per mostrarmi un edificio in gotico veneziano che prima della guerra era stato sede di un italianissimo municipio, oppure una cascata o un vecchio fienile che nascondono sempre una storia leggendaria che lui conosce o si inventa lì per lì. Per il resto sono prati e boschi.”
Intervista a Federica Manzon:
“Il bosco del confine” è anche un addentrarsi nella Storia più recente, un cercare una vicinanza tra avvenimenti dolorosi e intensità emotive, come si fa a mettere tutto questo sulla carta?
In questo libro c’erano due cose che mi stava a cuore raccontare: il sentimento di familiarità e attrazione che sento per una zona di confine, quel nord est carsico, complicato e spesso respingente, e dall’altra parte la capacità di quella geografia di incidersi nei caratteri delle persone, di renderli a volte degli strani e disadattati sismografi capaci di cogliere prima di altri il vento dei cambiamenti europei.
Il confine è un tema che è costante nel libro. Perché? In che modo si coniuga al presente che adesso viviamo?
Viviamo in un’Europa che ha abolito i confini, ma ciò che ne è conseguito non è stata una nuova società aperta e cosmopolita, ma assistiamo anzi al sorgere di separatismi e nazionalismi un po’ dovunque.
Credo invece che il confine, quando è davvero tale e non si trasforma in un muro, vada invece interrogato e possa essere un luogo, una linea, da cui ripartire per pensare una società che non ha urgenza di assimilare ma che sa abitare le differenze in modo libero e pacifico.
Il bosco sembra essere il luogo dove ogni legge ed ogni libertà sono rispettate. La natura è sempre un confronto necessario?
Lo è per me, perché credo che il confronto con gli elementi naturali (il mare, il vento, la montagna, il fiume) ci metta a contatto con una dimensione d’assoluto che risuona potente al fondo della nostra esistenza, un assoluto che ci angoscia e ci fa paura ma ci spinge anche a un respiro più grande.
C’è un amore che tiene le pagine del libro assieme, e che permette a tante cose importanti di essere dette e raccontate. Perché la scelta di questo ‘collante’?
Luka, il ragazzo che la protagonista incontra a Sarajevo, e per lei la chiave d’entrata alla città, il suo acceleratore di intimità. Il suo amore è un amore per la città.
Di Sarajevo cosa rimane adesso, nel ricordo che parte dall’assedio subito e che ci porta ai nostri giorni?
Di Sarajevo rimane, per me, il senso potente di un luogo in cui cultura, storia e mito parlano ancora con forza.

La Jugoslavia, in qualche modo, era uno sogno di civiltà. Poi è diventata un incubo. Qual è, adesso e a distanza di tempo, il suo sguardo e il suo pensiero in merito?
La questione jugoslava è una questione geopolitica e storica complessissima, io credo unicamente che pensare un’Europa che escluda il cuore dell’ampia regione balcanica significa perdere un pezzo della nostra identità e rimanere più poveri.
Il tema della memoria, vissuta anche come eredità, è importante. Era una prerogativa del romanzo?
Io fatico a pensare il romanzo senza pensare anche a un discorso sulla memoria, perché credo che i personaggi, quando sono davvero riusciti e ci parlano, sono sempre il frutto della loro eredità, di una memoria storica e individuale che pesa su di loro e che attraverso di loro ci parla.
C’è sempre una voglia di ‘incontrarsi’ (che nasce soprattutto nella protagonista), che si scontra con le altre figure che fanno il libro, molto chiuse nei loro ‘mondi’. E penso che sia questa la tensione che continua a dare impulso cardiaco al raccontare di queste pagine. Può essere così?
In realtà lei è figlia di un padre che mescola lingue e confini lasciando che molte voci diventino la propria, e Sarajevo è la città dove tutti, fino all’ultimo minuto possibile, hanno creduto che una guerra di identità chiuse fosse impossibile in città. Credo che tutti i personaggi del libro siano animati da questo spirito. Poi certo, la guerra, tanto più un assedio, è un tempo che si chiude tragicamente in se stesso.
Questa parte qui d’Italia a nord-est (penso a Gorizia e Trieste, a tutta la zona limitrofa che fa da respiro e condivisione con quella che è adesso la Slovenia) cos’ha di così specifico? e di speciale mi viene da dire…
L’aria dell’est.
Nella storia della protagonista, mi sembra che “il bosco del confine’ sia un invito ad essere se stessi, a non rinunciare alla propria specificità….
Sicuramente la protagonista ha ricevuto un’educazione che cercava di scartare ogni conformismo e considerava l’eccentricità un valore. Credo che essere se stessi, e prima ancora provare noi stessi, capire qual è il nostro genius, sia un cammino lungo, spesso faticoso, lungo il quale spesso si deraglia, ma sia l’unico che dà un senso alla nostra vita.
L’ultima domanda è forse la prima domanda da fare… da cosa nasce questo libro?
Dall’aria dell’est.

L’autrice:
Federica Manzon è nata nel 1981 a Pordenone. Vive e lavora tra Torino e Milano.
È autrice dei romanzi “Come si dice addio” (Mondadori, 2008), “Di fama e di sventura” (Mondadori, 2011; Premio Rapallo Carige per la Letteratura Femminile e Premio Campiello Selezione Giuria dei Letterati) e “La nostalgia degli altri” (Feltrinelli, 2017).
Ha curato l’antologia “I mari di Trieste” (Bompiani, 2015).
Attualmente è responsabile della didattica per la Scuola Holden e collabora con l’organizzazione del Festival letterario Pordenonelegge e con il quotidiano di Trieste Il Piccolo.
(Federica Manzon “Il bosco del confine” pp. 173, 14 euro, Aboca editore 2020)
Immagini ———————————–
TUTTUNO
ICTYS
di Lorenzo Marabini


il video di ICTYS lo si può guardare qui
Tempo presente ————————–
Un per sempre inventato
Cinque testi inediti
di Matteo Piergigli

siamo il poi
a sorreggere il cielo
di forze contrarie
(noi) il nostro esilio
a vivere i giorni
*
moriamo-viviamo
il buio di fame
un per sempre inventato
arrende la notte
tiene per mano l’ordine
di una scatola vuota
*
(e noi) petto-battito
un dove altrove scava
cielo agli occhi la notte
nega quello che sarà
*
la panchina aspetta
sul fianco della luna
c’è un perdere che
fa vivere aggrappato
la pioggia affondata
nella carne
*
due mani sfiorano
una luce accende
la stanza tutto fugge
qualcosa manca
la ritrovo accanto

L’autore:
Matteo Piergigli è nato a Chiaravalle (An) nel 1973. Ha pubblicato “Ritagli” nel 2015 con la Casa Editrice Kimerik. Il libro è una raccolta di poesie, aforismi, attimi di quotidianità presenti e passati, aneddoti.
Nel 2016 pubblica “Ritagli 2” con la casa editrice Arduino Sacco.
Tra il 2014 e il 2017 numerosi suoi testi sono stati pubblicati in varie raccolte e antologie.
La sua raccolta più recente è “La densità del vuoto”, edita da Samuele editore nel 2019.
Immagini ———————————–
sHotlines – spari su tela
di Lorenzo Marabini



Voce d’autore ————————
Così ti vedi, così è la vita
Francesco Targhetta, “I fiaschi”
di Roberto Lamantea

Il Veneto postindustriale – la terra dei capannoni, delle complanari, svincoli, centri commerciali, fabbriche, parcheggi, cinema multisala, qui e là qualche prato polveroso nido di rifiuti, ritagli d’erba di un verde pallido e malato a ricordare che quella terra una volta era campagna – questa zona anche umanamente arida che dalla pianura tra Padova, Treviso e Venezia s’arrampica fino alla pedemontana, ha la sua letteratura.
È la “pianura stanca” di ville e cancelli automatici dove frammenti di natura sopravvivono (fiumi di risorgiva, boschetti, campi, vigne, ma anche fagiani, garzette, picchi rossi e un’avifauna che non ti aspetti perfino in una città come Mestre).
È il Veneto dei schei, molto più del dio denaro tratteggiato a teatro da Molière e Goldoni: è una ricchezza volgare, senza grazia e senza cultura. È il Veneto disegnato dalla scrittura vertiginosa di “Cartongesso” di Francesco Maino, narrato da Alessandro Banda in “Io, Pablo e le cacciatrici di eredità”, ambientato a Mirano. È la terra dei romanzi di Romolo Bugaro.
Francesco Targhetta è noto perché il suo romanzo “Le vite potenziali” è arrivato nella cinquina del Campiello e ha vinto il premio Berto, ma il suo primo titolo è “I fiaschi”, raccolta di poesie che della terra veneta sfigurata dal “progresso scorsoio” di cui parlava Zanzotto racconta, con ironia desolata, il vuoto, l’angoscia, il nulla.
Nel 2012 Targhetta ha pubblicato da Isbn Edizioni un romanzo in versi, “Perciò veniamo bene nelle fotografie”, ristampato in una nuova edizione da Mondadori nel 2019 consolidando l’autore trevigiano tra i giovani autori più interessanti.
“I fiaschi” esce ora in una nuova edizione da Le Lettere, con la nota originale e un aggiornamento di Raoul Bruni e l’aggiunta di 60 poesie inedite scritte negli stessi anni di composizione (2003-2009).
Periferie, città, strade e una natura frammentata sono il paesaggio di queste poesie disincantate – a volte sarcastiche ma mai veramente disperate – dove un giovane co.co.co s’arrampica tra monolocali e un senso costante di precarietà anche amorosa. Il grigio del cemento e dell’asfalto consuma anche i colori del cielo e dell’erba.
È il vero paesaggio del vuoto, capace di trasformare in icona il progressivo deserto dell’anima, il vuoto interiore, la conformazione automatica e ipnotizzata a quella (in)civiltà dei consumi evoluta dagli anni ‘60 e che Pasolini aveva intuìto già 50 anni fa nei testi poi confluiti in Lettere luterane e Scritti corsari.
Il paesaggio specchia il trionfo del non-pensiero, dell’adesione acritica di massa a uno stile di vita vuoto sentito come il migliore possibile, fatto di griffes, smartphone, miti commerciali e spritz.
Targhetta è poeta, e scrittore, raffinato e colto. Così se Raoul Bruni nella prefazione e Daniele Piccini in una bella recensione su La Lettura del 3 gennaio 2020 citano i crepuscolari come prima matrice di questo libro (Targhetta si è laureato con una tesi su Govoni), la tessitura stilistica è molto più ampia. C’è un montaliano canto delle rime interne, deliziosi echi alla Gozzano (la rima elisabettiano/ Flaiano), intonazioni alla Giudici, la bellissima poesia di pagina 31, acquerelli che ricordano la dolcezza di Sandro Penna (“Vuol dire che stai passando/ per il campo del mercato,/ con le amiche, sul far della sera”) o un testo struggente come “Il treno dopo”, testi (“La fuga”) che ricordano la forma canzone alla Gaber e molte sono, in esergo, le citazioni da versi di band musicali. Fino a un grido beat, “La rivolta”.
“I fiaschi” racconta il vuoto antropologico di una terra che era bellissima ma non è solo questo: il libro di Targhetta è anche un canzoniere, disilluso, amaro, desolato (sembra che anche i sentimenti non possano essere condivisi, vissuti insieme) ma mai arreso.
Queste sono anche poesie d’amore, non solo narrazioni di sconfitte (i fiaschi, appunto) ma invocazioni. Se Targhetta scrive “tra i capannoni della zona industriale la domenica: la vita va maltrattata, / come il dolore” e pochi versi dopo “al freddo/ delle cinque di mattina su asfalti vuoti e illuminati,/ nei parcheggi liberi come la paura”, o nella poesia “triestina” di pagina 56 confida: “Così ti vedi, così è la vita:/ si fugge sempre, raramente si ama”, in “Epitalamio” le parole danzano: “Ma tu balla e sorridi/ della tua gioia confusa:/ magari diventerai la musa/ dell’amore felice”.
Ma è la citata “Il treno dopo” ad avere una struggente tenerezza alla Rohmer, la vita che vola via:
Potevo poco fa prendere il treno
che tu prendi, e vagare
tra i vagoni per guardarti
da lontano. Ma non l’ho fatto
perché ieri, forse, senza volerlo,
ti ho mandato un messaggio
che diceva che ti amo.
Così alla fine ho preso il treno dopo,
perché non so se parlarti come se
quelle parole le avessi scritte
oppure no.
Ma l’importante, lo so, è solo
che le penso, e il resto sono pensieri
senza un briciolo di senso, Elisa.
“Non devi amarmi se ti sbriciolo
su una tovaglia lisa. E non mi ami”
(Elio Pagliarani).
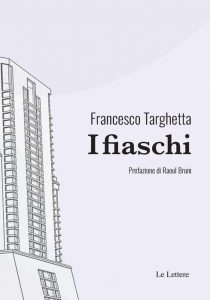
Dal libro:
Strategia per la conquista della stazione ferroviaria
Mi piaci solo dove ti trascuri,
negli angoli buttati, nei vicoli
scuri, dove nessuno ti guarda
e non te ne importa, nelle vetrine
rimaste agli anni settanta, dove
i canali si inforrano, sempre zitti,
bui, e il tramonto si incrina
in sampietrini sconnessi, dove
neanche tu, sotto occhi bassi,
ti sei accorta di valere di più.
E mi lasci in un novembre e sono
io che ti lascio: stomacarsi
a vicenda non vale la pena,
e cercare per resistere di sfruttarti
in ore morte. Meglio abbandonarti
così, maltrattata e neanche offesa,
e conquistare un bar che faccia
da fortino, un pezzo di verde
e un gradino in pescheria,
e la stazione, soprattutto,
per scappare, appena dormi,
appena serve, fuggire via.
Rimini
I bagni chiusi quando inizia l’autunno,
gli alberghi semivuoti e l’umidità
della sabbia, i pini marittimi
che perdono gli aghi e ancora
la rabbia di fingerti qui. A metà
di questi due giorni senza dormire
lo sai che è finita l’ennesima estate:
l’ho trascinata sulla battigia
con il vento sulla faccia, tra il vino
e la sambuca in locali deserti, fino
alle soglie di un panificio a Riccione
e poi nel vuoto della stanza d’albergo.
Allora si è scoperta un’alba grigia,
con la pioggia che batteva forte
sul vetro dell’ascensore esterno.
Come si fa ad amare d’inverno?
Rifiuto del rifiuto
Pure il suicidio alla fin fine
è una stupida carnevalata,
buona al massimo
per il teatro elisabettiano.
«Io muoio alla giornata»
(Ennio Flaiiano)
Vivere male
Osservare i limiti di velocità
guidando la domenica mattina
è un segnale di vivere male,
ancora sbronzo dal sabato prima,
dormite solo tre ore, l’arbre magic
che ballonzola e le dediche d’amore
alla radio, ma sempre meglio
di andare a messa o guardarsi
la partita del Cervia o vestirsi
con la tuta per fare del footing.
E lo stesso vengono i nervi
a pensare quanto stupido
e inutile sia vivere una vita
venduta così, al miglior offerente,
senza opporre nient’altro che un po’
di passione bruciata nelle cose
ritenute peggiori: l’alcol,
la notte, la musica, e la guida
in stato di ebbrezza.
E non c’entra un cazzo la crisi
economica se migliori nel look
e nell’esperienza ma rimani
soltanto un aspirante suicida.
Intervista a Francesco Targhetta:
“I fiaschi” (2009, 2020) precede e segue il romanzo in versi “Perciò veniamo bene nelle fotografie”, dedicato a un Veneto sfigurato nel paesaggio e nell’anima. È ancor oggi la regione d’Italia con il più alto tasso di cementificazione. È la terra dei “schei” narrata da Francesco Maino in “Cartongesso”.
Penso alla mia generazione, ventenni negli anni ‘70, pieni di ideali, e a quelle successive. La tua generazione ha ancora sogni? E i ragazzi di oggi?
La tua generazione ha conosciuto un paesaggio, reale e umano, diverso da quello, già sfigurato, in mezzo al quale è cresciuta la mia: siamo entrati nella vita dunque con la peculiarità di non poter essere nostalgici verso qualcosa di bello. La mia nostalgia comprende merendine, sigle di quiz e cartoni animati, il Pellicano interrato di viale Terza Armata, i condomini costruiti negli anni ‘70.
Non uno spettacolo. Per me insegnare oggi significa, tra le altre cose, educare alla bellezza; a riconoscerla, anzitutto. Quanto ai sogni, essendo figlio degli anni ’80, ossia di un mondo atomizzato e individualista, non posso esprimermi se non a titolo personale. Sogni generazionali forse ce ne sono stati fino al 2001; allora si perse, e punto, finita lì. Ciascuno ha i propri desideri, come i ragazzi di oggi, di cui non posso farmi portavoce. Constato che molti di loro se ne vanno da qui già a 19 anni dopo il diploma.
Quando si parla di poesia narrativa la citazione d’obbligo è “La camera da letto” di Attilio Bertolucci. Ma la poesia che racconta, pur in gabbie metriche rigide, è antica come la letteratura: da Omero, Virgilio, a Dante, Ariosto, Tasso fino al “Giorno” di Parini, il poema è una narrazione in versi.
Tu hai scritto anche un romanzo in prosa, “Le vite potenziali”. Come è nata l’idea di raccontare in versi?
Vero: la narrazione, con Omero e tutta l’epica antica, è nata come poesia, e tale è rimasta in Italia almeno fino alla moda delle novelle in versi di metà ‘800. Certo, nel frattempo era nato il romanzo in prosa, ma da noi faticò a imporsi; non a caso per me scrivere un romanzo in prosa è stata una sfida molto più faticosa rispetto alla composizione di un poema di 8000 versi.
La scrittura di “Perciò veniamo bene nelle fotografie”, nello specifico, mi fu commissionata nel 2010, dopo che la casa editrice Isbn aveva letto le mie poesie e ci aveva intravisto una vena narrativa passibile di sviluppi ulteriori.
Detto questo, a me viene spontaneo esprimermi in versi: la poesia garantisce più libertà, più incertezza, più ombre, e obbliga a prendersi cura del dettaglio, tutte cose a me care.
“I fiaschi” è anche un canzoniere, un canto d’amore ferito, desolato, disilluso, dove il precariato, oltre a quello sul lavoro, è anche quello dei sentimenti. Sei d’accordo?
Sì, certo: una precarietà trascina dietro l’altra. Aggiungerei che oltre alle ferite, alla desolazione e alla disillusione ci sono anche molta rabbia e molta ironia. Rileggendo il libro a circa 15 anni dalla composizione della maggior parte dei testi (che risale agli anni 2005-2007), mi ha colpito la quantità di rancore che contengono, come se avessi avuto bisogno di rigettare gli sfregi che crescere e stabilirsi qui aveva prodotto. Prima hai citato “Cartongesso” di Maino: be’, è un libro nato dallo stesso disagio. Così come i romanzi di
Trevisan.
È come se la violenza con cui in Veneto siamo passati dalla civiltà contadina a quella industriale avesse più che altrove fatto diventare lo spaesamento, ormai del tutto interiorizzato, un potente generatore di lucidità, che ha reso gli scrittori veneti tra i più geometrici e inesorabili in Italia nell’espressione del malessere.

Per la critica – penso alla bella recensione di Daniele Piccini su “La Lettura” – nei “Fiaschi” si sente il clima dei crepuscolari, di Govoni (è il tema della tua tesi di laurea), ma la tessitura delle rime interne rinvia anche a Montale. Quali sono i tuoi più grandi amori in letteratura?
I cosiddetti poeti crepuscolari sono tra i miei prediletti fin da quando li scoprii alle scuole medie: Govoni, certo, ma ancor più Gozzano, e anche Corazzini per un certo tono elegiaco, e tutti gli autori successivi che a quel magistero si sono rifatti, a partire da Pagliarani e Giudici.
Su Montale, che rimane il poeta imprescindibile del ‘900 italiano, seguii il mio primo corso universitario a
Padova, e a tenerlo era Pier Vincenzo Mengaldo: non ho dubbi che quelle lezioni e le letture montaliane di quegli anni abbiano contato molto per la mia poesia, sicuramente nella calibratura delle rime (touché!).
In realtà sulla mia scrittura in versi ha influito anche tanta prosa (se devo fare due nomi dico Luciano Bianciardi e Michel Houellebecq). E tanta musica: credo che una peculiarità degli autori della mia generazione rispetto alle precedenti sia quella di aver subito una forte influenza dai testi musicali, anche, se non soprattutto, in inglese.
Tu sei un insegnante: tra didattica a distanza o in presenza, formule che cambiano da una regione all’altra, come vivi la pandemia e che cosa è cambiato rispetto alla primavera 2020?
La didattica a distanza è il male minore ma non mi piace, non è efficace, non funziona. Rispetto alla primavera scorsa ho imparato a maneggiare meglio gli strumenti che abbiamo a disposizione, ho provato a impostare le lezioni in modo diverso per motivare di più gli studenti, ma al di là di ogni sforzo ciò che
noto, e non senza preoccupazione, è che nel giro di poche settimane quanto è stato imparato a distanza viene inghiottito da una sorta di buco nero cognitivo.
Quasi nulla viene trattenuto. L’altra cosa che mi preoccupa sono i danni psichici di quanto stiamo vivendo: noi adulti abbiamo più strumenti per tamponarli, mentre i ragazzi non ne hanno quasi nessuno, tanto più in
considerazione dell’azzeramento della loro socialità.
Un problema italiano è sempre stata l’incapacità di pensare sul lungo periodo, da cui l’annosa disattenzione verso i giovani. La pagheranno, la pagheremo cara.

L’autore:
Francesco Targhetta (Treviso, 1980) insegna lettere alle scuole superiori. Ha pubblicato il libro di poesie “I fiaschi” (ExCogita, 2009) e il romanzo in versi “Perciò veniamo bene nelle fotografie” (Isbn, 2012).
Nel 2014 ha vinto il premio Delfini e il premio Ciampi, da cui la plaquette “Le cose sono due” (Valigie Rosse, 2014).
Con Mondadori ha pubblicato il romanzo “Le vite potenziali”, nel 2018.
(Francesco Targhetta “I fiaschi” pp. 180, 16 euro, Le Lettere 2020)
Immagini —————————-
Frames
di Lorenzo Marabini

Voce d’autore ——————————-
Il sospiro non serve
Marco Bini, “New Jersey”
di Giovanni Fierro

Raccontare la provincia, partendo dal proprio centro autobiografico, ed esplorando tutte le sue possibili coniugazioni, nel camminare anche sul margine di un qualcosa d’altro, che a volte si sogna e a volte si perde. Ma che è fondamentale per creare il proprio stare, il proprio appartenere.
Marco Bini tutto questo lo fa molto bene, con la sua nuova raccolta poetica “New Jersey”.
Il suo è il documentare il proprio vivere nella provincia emiliana, tra la via Emilia e l’Appennino, in pagine che sanno mettere assieme i frammenti che sono il presente e il passato. E che in qualche modo iniziano a dare figura al tempo che verrà.
“Al capo estremo del tracciato siamo/ dove ai giorni non si attaccano aggettivi,/ siamo deposito e sedimento,// siamo i pezzi che nell’esplosione volano lontano”, sono le sue parole che in apertura di libro danno subito il suo intenso narrare.
Perché è da questa constatazione che Marco Bini trova la giusta intonazione, che gli permette di dire che “Il resto muore e forse torna in certi tagli di luce/ che crepitano il tempo nell’aria, lo animano di nuovo”. Tutto ha il proprio profilo delicato, che non rinuncia ad una identità necessaria, ad un sé che è il primo passo nel mondo: “Continuate a darmi limiti,// spingetemi a frugare nel mucchio del visibile./ Diventate scrittura, accenti sul libro del mondo./ Parole:/ fatevi scrivere, tenetemi in vita”. Serve anche questo.
“New Jersey” è questo invito ad incontrare il preciso momento che si sta vivendo, al fare della provincia anche una occasione unica, perché “Non ci ripeteremo mai in questo sfolgorio,/ mai più saremo così,/ numeri elisi dall’incontro con l’uguale di segno opposto”. Ed è bene ricordare quanto è importante la citazione posta in apertura di libro, firmata da Luigi Ghirri: “Il vero simbolo della provincia è essere incapace di narrare la propria storia”.
Ma in tutto questo dire e raccontare, Marco Bini non può che domandarsi se tutti questi suoi sguardi dedicati alla provincia sono il vero del suo possibile testimoniare, “o sono nodi che venuti al pettine lo spaccano?”.
Eppure, il New Jersey di Maro Bini è il suo trovare che la provincia può essere la terra promessa, tanto biblica quanto springsteeniana, in cui mostrare ciò che si è e ciò che si desidera di diventare.
Ma solo quando si ha la forza di affermare che “Si dovrebbero sorvegliare i sabati mattina di luce/ e tenerezza: qualcuno dovrà pur farlo, perché non io”.
La provincia di “New Jersey” è questo presente dove ogni frammento può trovare la migliore collocazione, per un disegno che non è più solo gesto ma inizia ad essere forma che trova spazio nel suo contesto, ritratto che porta in evidenza la necessità di stare qui, adesso. Forse è questa la vicinanza che si può avere con il proprio io, il sapersi al posto giusto, ma nella consapevolezza “che non sarebbe perdita ma grazia superiore/ spegnere tutto senza averci capito niente”.
E questo grazie al nuovo scrivere di Marco Bini.
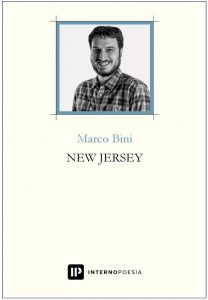
Dal libro:
Poteva finire peggio e la parabola ancorarci al punto
cieco della carta dove l’attrazione non arriva,
il sospiro non serve, la felicità è perfetta e non si regge
invece di farci piovere qui nell’esatto contrario del mare
tra l’erba bassa e il tormento insostenibile dei tralci
nell’alluvione dei campi a matita morbida e tratto leggero.
*
Fermati in un punto e guardati attorno attraverso le sei,
sei e mezzo: le narici bruciano di ossigeno
e la notte sta sparendo veloce. Dove va a finire?
Si ritira nelle ombre e lì prosegue nel primo minuto
del giorno che inizia a sparire: ti si incolla addosso.
Ora sull’asfalto come fuori dalla tenda di Abramo.
C’è freschezza, quasi, e nitore, quando lo scarico del tir
è una prima sigaretta che punge al fondo della gola.
Un esordio eterno a quest’ora il cielo extraurbano emiliano.
Rimani fermo e guardalo mentre supera in azzurro
la comprensione: poi dovresti guardare la luce franare
sui calanchi, è così bella da fermare il cuore.
*
Al Museo di storia tedesca
Mi vedo come li guardo, con quale smarrimento
di ultimogenito gli ultimi vent’anni
che siano valsi la pena, lo sfasciume inquieto
come in attesa del colore, la salita
di gruppo sul podio prefabbricato della storia:
è lo sguardo di chi ha mancato l’istante dell’eclissi.
Vedo cosa accade quando il tempo alza il ritmo
e si raggruma in un punto esclamativo:
la frase dopo vaga in aria in cerca di registro,
è incessata riscrittura, come la città oltre queste stanze.
*
È un’alleanza fatta di pozzanghere
il fondale del fiume dove ghiaia
e pesci mancano e pare scompaia
la pendenza che l’acqua fa rifrangere
sui sassi in mille toni trasparenti
come quello che sfuma tra impressione,
pensiero e questa lingua in dismissione
che si maciulla docile tra i denti,
abrasa dall’interno nel frantoio
della frase, una lingua enucleata
dall’equivoco e scarsa di portata,
discarica indifesa e pisciatoio
senza risciacquo, magra e digitale
lingua ridotta a un gesto attoriale.

Intervista a Marco Bini:
Il titolo del libro fa pensare ad un voler stare altrove. Cos’è, un senso di straniamento o un sogno?
Di sogni, in “New Jersey”, non ce ne sono molti, ma sicuramente c’è un certo lavoro di immaginazione e di proiezione. Il riferimento a un altrove, americano in particolare, nasce sicuramente da un fatto culturale (mi sono nutrito molto di libri, film, musica e storie dagli Stati Uniti), ma è anche il frutto di un’elaborazione, appunto, immaginifica svolta attorno al mio vissuto e alle mie radici.
Nasco e ho sempre vissuto nella provincia emiliana, tra la via Emilia e l’Appennino e “New Jersey” è stato per un po’ di tempo il modo, scherzoso, con il quale tra amici indicavamo proprio i nostri luoghi, perché le nostre attenzioni erano sempre rivolte altrove, dove avevamo l’impressione che ci fosse più luce e la vita promettesse qualcosa che sentivamo mancarci.
Era anche, però, un modo per rivendicare un’identità nostra e specifica, legando il nostro vissuto a racconti e immaginari che amavamo. Lo facevamo con un misto di ironia e serietà che mi è rimasto dentro e mi ha spinto a ripescare questa definizione per parlare di tutte le distanze che separano le nostre vite dalla pienezza che desideriamo: non solo, quindi, la distanza città-provincia, ma pure quella tra la nostra condizione reale e ciò che desideriamo.
Ci sono sezioni, in questa raccolta, che parlano di affetti mancati oppure della sensazione di vivere un tempo senza storia – dunque, poco decisivo e carente di senso –, o ancora della lingua e della poesia come strumento (capace o fallace?) per leggere questa realtà frammentata e divaricata.
Quindi, c’è sicuramente un desiderio di voler stare altrove; ma nella scoperta dell’impossibilità di essere in quell’altrove, inizia anche un’indagine sulle proprie radici. Questa raccolta – il suo titolo, i suoi temi, le sensazioni e le esperienze di cui vi si parla – è pienamente mia, nel senso che mi ritrae nella biografia, nell’immaginario e nelle ossessioni. Credo però che vada a indagare alcuni sentimenti che non sono solo miei, ma che appartengono a tanti, non solo nella mia generazione.
La foto di copertina, inevitabilmente, fa pensare a Bruce Springsteen. Nel caso, c’è anche il desiderio di raccontare una sorta di ‘epica’ della provincia?
Non so se la foto di copertina sia davvero così “springsteeniana”. Io la sento abbastanza vicina a quello che sono: quasi sorpreso e un po’ riluttante davanti all’obiettivo. Ad ogni modo, quella definizione scherzosa che è diventata il titolo della raccolta è, in effetti, anche un omaggio a Springsteen, che con il suo universo di antieroi è sempre riuscito a toccare corde sensibili in me fin da giovanissimo, quasi sentissi una consanguineità con i suoi personaggi disillusi e feriti, ma che non possono smettere di affidarsi al desiderio di un riscatto.
Poi sono arrivate tante frequentazioni decisive: oltre ai tanti poeti importanti per la mia formazione, certi sguardi della mia terra. Delfini, Ghirri, Tondelli, Celati, Rentocchini e, oltre i campanilismi, anche certi poeti romagnoli, come Baldini. E poi, l’innamoramento per poeti stranieri che hanno saputo fare dei loro luoghi marginali il centro di un universo, come Heaney.
Da questi stimoli e da questi incontri nasce quello che, più che un’epica, definirei un racconto dei miei luoghi. Questo perché l’epica ha qualcosa di finalistico, quasi giustificativo: è la narrazione di come le cose sono finite come altro non potevano. Il rapporto con i miei luoghi è invece intessuto di inquietudine e contrapposizione, basato su un senso dell’identità sempre in gioco e mai pacificato. “New Jersey” è anche il resoconto di questo conflitto permanente, dove convivono amore e disamore, dove i miei luoghi sono adorati e fatti a pezzi, raffigurati e trasfigurati.
Per questo preferisco parlare di racconto: è un concetto più aperto e, credo, meno retorico, che può assumere tutte le sfumature che servono e rimanere sempre aperto, senza per forza arrivare a un dunque.
Pagina dopo pagina, la mia sensazione è che questo tuo lavoro sia la voglia di tenere assieme un qualcosa che si è frammentato, che non è vissuto in modo continuo ma a strappi (basta vedere il testo di pagina 14). Può essere così?
Con “New Jersey” ho voluto fare una meditazione sulle distanze che contraddistinguono molte delle nostre vite, forse anche più delle identità. Si tratta di distanze geografiche, ma anche – o forse soprattutto – di distanze esistenziali, di affetti e desideri inappagati o inappagabili, della sensazione di vivere privati della storia (e quindi ripiegati sull’irrilevante).
Quindi sì, scrivo di una realtà frammentata, o in frantumi, vista attraverso il mio filtro di individuo a sua volta frammentato. Nella poesia che citi, ci sono due versi che mi sono cari perché sintetizzano molto dell’intenzione con cui ho scritto tutta la raccolta: “siamo deposito e sedimento // siamo i pezzi che nell’esplosione volano lontano”. In questa immagine violenta ho voluto mettere il sospetto di un caso che, nella sua arbitrarietà, ci obbliga a una certa esperienza della vita che possiamo rifiutare, criticare e nella quale possiamo identificarci – spesso tutto insieme.
Non so se la poesia possa riunificare o ricucire qualcosa; ho sempre faticato a credere in una sua funzione consolatoria. Però può essere un modo per salvare un po’ di quei pezzi sparsi dalla deriva e di costruirci – come dei Robinson Crusoe dell’immaginazione – un rifugio mentale, un ubi consistam, in mezzo all’asprezza della realtà.
I riferimenti biblici sono la volontà di dare a tutti una origine comune, in modo da avere ‘meno distanza’ fra le persone, fra gli accadimenti? Forse è anche un modo per vivere in altro modo uno ‘spaesamento’ che emerge distintamente in queste vite…
Una delle acquisizioni che sono arrivate scrivendo questa raccolta è la capacità di raccontare i miei luoghi, di trovare un linguaggio poetico e delle immagini adatte e che sentissi mie per affrontare un tema che nella mia vita ha molto peso, ovvero quello delle radici e della conflittualità con la quale le vivo.
Le storie e i personaggi biblici esercitano un grande fascino su di me. Senza essere uno specialista, negli ultimi anni ho aperto sempre più spesso la Bibbia. Le figure che ho incontrato e quel modo di raccontare hanno nutrito la mia immaginazione, impastandosi alle altre mie letture predilette. Ho pensato che rimettere in gioco personaggi, frasi o alcuni riferimenti biblici nella mia scrittura poteva aiutarmi a restituire nelle poesie lo stato d’animo, che mi appartiene, del cercatore della Terra Promessa e a posizionare, almeno in parte, fuori dal tempo le esperienze e i momenti di vita dai quali sono nati molti di questi testi.
Forte è anche la sensazione di come “New Jersey” sia un mosaico di esistenze, una moltitudine di realtà/visioni che si riconoscono, e mettendosi assieme creano anche il luogo dove stare. C’è anche questo nel libro?
C’è sicuramente la ricerca (o forse la contemplazione) di una Terra Promessa, intesa come luogo e pienezza dalla quale siamo separati per un “errore di progettazione” della natura umana, che sempre desidera uno stato di grazia senza poterlo mai raggiungere.
Lo sguardo è sempre bene o male il mio: “New Jersey” è sicuramente una raccolta che ruota molto intorno al mio mondo, dove c’è racconto quasi senza personaggi. Però credo che i suoi temi e gli stati d’animo che ne stanno alla base siano condivisi da molti – e alcuni lettori mi hanno dato dei riscontri in tal senso.
Forse il riconoscimento e la creazione di un luogo (mentale, si intende) dove stare, avviene più fuori che dentro il libro, ma comunque grazie (o, forse, a causa) del libro.

Quale il senso della ‘provincia’ che hai vissuto durante e dopo la scrittura del libro? È un luogo marginale o cos’altro?
Nella provincia emiliana sono nato e ho sempre vissuto e, come ho accennato prima, questa è per me una dimensione decisiva che ho voluto mettere al centro di questo lavoro. Oltre ad esserne un abitante, ne sono anche un osservatore: così ho visto questi miei luoghi cambiare nel tempo e rivestirsi di attributi sempre meno nitidi e a fuoco.
Intendiamoci: si tratta di luoghi di benessere e opportunità, quindi il mio non è in alcun modo un “canto del degrado” o il lamento della periferia abbandonata. Tuttavia, le mutazioni antropologiche che si ripercuotono sul modo di essere della provincia si fanno sentire e definiscono la sua identità quasi solo per sottrazione: non è città, non è campagna, non è periferia, non è suburbia, non è quasi più “paese”.
Infatti, come citazione in apertura recupero una frase di Ghirri che rileva come la provincia si distingua per l’incapacità di raccontare la propria storia. Era vera probabilmente all’epoca – anche se quella provincia ghirriana, rivista oggi, sembra invece traboccante di racconto – e lo è ancora di più adesso.
Questa mancanza o latitanza di identità definita ha formato il mio modo di vedere il mondo e mi ha reso attento agli stupori minimi e alle zone indefinite dello spazio e del tempo, un mondo di segnali a cui pochi fanno caso e dai quali mi sento attraversato continuamente.
Il paesaggio è fondamentale in “New Jersey”. Avevi già da subito l’idea precisa del modo in cui trattarlo, il come rappresentarlo e dipingerlo?
No, è stato un’acquisizione che ho voluto inseguire a tutti i costi, quasi programmaticamente, scrivendo queste poesie. Un percorso non semplice che mi ha chiesto, da una parte, di ricorrere a tutti i maestri dello sguardo sui quali potevo mettere gli occhi e che potevano darmi punti di vista sorprendenti; dall’altra di mettere molto in discussione ciò che scrivevo.
Il problema del paesaggio contemporaneo è che non credo ne esista uno più descritto e riprodotto nella storia umana. Cosa posso aggiungere io, allora, con una poesia? Non molto, per cui la visione dei luoghi è diventata sempre il referto di un’inquietudine interiore e di un rapporto tormentato con quei luoghi stessi.
Sei molto critico anche con il linguaggio che si sta usando, che rivela il nostro tempo quotidiano… (il testo di pagina 94)
La raccolta si chiude proprio con una sezione dedicata al tema della lingua – e quindi anche alla scrittura e alla poesia stessa – e alla sua capacità o incapacità di dire bene la nostra vita e il mondo interiore che ci agita.
Inutile dire che, se scrivo, significa che quella capacità perfetta non la vedo: se esistesse e ne scoprissi il segreto, ciò che mi spinge a scrivere morirebbe all’istante. Però è proprio questo processo continuo di cura della lingua che è la poesia ad essere stimolante, talvolta pure esaltante.
Una sorta di missione, che riserva momenti di gioia, ma anche di frustrazione (come nella poesia che citi), e comunque destinata al fallimento nell’impossibilità di dire l’esperienza umana, che rimane sempre più larga dei nostri poveri mezzi linguistici, in ogni suo risvolto. In questo senso, la raccolta chiude con una poesia che è una dolce resa all’impossibilità di nominare, e quindi di comprendere, ogni cosa: “spegnere tutto senza averci capito niente” è il verso finale.
La sensazione, a lettura del libro conclusa, è che tutto “New Jersey” sia un grande e importante lavoro di memoria, di documentazione umana di un qualcosa, ma anche di persone e presenze, che rischiano di essere dimenticati, che vivono sulle proprie vite il peso della Storia con difficoltà e dolore…
È vero, hai colto un punto che per me conta molto. In queste poesie – ma forse, in generale, in tutto ciò che ho scritto finora – c’è sempre una riflessione sul passato e sulla storia.
Credo davvero che la nostra esistenza sia una compresenza di diversi piani temporali: il presente coesiste col passato. I luoghi parlano di sé stessi nel presente, ma mostrano tracce del loro passato in molteplici segni, più o meno visibili; le nostre stesse vite parlano di quello che siamo, ma anche di quello che siamo stati e delle persone che le hanno attraversate (e che ora, magari, non possono più farlo).
Ci siamo noi e, accanto a noi, in qualche modo vive chi ci ha preceduto. C’è il nostro tempo e – anche se siamo sempre meno capaci di leggerlo – c’è la storia che vive in una quarta dimensione che ci circonda, impregna e attraversa. Tra i temi sui quali ho voluto riflettere, c’è proprio la storia – o meglio l’impressione di vivere in un tempo dopo la storia, mentre in realtà è solo una sua sospensione, che vale soprattutto per noi che viviamo in questa parte del mondo. Altrove la storia esiste ancora, eccome, e sta correndo come sempre. È la nostra società che si sta illudendo di poterne fare a meno.
Tra gli effetti di questa illusione, c’è l’impressione – che sono sicuro di condividere con tanti – di vivere in un tempo poco decisivo, dove tutto è stato in qualche modo già fatto e non rimane che raccontare ancora e ancora il passato, con tutti gli aspetti controversi che ciò comporta. Anche questa è una declinazione della metafora del New Jersey: da questi nostri anni a sangue freddo ammiriamo in lontananza la storia a sangue caldo che ci ha preceduti, dalla quale siamo irrimediabilmente separati.
In una poesia, che si intitola “Al Museo di storia tedesca”, ho provato a esprimere questo senso – non so come altro dirlo – di invidia: guardando l’allestimento dedicato alla caduta del Muro nel museo berlinese, osservavo nelle foto e nei filmati tanti giovani in perfetta sincronia con la storia nel suo accadere. Alla mia generazione questa opportunità è mancata.
Non rimane, per ora, che ricucire lo strappo con quella quarta dimensione di cui dicevo prima: per ricominciare a pensare possibile una storia, occorre riconnettersi in maniera profonda alla propria.

L’autore:
Marco Bini è nato nel 1984 e vive a Vignola (MO). Laureato in lettere moderne all’Università di Bologna, ha pubblicato le raccolte poetiche “Conoscenza del vento” (Giuliano Ladolfi editore, 2011) e “Il cane di Tokyo” (Giulio Perrone editore, 2015).
Suoi testi sono apparsi nelle antologie “La generazione entrante” (2011) e “Post ‘900” (2015), entrambe pubblicate da Giuliano Ladolfi editore, e in diverse riviste come Nuovi Argomenti, Poetarum Silva e Poesia del Nostro Tempo.
Collabora con l’organizzazione di Poesia Festival in provincia di Modena.
(Marco Bini “New Jersey” pp. 95, 11 euro, Interno Poesia 2020)
Immagini ———————————–
TUTTUNO
Make me sober flamingo! – Dancing Sardine
di Lorenzo Marabini


Da qui —————————
Elizabeth Barrett Browning, “Sonetti dal portoghese”
Laura Ricci, “Di libertà e d’amore”
di Sandro Pecchiari


Il volume di Laura Ricci, “Di libertà e d’amore”, pubblicato nell’ottobre 2020, presenta una nuova traduzione, con testo a fronte, dei celebri “Sonnets from the Portuguese” di Elizabeth Barrett Browning (London, Chapman & Hall, 1850), preceduta da un saggio introduttivo che ripercorre la vicenda letteraria e umana del canzoniere, ispirato dal sorgere dell’amore sovversivo e liberatorio per il poeta Robert Browning.
Questa nuova versione ci offre l’immediatezza del suo canzoniere in modo più modernamente fruibile, pur prestando somma attenzione al registro elevato della poetessa vittoriana.
Elizabeth Barrett, ritiratasi presto dalla vita sociale per una salute molto cagionevole, si era ridotta ad una esistenza da invalida solitaria. Nella poderosa biblioteca del padre può accedere e fare sua una cultura profondissima assieme all’apprendimento del francese e dell’italiano.
Nonostante i problemi di salute, corrisponde fittamente con letterati e artisti dell’epoca tra i quali Swinburne, Wordsworth, Ruskin, Poe, Hawthorne e Dickinson.
Ma la sua vita viene stravolta felicemente e inaspettatamente da Robert Browning; lei, fragile, malata, ha quasi quarant’anni; lui, più giovane, avvenente, già apprezzato anche se non ancora molto noto. Hanno in comune formazione culturale, predilezioni e moltissime qualità, che traspaiono via via dal gioco serrato delle lettere che si scambiano tra il 1845 e il 1846. Decidono di consacrarsi l’un l’altro e di eludere con una romantica fuga d’amore l’insormontabile divieto del padre di lei, che aveva proibito a tutti i figli di lasciare la famiglia per il matrimonio, pena il diseredarli e la cessazione di ogni rapporto.
Elizabeth era una figura sicuramente coraggiosa, evoluta, anticonformista, ma altrettanto lo fu Robert, e altrettanto esulò dai ruoli e dai canoni maschili prescritti dal suo tempo e dalla società vittoriana da cui entrambi si discostarono. Robert fu colpito e affascinato proprio dagli aspetti di lei, fuori dai rigidi schemi dell’epoca, non temette la differenza di età, la sua salute cagionevole, la maggior fama di Elizabeth che spesso gli fu garbata maestra, lanciando al mondo la sfida di un rapporto non facile, e sicuramente non in sintonia con la cultura patriarcale sempre a sfavore del genio femminile.
Si sposano il 12 settembre 1846 e se ne fuggono verso un’Italia in via di riunificazione, lui, lei, la cameriera e l’insostituibile Flush (l’amato vivace cocker spaniel che Virginia Woolf renderà celebre scrivendo, un ritratto biografico di E.B.B. attraverso la biografia del cane), con pochissime cose, tra cui le lettere che si sono scambiati e i “Sonnets from the Portuguese”, che Elizabeth stava scrivendo in segreto in quel periodo e che erano pressoché conclusi.
Fu un rapporto paritario il loro, una relazione complice e stimolante attraverso il confronto, il commento, le appassionate riflessioni su testi classici, contemporanei, europei e non, sempre soffuso di brio, arguzia, finezza, ironia e autoironia. Qualche volta non sono d’accordo, ma non tentano tuttavia di convincersi l’un l’altra, piuttosto sanno rispettare e apprezzare le diverse posizioni per arricchire la propria personale idea.
III
Unlike are we, unlike, O princely Heart!
Unlike our uses and our destinies.
Our ministering two angels look surprise
On one another, as they strike athwart
Their wings in passing. Thou, bethink thee, art
A guest for queens to social pageantries,
With gages from a hundred brighter eyes
Than tears even can make mine, to play thy part
Of chief musician. What hast thou to do
With looking from the lattice-lights at me,
A poor, tired, wandering singer, singing through
The dark, and leaning up a cypress tree?
The chrism is on thine head, – on mine, the dew, –
And Death must dig the level where these agree.
*
Siamo diversi, diversi, o Cuore nobile!
Diversi nei destini e negli usi di vita.
I nostri angeli custodi con aria stupita
si guardano, quando le ali in volo mobile
si incrociano. Tu, un ospite appetibile
delle regine, della loro pompa infinita,
che ogni sguardo da occhi più brillanti invita
dei miei sempre in lacrime, a fare, abile,
da primo musicista. Perché mai guardare
me tu dovresti dalla tua grata illuminata,
me, povera stanca raminga poeta, cantare
nell’oscurità a un cipresso appoggiata?
Rugiada sulla mia fronte – a livellare
sarà la Morte – dal crisma la tua è baciata.
Si riconoscono con grazia nel gioco dialettico nell’interesse per la contemporaneità, discostandosi dai modelli della tradizione poetica e spostando l’ispirazione alle questioni sociali e alla semplice vita quotidiana.
Il loro è stato un rapporto che ha potuto realizzare le scelte di vita che condividevano: scrivere, amare, vivere, quindi diventare estremamente consapevoli di quanto e cosa desiderasse, assieme all’ambizione e alla volontà di realizzarla, muovendosi nell’ambito di un diritto alla libertà che non era per niente scontato nei decenni in cui vissero.

XLIII
How do I love thee? Let me count the ways.
I love thee to the depth and breadth and height
My soul can reach, when feeling out of sight
For the ends of Being and ideal Grace.
I love thee to the level of everyday’s
Most quiet need, by sun and candlelight.
I love thee freely, as men strive for Right;
I love thee purely, as they turn from Praise.
I love thee with the passion put to use
In my old griefs, and with my childhood’s faith.
I love thee with a love I seemed to lose
With my lost saints, – I love thee with the breath,
Smiles, tears, of all my life! – and, if God choose,
I shall but love thee better after death.
*
Come ti amo? Lascia che i modi conti. Ti amo
fino alla profondità, al respiro, all’altezza
che l’anima mia sa raggiungere, quando anela
ai confini dell’Essere e dell’ideale Grazia.
Ti amo nella quieta necessità di ogni giorno,
alla fiamma del sole e della candela. Ti amo
nella libertà, come chi lotta per la Giustizia;
nella purità, come chi dal Plauso rifugge.
Ti amo con la passione che consumavo
nei miei antichi affanni, con fede di bambina.
Ti amo con quell’amore che perduto credevo
con i miei perduti santi – Ti amo col respiro,
i sorrisi, le lacrime di una vita intera! – e
se vorrà Dio, meglio dopo la morte ti amerò.
Il fascino della loro straordinaria vicenda sentimentale ha offuscato ben presto il valore profondamente innovativo del dettato poetico di Elizabeth Barrett, fino a farla dimenticare per un lungo periodo. Viene riscoperta dalla critica femminista del XX secolo che, a partire da Virginia Woolf, evidenzia la qualità puramente letteraria della scrittura di Elizabeth.
Nel suo recente studio Ilaria Rizzato ha evidenziato i rimandi continui tra l’epistolario e i sonetti, come se fosse un gioco di specchi: in una trasposizione delle lettere sue e di Robert:
XXVIII
My letters! all dead paper, mute and white!
And yet they seem alive and quivering
Against my tremulous hands which loose the string
And let them drop down on my knee to-night.
This said, – he wished to have me in his sight
Once, as a friend: this fixed a day in spring
To come and touch my hand… a simple thing,
Yet I wept for it! – this,… the paper’s light…
Said, Dear, I love thee; and I sank and quailed
As if God’s future thundered on my past.
This said, I am thine – and so its ink has paled
With lying at my heart that beat too fast.
And this… O Love, thy words have ill availed
If, what this said, I dared repeat at last!
*
Lettere! candida carta che sembra tacere!
ma mute non sono fra le mie mani tremanti
e parlano nella mia notte vive e vibranti
mentre dal nastro al ginocchio le lascio cadere.
Una diceva – come amica mi vuole vedere:
per venire a sfiorare le mie mani palpitanti,
un’altra di primavera giornate alitanti
sceglieva… un nulla, ma ho pianto di piacere! –
Cara, ti amo… tenue la carta scandiva;
e caddi, come se divino futuro furore
tuonasse sul passato. E quel, Sono tuo – sbiadiva
a lungo tenuto al battito rapido del cuore.
E questa… questa sarebbe stata vana missiva
se osassi ripetere le tue parole, Amore!
ma anche in eco con versi e metafore da altri poeti, come ad esempio in un sonetto dei più avvincenti e giocosamente sviluppati: il sonetto XIX, ad esempio, allude al dramma shakespeariano il Mercante Di Venezia e a quanto Browning, citando Shakespeare, aveva affermato in un’altra lettera. Anche in questo caso con grande ironia, libertà e innovatività: perché oltre all’ardire dell’amata, che si pone su un piano giocoso di parità chiedendo “ciocca per ciocca”, la ciocca dell’amato non ha nulla a che vedere con le classiche ciocche dorate dei canzonieri petrarcheschi, ma: “è così nera, amore!”.

XIX
The soul’s Rialto hath its merchandise;
I barter curl for curl upon that mart,
And from my poet’s forehead to my heart
Receive this lock which outweighs argosies, –
As purply black, as erst to Pindar’s eyes
The dim purpureal tresses gloomed athwart
The nine white Muse-brows. For this counterpart,…
The bay crown’s shade, Beloved, I surmise,
Still lingers on thy curl, it is so black!
Thus, with a fillet of smooth-kissing breath,
I tie the shadows safe from gliding back,
And lay the gift where nothing hindereth;
Here on my heart, as on thy brow, to lack
No natural heat till mine grows cold in death.
*
Ha il Rialto dell’anima i propri venditori;
ciocca con ciocca baratto a questo mercato
e al cuore giunge, dalla fronte del mio amato,
un ricciolo che supera di Argo i tesori –
di scura porpora, come quella che agli albori
Pindaro cupa vide nelle brune purpuree
trecce delle Muse dal bianco incarnato.
Dunque… suppongo ancora indugi, degli allori
l’ombra, sul tuo ricciolo, è così nero Amore!
Con un nastro di amoroso respiro dolcemente
annodo l’ombra e la ripongo in cuore:
al sicuro, perché non debba volteggiante
svanire, sul mio petto, perché calore
ne prenda fino alla morte raggelante.
Il volume di Laura Ricci recupera ed evidenzia, sia nel saggio che nel compito traduttivo, e restituisce con un’impostazione di colta, appassionata e ironica modernità l’intenzione e lo stile dell’opera originale. Questa nuova traduzione “da poeta a poeta” opera una vera ricreazione di questo celebre canzoniere tenendo ben presente quanto, in esso, l’amore venga cantato a voce alta per esprimere sia il valore salvifico e il lieto fine della storia sentimentale, sia la libertà che la poetessa si prende, in piena epoca vittoriana, nel superare e rinnovare in modo estremamente personale e moderno la tradizione letteraria dei canzonieri d’amore.
Il miracolo della sua poesia risiede, scrive Laura Ricci, proprio nel fatto che alla lettura tutta la sua cultura e erudizione non intralciano e non hanno predominanza: sostenute da un formidabile lavoro innovativo di visione e di stile e, non ultimo elemento, dalla sincerità e dall’onestà dell’esperire e del sentire, e sanno diventare puro corollario dello spirito dionisiaco che brucia e pervade la poeta, così da farle comporre un testo che va ben oltre l’epoca e l’esperienza personale, come un archetipo senza tempo della forza rigeneratrice dell’amore.
Le autrici:

Elisabeth Barrett Browning nacque nel 1806 a Durham. Visse un’infanzia privilegiata con i suoi undici fratelli.
Non ancora adulta, aveva già letto Milton, Shakespeare e Dante. La sua passione per i classici e i metafisici fu bilanciata da un forte spirito religioso.
Fra il 1832 e il 1837 la famiglia Barrett si stabilì a Londra.
Nel 1838 fu pubblicata la raccolta “The Seraphim and Other Poems”. Nello stesso periodo, Elizabeth Barrett ebbe gravi problemi di salute che la resero invalida agli arti inferiori e la costrinsero a restare in casa e a frequentare solo due o tre persone oltre ai familiari.
Nel 1844, l’uscita dei “Poems” la rese una delle più popolari scrittrici del momento. La lettura della sua raccolta di poesie spinse il poeta Robert Browning a scriverle per manifestare il proprio apprezzamento.
Nel 1845 si incontrarono e poco dopo si sposarono di nascosto e fuggirono insieme a Firenze dove ebbero un figlio, Pen.
Elizabeth Barrett Browning pubblicò in seguito “Sonnets from the Portuguese” (1850), “Casa Guidi Windows” (1851), “Aurora Leigh” (1856) e “Poems before Congress” (raccolta dei suoi poemi, 1860).
Fu una grande fautrice del Risorgimento italiano.
Morì a Firenze nel 1861. È sepolta al Cimitero degli inglesi di Firenze.

Laura Ricci, scrittrice e traduttrice, fa parte della Società Italiana delle Letterate e collabora con varie riviste e quotidiani, tra cui Letterate Magazine, Leggendaria, Il Ponte rosso, Articolo 21.
Con le edizioni LietoColle ha pubblicato le sillogi “Voce alla notte” (2006) e “La strega poeta” (2008), e i dodici racconti di “Dodecapoli” (2010).
Con il volume “Io sono una Rosa” (LietoColle, 2013) si è cimentata nella traduzione dal francese, dall’inglese e dallo spagnolo di diciotto grandi poeti e poete.
La sua raccolta poetica più recente è “Rose di pianto” (La Vita Felice, 2017).
Con le edizioni Vita Activa ha curato la “Guida sentimentale di Orvieto” (2018) e il saggio “Sempre altrove fuggendo. Protagoniste di frontiera in Claudio Magris, Orhan Pamuk, Melania G. Mazzucco” (2019).
(Elizabeth Barrett Browning “Di libertà e d’amore. Sonetti dal portoghese”, a cura di Laura Ricci, pp. 166, euro 14, Vita Activa Edizioni 2020)
Immagini ———————————–
ritratti
La figlia del signor L
di Lorenzo Marabini

Tempo presente —————————
Ogni libro è un labirinto
La biblioteca di Babele da Borges a Dante
di Roberto Lamantea

Borges scrive caleidoscopi, o labirinti di caleidoscopi, dove il caos è ordine, il sogno agisce nella realtà, l’ombra è corpo, la scrittura riscrittura infinita, l’aritmetica e la geometria disegnano il caso e il caso è un’equazione matematica. Naturalmente la biblioteca è Babele e Babele è una biblioteca. E il paesaggio è uno specchio.
La scrittura di Borges è una ragnatela, ma non è detto che sia lui il tessitore – il ragno. Borges interseca Poe e Babilonia, i classici greci e latini e la Bibbia, gli alfabeti antichi e la psicanalisi, la fisica e l’immaginario, la citazione erudita con quella di fantasia: archeologo dell’inconscio, entomologo dei fantasmi.
Un libro è un labirinto, diceva Borges, e l’insieme dei libri è la Babele dei labirinti. Ma, annota il grande scrittore argentino scrivendo dell’immaginaria Tlön, l’errore è indulgere al “rigore di scacchisti, non di angeli”.
Rileggere Borges è sempre una gioia, un piacere dell’intelletto insieme perfido e angelico; così è un piacere sottile scoprire i rinvii tra autori e libri tra loro lontani. “Pierre Menard, autore del Chisciotte”, dedicato a Silvina Ocampo, è un racconto del 1939 raccolto in Finzioni (1944). In una nota della bella edizione Einaudi del 1985 negli “Scrittori tradotti da scrittori”, che riprende quella dei “Gettoni” del 1955, (la magnifica traduzione è di Franco Lucentini) Borges scrive: “Ricordo i suoi quaderni a quadretti, le sue nere cancellature, i suoi peculiari simboli tipografici e la sua scrittura da insetto”. Di “delicati, silenziosi, insettiformi caratteri di stampa” scrive Stefan Zweig in “Mendel dei libri” (trad. di Ada Vigliani, Adelphi 2008).
In uno dei racconti più belli del libro – e più famosi di Borges – “Il giardino dei sentieri che si biforcano”, lo scrittore parla del tempo: “A differenza di Newton e di Schopenhauer, […] non credeva in un tempo uniforme, assoluto. Credeva in infinite serie di tempo, in una rete crescente e vertiginosa di tempi divergenti, convergenti e paralleli. Questa trama di tempi che s’accostano, si biforcano, si tagliano o s’ignorano per secoli, comprende tutte le possibilità”. È quanto scopre il protagonista, un io autobiografico, del bellissimo racconto di Claudio Magris “Tempo curvo a Krems” (Garzanti 2019), che ritrova una persona del passato che credeva di aver dimenticato – un amore – e il confine tra tempo trascorso e tempo presente si assottiglia (anche se il tema del tempo, naturalmente, attraversa tutta la filosofia e la letteratura).
Nello stesso racconto di Borges il protagonista riflette: “…ogni cosa, a ognuno, accade precisamente, precisamente ora”.
“And all is always now” è un verso di Eliot nei “Quattro quartetti”, verso che dà il titolo all’ultima raccolta di poesie di Antonio Prete, “Tutto è sempre ora” (Einaudi 2019).
Ovviamente è un’eco di rimandi e di letture (chi non ha letto Borges o Eliot?). Ma resta il piacere del gioco, da bibliofilo, bibliomane, o semplicemente insetto del labirinto.

Ma il gioco diviene ancor più vertiginoso sul tema – teologico e dantesco – del vedere Dio.
Nell’ultimo canto della Commedia, San Bernardo prega Maria perché Dante possa vedere la luce di Dio. Nella narrazione del viaggio ultraterreno il poeta confessa che ciò che ha visto, la visio dei, va al di là delle possibilità umane di vedere e narrare “l’alta luce che da sé è vera”: “il mio veder fu maggio / che ‘l parlar mostra”, vidi molto di più di quanto ora riesco a dire.
La visione di Dio in Dante è come, da sveglio, la memoria del sogno, stupenda l’immagine: “Così la neve al sol si disigilla”: così al sole la neve si scioglie ma anche perde la sua forma.
Borges amava Dante ma amava anche la letteratura e la teologia dell’immaginario (Poe docet). Così nel breve racconto che chiude Finzioni, “Tre versioni di Giuda” (1944), Nils Runenberg, eretico membro dell’Unione Evangelica, rivela che “Dio interamente si fece uomo, ma uomo fino all’infamia, uomo fino alla dannazione e all’abisso”. Su chi pronuncia il nome di Dio o vede il suo volto si abbattono furiose maledizioni: per non vederne il volto Elia e Mosè sulla montagna si coprirono il volto; Isaia atterrì; Saul restò cieco sulla via di Damasco; il rabbino Simeon ben Azaì vide il Paradiso e morì; il mago Giovanni da Viterbo impazzì quando potè vedere la Trinità; i Midrashim “abominano gli empî che pronunciano il Shem Hamephorash, il Segreto Nome di Dio“.
A Babele ogni libro rinvia a un altro, l’ordine di una biblioteca è tessuto da specchi e richiami infiniti (come insegna Roberto Calasso in “Come ordinare una biblioteca”, Adelphi 2020): è vero, la letteratura è un labirinto.
Immagini ———————————–
TUTTUNO
Chela dORATA
di Lorenzo Marabini
Voce d’autore ——————————-
Hai scelto di andare
Donatella Nardin, “Rosa del battito”
di Salvatore Cutrupi

Il libro di Donatella Nardin dal titolo ”Rosa del battito”, fresco vincitore del Premio Internazionale Mario Luzi 2020, è composto soprattutto da poesie occidentali a cui si aggiungono alcune poesie haiku, di origine giapponese, influenzate dal pensiero e dalla filosofia Zen.
Questa particolarità di visione poetica ci fa subito capire quale sia l’humus da cui tra nutrimento l’autrice, che nei suoi versi esplora non solo gli aspetti legati allo sguardo sulla natura, ma anche quelli legati alla rappresentazione dell’animo umano, in tutte le sue declinazioni.
Nel suo scrivere c’è quindi la trasposizione reale di ciò che lei osserva (il qui ed ora) e c’è anche il racconto di un passato, soprattutto autobiografico.
Il tema più trattato nei suoi versi è senza dubbio quello della sofferenza che viene descritta nei suoi vari aspetti, da quello della perdita fisica fino a quello dell’assenza, intesa come abbandono, distacco e delusione amorosa.
Nel poetare della Nardin c’è anche un accenno ad aspetti sociali, come il bullismo e la precarietà e lo sfruttamento nell’ambito del lavoro, temi poco trattati dalla poesia contemporanea e che lei vuole portare all’attenzione del lettore.
Quello che più colpisce della poesia di Donatella Nardin è la concretezza del suo linguaggio, sempre diretto, privo di pietosi sentimentalismi e con minimi ricorsi alle figure retoriche o alle metafore.
Lei mette a nudo la sua anima e ci regala 48 liriche che sembrano scritte per noi o che avremmo potuto o desiderato scrivere. Si tratta infatti di argomenti che fanno parte di quel bagaglio di vita che, in qualche modo, tutti ci portiamo dentro e che rivelano la fragilità dell’essere umano, quando s’inoltra sulla strada dei sentimenti.

Dal libro:
Haiku
Casa di nonna-
dai cassetti sbocciano
baci e mughetti
*
Era di velluto il mattino
Nuota tra le nuvole Venezia
appena oltre le finestre di casa.
Il suo albeggiare è mancanza.
E il mormorio di un cielo sgualcito,
acqua che appare e scompare
reclamando il suo vuoto.
Ad ali aperte un volo altro, o forse
un rimpianto, mela acerba
da addentare dopo che al bivio
hai scelto di andare.
Era di velluto allora- al primo
apparire sopra Venezia-
il mattino.
*
Bullismo
(…)
Sorridimi accanto mamma, fammi
tornare
alla casa delle primavere perdute,
alle lune di latte riemerse dal loro antico
splendore, sbocciando in farfalla, levami
gambe e occhi per farmi diversa
da quella che sono
(…)
*
Se l’amore è la fatica delle mani
(…)
Siamo qui con i fianchi piegati a lottare
la danza del tempo davanti ai cancelli
di uffici e fabbriche chiuse, nell’ignoto
dei giorni che ci fanno essere noi
senza più essere se non un insieme
sommesso di senza lavoro, accerchiati
da un nulla sfuggente di capannoni
industriali ormai vuoti, di braci digitali,
di torni arrugginiti offerti al disperato
mutare del vento.
(…)
*
Haiku
Come farfalle-
mi appoggiavi sul cuore
consolazioni
*
Rosa del battito
Cuori che battono all’unisono
nel petto di un respiro universale
ed è quell’alba chiara che ci crebbe
amici, amanti, fratelli
altro non resta se non l’amore,
rosa del battito
per l’enigma che siamo.

Intervista a Donatella Nardin:
Diversi poeti scrivono contemporaneamente poesie occidentali e poesie haiku, di origine giapponese. Anche nel tuo libro, accanto alle poesie tradizionali, sono inseriti alcuni haiku. C’è un motivo particolare che fa sentire “tue” entrambe queste forme poetiche?
La poesia è per me anche, ma non solo, quel luogo prediletto e necessitato in cui esercitare la libertà del dire e del sentire, e dunque amo cimentarmi con tutto ciò che la parola poetica può offrire, percorrere sentieri diversi, siano essi quelli più classici come quelli un po’ più lontani dai canoni occidentali.
La poesia haiku, nel suo addensarsi in nuclei semantici concisi, nel suo declinarsi in immagini e scene rapide ma intense, suggerite quasi sempre dall’osservazione della natura, offre la possibilità di aderire a una comunicazione interiore che non è solo mentale ma che risulta essere “quella folata di vento che ridesta l’assopito“, secondo la definizione coniata dal grande poeta Matsuo Bashō, uno dei maggiori autori giapponesi di haiku.
Da questo interesse particolare, confortato e sostenuto da un certo numero di giudizi critici positivi e da qualche premio letterario attribuito ad alcuni miei haiku, è nata, nel 2015, la mia seconda raccolta poetica “ Le ragioni dell’oro“ (Ed. Il Fiorino).
Ho mantenuto poi, nelle mie due pubblicazioni successive, l’abitudine di inserire a intarsio qua e là alcune di queste mie composizioni per evidenziare a raggiera situazioni e temi da me esplorati.
“Rosa del battito”: tre parole che sorprendono e stupiscono per la loro bellezza soltanto già nel pronunciarle. Da cosa nasce il titolo del libro?
Spesso la mia voce interiore sceglie per me liberando delle intuizioni che solo sedimentandosi, e traendo linfa e nutrimento da un mio piccolo bagaglio di conoscenze, acquisiscono senso e pregnanza.
Così è stato per “Rosa del battito“, titolo che in sé assomma un topos letterario quale la rosa e lo accosta al battito, che è soprattutto essenza e nutrimento di vita.
In poesia la rosa, cantata e celebrata fin dall’antichità da molti autori, riassume in sé numerosi significati e interpretazioni diverse.
In alcune declinazioni, essa rappresenta la personificazione della grazia e della bellezza oppure il fiore mistico e simbolico che, nel suo sfiorire, dà corpo alla fuggevolezza e alla caducità delle cose.
Con le sue spine, creando risonanze, può sia ferire come recita un bellissimo verso di Francesco Petrarca, ”candida rosa nata in dure spine“, che proteggere dal male e dalle sofferenze.
Il battito poi, unito ad altri battiti insufflati, per chi crede, da un Creatore, simboleggia il ritmo unificante così come l’ininterrotta energia vitale che, nella sua sacralità, sostiene il mondo e l’universo tutto.
Unire le due cose è stato però per me un atto spontaneo, spero efficace, di pura creatività che trova un suo dispiegarsi più chiaro nella poesia che chiude la raccolta.
Il tema della sofferenza è più volte presente nel tuo poetare. Trasportare nei versi la sensazione di “vuoto” è per te una necessità, un’esigenza? È un alleviare il dolore o è solamente qualcosa che accade, un qualcosa che “deve” accadere?
Ognuno di noi, purtroppo, viene colpito nel corso della sua esistenza da lutti, da privazioni affettive e da mancanze dolorose, da quel “sembrami d’aver tra le dita /tutto il peso del mondo“, come efficacemente annota in una sua poesia Sibilla Aleramo.
Ed è in questo accadere, nel respirare a fatica che, nel tentativo di accettare la sofferenza, connaturata al vivere stesso, si è costretti a rivolgere uno sguardo altro alle cose e ad acquisire una maggiore consapevolezza della labilità e della ineluttabilità di tutto ciò che ci circonda.
Non possedendo segreti risolutori, ma solo qualche “storta sillaba e secca come un ramo“ di montaliana memoria, il dolore sordo che non parla ha cercato per me un rifugio e un lenimento nella poesia, nel desiderio, che si deve sempre coltivare, anche se nulla è più come prima, di rivestirsi di nuove speranze e di una nuova forza, sia a livello umano che ontologico.
Intrecciare in poesia i propri pensieri disarmati, le proprie emozioni con il ricordo di chi, pur non essendoci più, rimane dentro e accanto, contribuisce a rinsaldare continuamente il legame tra il visibile e l’invisibile e a concedere una cura a un’anima toccata da molte asperità.

Tra le tue liriche che sottendono la mancanza di qualcosa, si fanno strada anche i colori dei fiori. È una voglia di mostrare la bellezza della natura, oppure è un segnale di speranza da voler condividere coi lettori?
Come osserva con acutezza Riccardo Deiana nella sua prefazione, la mia poesia mostra degli aspetti “tormentosamente floreali “.
Connaturati ai fiori risultano essere i colori che, orientando verso la bellezza e la trascendenza, tentano di allontanare l’occhio e lo spirito dal grigiore di un tempo sospeso fatto di fatiche e disillusioni.
Cogliere nei colori il minuto respiro di un mistero, pronto a farsi suggestione e corpo in perenne movimento e mutazione, è un qualcosa di talmente pregnante nella sua urgenza emotiva da lasciare talvolta senza fiato.
Dato che la mia abitazione è situata davanti a Venezia, alla sua laguna e alle sue splendide isole, percepisco la natura in cui sono immersa come un soggetto dialogante che esprime, nella sua matericità sublimata e trasfigurata, sia l’armonia degli opposti che, nel rispecchiamento, le sue molteplici dissonanze.
Del libro fanno parte anche poesie che affrontano temi come quello del bullismo e dello sfruttamento del lavoro. Pensi che i poeti dovrebbero dare più voce ad argomenti di tipo sociale come questi?
La mia tenta di essere, non so bene con quali risultati, una poesia non di semplice introspezione e di scavo egoriferito quanto anche di relazione che cerca nell’altro, in massimo grado in chi soffre e pena, la propria conferma.
Credo sia doveroso, anche in questo ambito, assumere su di sé ciò che il tempo in cui si vive ci offre, esercitare in questo modo una qualche forma di responsabilità nel tentativo di non far prevalere l’indifferenza rimanendo chiusi egoisticamente nel proprio dire solipsistico.
Questi assunti, secondo il mio modesto punto di vista, hanno la medesima pregnanza e dignità poetica di altri a patto di essere esplicitati senza troppa retorica o patetica sentenziosità.
Aggiungo che forse la poesia dovrebbe dare maggiore evidenza e spazio a tali istanze, in modo tale che chi ha il dovere di occuparsi concretamente di certe tematiche sociali, sia stimolato a farlo con il dovuto impegno e con la giusta tensione morale.
Auspicio utopico purtroppo dati i tempi, ne sono consapevole, ma non per questo destinato alla desistenza.

L’autrice:
Donatella Nardin è nata e risiede a Cavallino Treporti (Venezia). Appassionata da sempre di scrittura, soprattutto poetica, ha ricevuto per questa sua attività numerosi premi e riconoscimenti in diversi Concorsi Letterari.
Per le Edizioni Il Fiorino ha pubblicato nel 2014 la silloge “In attesa di cielo“ (Premio Giovanni Gronchi, Premio Cinqueterre Golfo dei Poeti, Premio Rivalta Roberto Magni, Premio Leandro Polverini).
Nel 2015, per lo stesso editore, ha pubblicato la raccolta di Haiku “Le ragioni dell’oro” (Premio Giovanni Gronchi, Premio speciale della Giuria al Premio Città di Arona) e nel 2017 per Fara Editore la silloge “Terre d’acqua“ (Seconda classificata al Premio Città di Arona, Menzione di merito al Premio Città di Copenaghen, Primo Premio al Premio Il Litorale e Menzione di Merito al Premio Poetika).
La raccolta “Rosa del battito” ha avuto la Menzione d’onore al Premio Lorenzo Montano ed è stata finalista al Premio Tra Secchia e Panaro.
Sue poesie e racconti sono stati inseriti in antologie di Concorsi Letterari, in raccolte collettanee di case editrici come LietoColle, La vita Felice, Empiria, Fusibilia, Terre d’Ulivi, e in alcune riviste di settore anche straniere e in siti on-line dedicati.
Alcune sue poesie infine sono state tradotte in inglese, in francese e in giapponese.
(Donatella Nardin “Rosa del battito” pp. 80, 10 euro, Fara Editore 2020)
Immagini—————————-
TUTTUNO
Lumacone Romagnolo – Vacca Boia
di Lorenzo Marabini


Intervista a Lorenzo Marabini:
La bella sensazione, che si vive subito e in modo immediato, è la tensione che si può percepire tra l’imprinting ‘concettuale’ che sta alla base di ogni sua creazione, e la forma che poi trova (che ha) nella sua versione definitiva. Si ritrova in questo?
Ogni volta che ho affrontato una serie mi è sempre stato necessario cercare riferimenti, assonanze, trasversalità e perfino attenuanti confrontandomi con la storia delle idee, del pensiero umano.
Nell’ambito delle mie possibilità, quell’imprinting per certi versi è presente. Una forma anche. Che poi si riesca a percepire positivamente la tensione tra i due aspetti, al di là delle mie intenzioni, questo mi fa piacere.
“‘TUTTUNO’. Distinguere per unire” si nutre anche di un senso del ‘gioco’. Ma questo scomporre/comporre ha anche altro mi sembra… dà un senso di ciò che è trasformazione, mi viene da dire, in atto. Ha un che di avvertimento, che indica già che i cambiamenti sono in atto…
L’ispirazione della serie è nata nel 2013, ma è ancora in corso, è viva (‘TUTTUNO’ è stato in mostra a Ravenna alla galleria Pallavicini22 dal 16 gennaio al 7 febbraio di questo inizio anno, a cura di Annalisa Cattani).
La mia idea era quella di praticare una combinatoria ispirata liberamente alle suggestioni delle metamorfosi mitologiche, dei bestiari medioevali, fiamminghi… in chiave ludica, ma non sempre. Lo stesso si può dire di un gioco, che può essere anche molto serio.
Riguardo alla trasformazione, mi hanno sempre affascinato certi concetti riferibili ad uno stadio culturale umano ‘prescientifco’ come quelli di ‘Fluidità’ – dove uomo, donna, animali, vegetazione si alternano e si trasformano vicendevolmente – e di ‘Permeabilità’ come assenza di barriere tra il mondo ‘reale’ in cui ci troviamo e quello degli ‘spiriti’ (il mondo irreale, divino, soprannaturale, invisibile).
Dall’antichità le rappresentazioni del mondo animale e naturale paiono essere come un tentativo di oggettivazione della realtà in un rapporto immaginifico tra l’essere umano e l'”altro” da sé, la natura, un mondo fatto di misteri, di pericoli, ma anche di risorse.
Benché siamo ora Homo sapiens (o Technologicus) rimaniamo sempre Homo Spiritualis. Infine, siamo sempre quelli di allora. Siamo ancora a barcamenarci sulla nostra natura e sulla natura stessa dell’Universo.
D’altronde in quelle grotte preistoriche si potrebbero riconoscere gli stessi tori stilizzati di Picasso, il quale apre al contemporaneo ‘tornando’ a una visione metafisica della realtà, oltre al fenomenico visivo.
E a proposito del lavoro “ICTYS” in particolare?
Questo lavoro è nato sotto il primo lockdown. Mi ha impressionato vedere l’incedere del Papa verso un crocifisso antico per chiedere la grazia per l’intera umanità. Una sequenza televisiva che mi ha provocato la sensazione di un salto temporale, un ritorno ad un passato remoto…
Mi sono sempre voluto confrontare con la figura di Cristo, una personalità che mi affascina moltissimo sia storicamente, sia spiritualmente. Ho voluto recuperare l’iconografia tradizionale adattandola alle mie modalità compositive: lavorare per dittici e polittici in una sorta di lavoro di giustapposizione-contrazione. Un tentativo di scardinamento delle certezze, anche visive, delle abitudini.
Lo stesso simbolo del pesce che riporto era rappresentato anticamente all’esterno delle prime catacombe, era un simbolo di riconoscibilità sotto le prime persecuzioni perché acronimo del nome di Cristo figlio di Dio in greco.
Nell’unione tra la figura umana e quella animale, nelle mie intenzioni compio una sorta di “passione condivisa” che risponde per certi versi anche all’invito di Papa Francesco a considerare noi tutti una “nuova ecologia”, in un contesto di mutua necessità e necessaria rispettosa interdipendenza tra tutti gli esseri viventi.
Anche per San Paolo non solo l’uomo è figlio di Dio, ma tutti gli esseri viventi, così per San Francesco…
I ‘gunshots’ hanno in sé qualcosa di violento, il nascere da uno sparo, ma anche qualcosa che ha che fare con ‘l’accettazione’, con il bianco delle tele che sembra ammorbidire ed accogliere questo ‘gesto’ estremo…
La serie dei gunshots on canvas – ‘sHotlines’ – esordisce deturpando la purezza della tela bianca al cospetto della quale a quel tempo volevo provare qualcosa di personalmente nuovo. Ho lasciato i pennelli al loro posto e volevo confrontarmi col ‘grado zero dell’arte’ (quando allora ero ancora affascinato da tutta la letteratura dello stesso Malevic riguardo in particolare al suo quadrato bianco su bianco).
Mi piaceva proprio concettualmente sondare il candore del bianco, interpretarlo. Volevo quindi provare a lasciare sulla tela un segno potente. Ho provato a sparargli contro al poligono, accostando anche due tele per volta (da lì nascono i miei dittici). Il colpo doveva partire dal bordo per vedere come si sarebbe comportato il proiettile colpendo prima il legno e poi la tela, per poi vedere come avrebbe raggiunto la tela successiva…
Dalla risultante ho avvertito un senso di ‘sublime’ nella combinazione rapimento-sconcerto, attrazione-repulsione: il gesto estremo e distruttivo diventava in quel modo attraente come in fondo è nell’immaginario collettivo dei ‘miti’ pistoleri e prevaricatori televisivi, cinematografici e dei videogiochi.. che penso denotino la morbosità schizofrenica del nostro mondo ‘civilizzato’ distorto.
Io ho voluto lasciare una ‘reliquia’, un oggetto ‘sacrificale’ con la memoria del percorso del proiettile, che in un istante è capace di distruggere e al contempo generare una “linea rovente”, un segno creativo, tanto affascinante quanto tremendamente distruttivo.
Nei ‘Frames’ protagonisti sono i film, e i loro attimi catturati in queste tele. Questo rapporto fra realtà e finzione mi sembra che per lei sia molto importante….
In quel periodo mi attraeva il rapporto di interscambio tra arte e cinema, un tema affrontato soprattutto dai registi. In quella fase combinavo di più la mia duplice identità di videomaker e regista con quella di artista visivo.
Mi incuriosiva estendere orizzonti, uscire dai soggetti ‘reali’ o dalle scene di vita ‘reale’. Qui vorrei riprendere uno stralcio da Tobia Donà che mi scrisse a riguardo: “Sono frammenti mnemonici che probabilmente non sono neppure stati scelti ma si sono stratificati per caso in quel cassetto della memoria. Quante volte paragoniamo la vita a un film, tanti episodi composti d’immagini di vita reale o solo immaginata, dei quali ricordiamo solo alcuni, i più intensi. I quadri di Lorenzo Marabini sono Frames di un cassetto della memoria che è di tutti noi, se è vero che la cultura di massa provoca da una parte inevitabili fughe immaginarie dalla realtà, contribuisce anche alla creazione di nuovi miti e nuove immagini dove noi ci riconosciamo, essi sono i fotogrammi di tutta una generazione“.
Nei ‘ritratti’ c’è l’esplorazione di volti e corpi; e sembrano avere una vera e propria forza d’espressione, che li spinge fuori dalla tela, che li muove nel quotidiano della realtà. Questa è una forza che si può controllare? O che si può solamente lasciare esprimere e liberare?
Il ritratto è una modalità che mi avvince ogni volta. Non saprei rispondere alla capacità di controllo o meno. Di sicuro mi piace sondare nei meandri della personalità della persona che ritraggo. Il carattere, lo stile di vita… Non mi basta l’immagine in sé.
Non dico che mi occorrerebbe una sessione di confronto come quella di “Mr Gwyn” di Baricco (un romanzo curiosissimo sul tema del ritratto). Però per la resa, è sempre molto utile conoscersi.
Tutti questi lavori sembra che vogliano ancor di più esplorare il reale, che non si accontentino di ritrovarne la bellezza e il lasciarla esprimere. È come se volessero ridefinirlo, dargli un’altra lettura, costruirne una nuova e rinnovata identità….
La deformazione di cercare di capire il mondo l’ho sempre un po’ avuta. Gli studi di Filosofia Estetica all’Università di Bologna mi hanno poi aperto a scenari inediti con strumenti interpretativi interessantissimi riguardo ad argomenti come il ‘reale’ stesso, l’arte, la storia del pensiero umano in generale. La necessità di lettura delle cose è ormai una mia modalità esistenziale

L’artista:
Lorenzo Marabini si è diplomato al Liceo Artistico di Ravenna e Laureato in Filosofia Estetica all’Università di Bologna (110/110 e lode – con una tesi originale sul rapporto tra Platone e le avanguardie artistiche del ‘900).
Vive e lavora tra Milano e Bologna.
Recentemente il suo lavoro è stato presentato al Milano Licensing Day 2019, a seguito di una selezione a cura di Angelo Crespi per il progetto triennale Popack – art exhibition on packaging.
Ha esposto i suoi lavori a Parigi, Milano, Venezia, Bologna, Ravenna, Faenza e Rovigo.
Le sue opere sono in esposizione permanente presso attività a Bologna (con presentazione di Annalisa Cattani), in storici locali a Venezia e in sedi pioneristiche (ilSole24, 2019) nel campo del design a Milano.
I suoi lavori in Video: EYEROPHANY, Netmage, International Live-Media Festival di Bologna – installazione/evento performativo dedicato a David Lynch in collaborazione con Enrico Ghezzi e Emiliano Montanari; Tying Tyffany – Slow Motion (Nic Endo remix), Bizzarro Film Festival, Bologna e MTV, con Emiliano Montanari.
rivista Fare Voci
curata da Giovanni Fierro
collaboratori:
Roberto Lamantea, Salvatore Cutrupi, Ilaria Battista, Livio Caruso.
ospite:
Sandro Pecchiari




