
Andiamo incontro alla primavera, ben consci di vivere una stagione fragile e a volte molto debole. Un motivo in più per presentarvi questo nuovo numero di “Fare Voci”:
Ad iniziare da un film che è un vero e proprio gioiello: “Piccolo corpo”.
Ce ne parla la sua regista, Laura Samani. Incanto e poesia sono il nutrimento della sua opera.
E poi la voce d’autore di Sandro Pecchiari, che ritorna con le sue nuove poesie di “Desunt Nonnulla”, con Giacomo Vit e “A tàchin a trimas lis as” e con Michele Donati e l’intensità dei suoi testi contenuti in “Il paesaggio nuovo”.
Roberto Lamantea ci porta nei ‘Margini. Di poesia ed altro” per raccontarci di Andrea Zanzotto: del suo oramai classico “Dietro il paesaggio” e del libro che Rosanna Mutton gli ha dedicato, “Le impronte della poesia nel paesaggio di Andrea Zanzotto”. E anche di Luigia Sorrentino e le poesie del suo “Piazzale senza nome”.
Il libroelibro scelto e proposto da Laura Mautone è “Oliva Denaro” di Viola Ardone, e Luca Buiat ci racconta de “La chiesetta di San Lorenzo”.
Gli inediti sono di Francesco Vitale e le dieci fotografie sono firmate da Luisa Sodomaco.
(Sì, c’è molta Trieste in questo numero: Laura Samani, Sandro Pecchiari, Luisa Sodomaco…)
Buona lettura.
Giovanni Fierro
(la nostra mail è farevoci@gmail.com)
Immagini —————————
Aurora, 2021
Dieci fotografie
di Luisa Sodomaco

ilFilm ——————————-
Il tuo corpo se ne dimenticherà, e il tuo cuore anche
Laura Samani, “Piccolo corpo”
di Giovanni Fierro


La storia:
In una piccola isola del nord est italiano, in un inverno agli inizi del ‘900, la giovane Agata perde sua figlia alla nascita. La tradizione cattolica dice che, in assenza di respiro, la bambina non può essere battezzata. La sua anima è condannata al Limbo, senza nome e senza pace.
Ma una voce arriva alle orecchie di Agata: sulle montagne del nord pare ci sia un luogo dove i bambini vengono riportati in vita il tempo di un respiro, quello necessario a battezzarli.
Agata lascia segretamente l’isola e intraprende un viaggio attaccata a questa speranza, con il piccolo corpo della figlia nascosto in una scatola, ma non conosce la strada e non ha mai visto la neve in vita sua.
Incontra Lince, un ragazzo selvatico e solitario, che conosce il territorio e le offre il suo aiuto in cambio del misterioso contenuto della scatola.
Nonostante la diffidenza reciproca, inizia un’avventura in cui il coraggio e l’amicizia permetteranno a entrambi di avvicinarsi a un miracolo che sembra impossibile.
“Piccolo corpo” è un film da vedere. È una realtà che sorprende, un lavoro che ha la capacità di dire.
Laura Samani, la regista, racconta la storia di Agata e costruisce un viaggio che è molto di più di un andare.
Con attenzione e partecipazione in ogni minimo momento, pone il suo vivere al centro del film. Lo lascia crescere, le permette di mettersi in gioco, l’aiuta a credere in se stessa.
C’è incanto in tutto il narrare, ma c’è anche lo sgarbo che la vita fa alla vita stessa, e il quando dove l’essere umano si trova nel dovere di mettere le cose a posto.
Agata ha un futuro che sembra una condanna. E non è un caso che nelle prime immagini (lei e le donne a piedi sulla sabbia, mentre camminano incontro al mare) il suo sguardo si ferma su un orizzonte che non c’è. Di fronte lei non vede uno spazio aperto ma altra terra (banchi di sabbia?); il suo vedere è già bloccato, il suo domani ha già nella carne un nodo.
Ma è a questa condanna che Agata reagisce, crea una vicinanza ancora più profonda con il piccolo corpo senza vita che ha generato; volendo rinascere lei per prima, per dare a sua figlia un respiro, uno soltanto, e un nome. Per consegnarla alla realtà e al presente di un amore materno, assoluto.
“Il tuo corpo se ne dimenticherà, e il tuo cuore anche” le viene detto, ma sua figlia era ed è un sogno, un desiderio; e queste sono intensità che non si possono dimenticare, che lei nella sua decisione vuole portare al compimento, nel rispetto più profondo di sé.
In una vita che è crudele, certo, ma che si accetta se si vuole farne parte.
“Piccolo corpo” è film fatto di silenzi. Che si muovono o aspettano, che nutrono le parole in attesa di essere corpo negli sguardi necessari, che sono l’aria stessa che Agata e Lince respirano. Silenzi che sono anche atti da compiere, promesse fatte a se stessi, luoghi dove poter stare meglio.
Friulano, carnico, italiano, sloveno, dialetto veneto. Sono queste poi le lingue che animano il film, in incontri di persone che si trovano, senza bisogno di traduzioni. Ognuno di loro dice di come la diversità è una ricchezza che amplifica l’ascolto della vita stessa, una necessità per cogliere le sfumature e le variazioni. Che l’anima la si può pronunciare in tanti modi diversi.
Fa bene al cuore “Piccolo corpo”, perché è la constatazione che ogni cosa è sacra, anche la più piccola e apparentemente insignificante; di una sacralità che si muove anche in una certa ‘geografia pagana’, che si intreccia continuamente con la religiosità ufficiale, che trova accadimento e appartenenza, che fa dell’esperienza di Agata, ma anche di Lince a questo punto, una prova irrinunciabile a cui sottoporsi, per dare il valore dell’irripetibilità al proprio vivere.
È un cammino difficile, certo, ma non rinviabile. E il voler dare alla propria figlia quell’unico respiro che la possa far accettare nel mondo, ricorda molto bene il motivo per cui la poesia è viva: il suo dare respiro a ciò che, per molti, non esiste oppure è già morto.
Per sottrazione e per talento, Laura Samani con “Piccolo corpo” porta lo spettatore ancora più vicino al proprio sentire, gli regala fiducia e permette di costruire una nuova unicità.
Per riconoscere un modo di stare nella vita che non si ferma alle regole imposte, ai canoni ereditati e subiti, ma si mette in cammino verso ciò che ancora non si sa. La sfida che permette di trovare l’essenza di sé anche quando il primo orizzonte non ha la forza di liberarsi da solo.
(Nota di merito per le due attrici, Celeste Cescutti (Agata) e Ondina Quadri (Lince), capaci di fare il film con il proprio essere il film)

Intervista a Laura Samani:
Il titolo del film arriva da una scena che poi è stata tagliata. E che aveva anche un tono denigratorio, “è solo un piccolo corpo”. Cosa ha significato invece, nel farsi del film giorno dopo giorno, dare dignità e presenza a quel piccolo corpo e a chi per nove mesi lo ha preparato per il mondo?
Il concetto di piccolo corpo per me non è effettivamente denigratorio. È solo un punto di vista diverso da quello di Agata, un promemoria di disaccordo che le permette di ribellarsi e partire. Credo che molte volte siano proprio le affermazioni che ci offendono a innescare il cambiamento.
Con Celeste Cescutti, che interpreta Agata, abbiamo parlato di insoddisfazione, di un “non è abbastanza” che spinge il personaggio a muoversi e cercare.
Perché la magia assoluta del film, a mio parere, è rendere il primo ed unico respiro della bambina una verità. Perché questo poi ha illuminato tutto il percorso narrativo, ma anche la costruzione artistica e sociale dell’intero film. L’ho vissuto come un azzardo e come un atto d’amore. Sia per la protagonista e la sua storia, e sia per lei regista ed il suo film. C’è qualcosa di veritiero in questa mia osservazione?
Abbiamo a lungo dibattuto sulla questione del miracolo, sia in fase di scrittura con Elisa Dondi e Marco Borromei, co autrice e co autore della sceneggiatura, sia in fase montaggio con la montatrice Chiara Dainese.
Io ho cambiato spesso idea, prima di prendere la decisione finale. Ha avuto la meglio un senso di necessità: volevo una prova di evidenza del miracolo. Volevo che Lince vedesse e noi con lui.
Sì, tutto il film tocca sempre l’intonazione della poesia. D’altronde anche la poesia cerca di dare un respiro a ciò che, per molti, non esiste oppure è già morto. E per questo permette di non avere una ‘distanza di sicurezza’ dalla vita. Si ritrova in questo?
Io parlo raramente di distanze di sicurezza, molto più spesso di prossimità. Quindi sì, mi ritrovo.
“Piccolo corpo” vive anche di profondi silenzi, che permettono alla storia e ai protagonisti di dire e di raccontarsi. In che modo ha affrontato il silenzio, rendendolo necessario al film?
Credo che fosse evidente fin dall’inizio a tutte le persone coinvolte che non si sarebbe trattato di un film verboso. Ma la strada si trova un po’ alla volta. Magari c’è una battuta a cui ti affezioni perché suona bene sulla carta, è poetica, hai trovato un aggettivo puntuale, cose così.
Poi si fanno le prove e quella frase non sta bene in bocca a chi la deve dire. O succede che al montaggio ci si accorge che è molto più forte togliere quella frase, farne arrivare il contenuto tramite uno sguardo.
Il film è un corpo vivo, si crea piano piano con tanti strati e contraddizioni.

Tutto il percorso della protagonista Agata è dentro una religiosità che si nutre anche di credi pagani. Ma la cosa più bella è che si vive un continuo senso di sacralità, legato alla vita stessa, al suo manifestarsi, al suo essere corpo ed appartenenza, irripetibilità. Può essere (anche) così?
Per me sì, assolutamente. Il senso di sacro non è necessariamente legato alla religione.
Ad Agata viene detto “il tuo corpo se ne dimenticherà, e il tuo cuore anche”. Ma sua figlia era il suo sogno, un desiderio, e queste sono intensità che non si possono dimenticare. Difatti, lei le porta fino in fondo, le dà compimento. Penso che questo sia un dire, una esortazione, che è sempre più attuale, sempre più necessaria. Cosa ne pensa?
Penso che sia molto difficile condividere le emozioni nella loro verità. Possiamo verbalizzare le esperienze che ci hanno portato a provare quelle emozioni, ma siamo da sole e da soli a sentire le emozioni e quindi le necessità.
Agata conta solo su se stessa per onorare la sua volontà, senza delegarla ad altre persone. Pensava e temeva di dover fare tutto da sola, e invece incontra Lince.
“Piccolo corpo” è stato girato in uno spazio definito del nord est (la laguna di Carole e Bibione, l’entroterra friulano, la Carnia). Cos’ha di così particolare questa zona geografica? E cosa ha significato girare/lavorare sul territorio?
Io sono di Trieste, della Venezia-Giulia. Sono molto legata alla mia terra e le idee che mi ossessionano, almeno fino ad oggi, sono tutte ambientate lì.
Si tratta di una regione che in uno spazio molto ristretto ha sia mare che montagna, che confina con altri due stati Europei, la Slovenia e l’Austria, una regione che è italiana da pochi decenni e che del suo essere “periferica” ha fatto fortuna e condanna.
Il concetto di periferia è sempre subordinato alla definizione di centro, è un esercizio interessante domandarsi cosa sia “centro” per ognuno di noi.
Cosa ha significato portare “Piccolo corpo” alla Settimana della Critica a Cannes 2021? E cosa è rimasto in lei, donna e regista, dopo aver girato “Piccolo corpo”?
Debuttare alla Semaine è stato bellissimo. Per me ha significato tornare al Festival di Cannes dopo cinque anni, quando nel 2016 ero stata selezionata in Cinefondation con il cortometraggio “La Santa che dorme”. Ciò che mi è rimasto, come sempre direi, sono innanzitutto le persone che hanno viaggiato con me in questi anni.
Penso che, come Agata con Lince, l’insegnamento più grande di questa esperienza sia stato quello di imparare a scegliere i compagni di viaggio.

La regista:
Laura Samani è nata nel 1989 a Trieste. Dopo la laurea in Filosofia e Letteratura presso l’Università degli Studi di Pisa, ha studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia (Roma), corso di regia.
Il suo cortometraggio di diploma, “La Santa che dorme”, è stato presentato in anteprima a Cannes Cinéfondation nel 2016. Da allora, ha ottenuto consensi e premi in diversi festival internazionali.
Nel 2018 ha lavorato per l’Associazione Maremetraggio, conducendo il videolaboratorio partecipativo Città Visibile, finanziato da Siae Bando Sillumina ‐ Periferie Urbane di Valmaura, Trieste.
È il primo laboratorio di questo tipo mai condotto a Trieste, ha coinvolto adolescenti che vivono nella marginalità sociale con l’obiettivo di realizzare un documentario auto‐narrativo.
Filmografia dal 2000:
2015 corto “I Morti Non Sono Tranquilli”: assistente alla regia
2016 corto “La Santa che Dorme”: regia, soggetto, sceneggiatura
2021 film “Piccolo Corpo”: regia, soggetto, sceneggiatura
Il trailer di “Piccolo corpo” qui
Immagini —————————
Diary 2019
Dieci fotografie
di Luisa Sodomaco

Tempo presente —————————
In frammenti di piccole aurore
Cinque testi inediti
di Francesco Vitale

E poi qui
nella dimensione del fare
continuo a stare nella vita.
Traccio le linee
che circoscrivono la mia penombra
e il presente si inabissa
nel cerchio della consuetudine.
Guardo un punto fisso
e tocco le stelle
e il silenzio mi insegna a contemplare
l’infinito vuoto
che nel rumore
cerca la parola.
*
Plano sui miei affanni
e ne faccio
musica compatta
ne faccio
suono composto
di respiro e di soffio
che rigenera la vita.
Voglio vita nuova
ogni giorno, che sia gioia
per il mio essere al mondo
per lo stare ancorato
sulla terra
ed essere grato
sottilmente e lieto.
*
Canto il corpo che rinasce
amplifico la misericordia
nella costituzione del verbo
che si fa pulsante
si fa clima dolce
per la mietitura del bene.
Canto la vita intera
che sta tutta nei vestiti che indosso
nelle infinite parti
che la rendono linfa
di un urrà festoso
preghiera costante
di gioia fertile.
*
Nel flusso solenne
di correzioni e atti
livelli di vita aperta
e chiusure d’onda,
il silenzio traspare
in frammenti di piccole aurore
e chiama la luce
sorella gioiosa
che dell’ora fa preghiera
fa atto duraturo
e ci consegna alla sete
trionfo della vita
in alba grande.
*
C’è alleanza d’amore
sguardi in superficie
che sanno
di pane e silenzio
e adornano l’anima.
C’è fermentazione d’unione
nelle stanze aperte
che contengono
fuoco centrale
in geometrie di luce
rannicchiati al bene.

L’autore:
Francesco Vitale si è laureato nella magistrale di Cinema, televisione e produzione multimediale all’Università Roma Tre.
Ha pubblicato “Una storia dei giorni che passano” (Coessenza 2015) e “Varchi attivi” (Edizioni Erranti 2020). Alcune sue poesie sono state tradotte in spagnolo nel volume argentino “Fragmentos de Humanidad” (Le Pecore Nere Editorial 2018).
Immagini —————————
Self portrait summer 2019
Dieci fotografie
di Luisa Sodomaco

Margini. Di poesia ed altro ————————
Luce fuggita in un mattino
Luigia Sorrentino, “Piazzale senza nome”
di Roberto Lamantea

È un grido raggelato, un urlo muto la poesia di “Piazzale senza nome”, il nuovo libro di versi di Luigia Sorrentino pubblicato nella “gialla oro” di Pordenonelegge/Samuele Editore e composto nel 2017-2018.
A disegnare il “paesaggio” dei versi sono periferie di case popolari, muri, strade e piazzali nella notte, polvere e stracci. È una poesia di tavoli di dissezione che ricorda la luce livida di Gottfried Benn, di liquidi che sgorgano da bocche mineralizzate in una smorfia, neon da obitorio.
Ritorna l’immagine di una capra sgozzata, simbolo biblico e infernale, la “neve” è il bianco mantello invernale ma anche la cocaina – “con la neve depositata nei solchi/ nei crepacci delle vene”, e “vene” è l’anagramma di “neve” – istantanee di cronaca nera: corpi sull’asfalto dopo corse clandestine in moto, rivoli di sangue raggelato, volti che non sono più volti che ricordano la pittura di Francis Bacon, o flash alla Fassbinder (ma senza la rabbia anarchica del regista tedesco).
Eppure c’è una dolcissima pietà in questi versi, un amore silenzioso nello sguardo verso chi giovanissimo ha rinunciato a vivere. La dedica è al padre giardiniere, come le sei righe in prosa che concludono il libro – “Il tuo letto non è al cimitero, nella nicchia con la parete di marmo. […] Tu sei negli utensili che usavi per diserbare il giardino: vanga, zappa, forbici, rastrello, cesoie” – l’esergo è da Plutarco: “La morte dei vecchi è come un approdare al porto, ma la morte dei giovani è una perdita, un naufragio”.
È la morte dei giovani il filo che unisce le poesie di questo libro dove la pietà è nello sguardo, nella matita leggera con cui l’autrice sa disegnare anche la violenza (ci sono un linciaggio, il rivestirsi dopo quello che potrebbe essere uno stupro), un lento dissolversi: “noi che non eravamo mai stati del tutto/ vivi all’amore,/ eravamo caduti sul ciglio della strada/ nella polvere// conoscemmo con cura il perdersi”, nella città dove “di notte il cortile odorava di pianto/ l’attraversarono occhi di cemento e intonaco/ scale morenti senza voce”.
La poesia racconta questo dolore, perché “la maschera è il viso/ la parola è nella maschera/ l’attimo innaturale della bocca/ distorce l’emissione della voce// l’imperfezione/ della parola/ porta nella poesia il difetto/ dell’uomo”.

Dal libro:
vivevi in un comando
in una testa che non era tua
ti ordinava di restare
o di andartene
tutto operava la sua distruzione
nel comando terrestre vacillavi
avvertito dal grembo
la rosa del guardare è affranta
cara vuole sorgerti
nei minuti di recente offesa
– portalo verso la madre
al movimento rapido dell’acqua
dondola il canneto –
*
dal vetro vede la strada
una lingua lucida
limacciosa
spalancata negli occhi
ha fame di notte
l’odore di pioggia senza peso
ha investito il corpo nascosto
l’odore viene dal basso
la suola delle scarpe
non ha consumato
la sconosciuta
profondità del vedere
*
nel giorno del sinistro tacere
chiede di essere ascoltata
getta via il timbro delle ore
amore che ti levi dalla fogna
amore morto, neve nel sangue
ti decompone
l’assalto della città morta
ansia di andare,
la corsa dei fuochi nelle vene
*
la vide per l’ultima volta
a Rione Acquaviva
annunciata da un lampo
luce fuggita in un mattino
sorriso leggero
dura fermezza d’azzurro iride
la faccia dentro la parrucca bionda
nascondeva la testa rasata
sulla via del mare
nell’inganno supremo
dell’adolescenza
lucida, era svanita dagli occhi
prima di entrare nel cuore
*
La notte dei falò
chi sarebbe diventato
se non avesse conosciuto
l’eremita del paese
il ragazzo dalla forza antica
sollevava tronchi da incenerire
nel viso di dio
il sangue del gigante solleva
i guasti
del nostro accadere
l’ingiustizia
richiama una folla di morti
un paese morto

L’autrice:
Luigia Sorrentino è nata a Napoli e lavora alla Rai. Ha fondato e dirige dal 2007 il primo blog della Rai dedicato alla poesia sul sito di Rai News 24 (poesia.blog.rainews.it), con interviste tra gli altri a Derek Walcott, Seamus Heaney, Orhan Pamuk, Mark Strand, Yves Bonnefoy.
Fra le sue più recenti pubblicazioni di poesia: “L’asse del cuore” (“Almanacco dello Specchio” Mondadori 2008), “La nascita, solo la nascita” (Manni, prefazione di Maurizio Cucchi), “Olimpia” (Interlinea 2013-2019, prefazione di Milo De Angelis, postfazione di Mario Benedetti), “Inizio e Fine” (I Quaderni di Stampa2009, 2016, a cura di Maurizio Cucchi).
Le sue poesie sono state tradotte in numerose lingue. Per il teatro ha scritto e pubblicato il dramma “Olimpia, tragedia del passaggio” (2020), una produzione di Napoli Teatro Festival Italia diretto da Ruggero Cappuccio, messo in scena nel Palazzo Reale di Napoli il 16 luglio 2020.
(Luigia Sorrentino “Piazzale senza nome” pp. 102, 13 euro, Pordenonelegge/Samuele Editore, collana “Gialla Oro” 2021)
– la foto ritratto in bianco e nero è di Dino Ignani
Immagini —————————
On the road to my happy place 2017-2018
Dieci fotografie
di Luisa Sodomaco

Voce d’autore ————————-
Piccole omissioni
Sandro Pecchiari, “Desunt Nonnulla”
di Giovanni Fierro

Sono i giorni del ricovero, sono i giorni che dicono dell’attraversare la malattia del secolo, il volere porre fine ad un pericolo, il testimoniare il dolore e trovare la ripresa, il nuovo cammino, il raccontare.
È questo il ricco narrare della nuova raccolta poetica di Sandro Pecchiari, a titolo “Desunt Nonnulla”. Che pone nuovamente l’autore triestino al centro dell’attenzione poetica.
Scandito giorno per giorno, il suo documentare si apre da subito con una geografia che porta alla ricerca di una protezione, quando “le torri a Cattinara sono orchi/ di cemento di mille occhi armati/ i pini corazzati di corteccia/ e resina, bramosi di battaglia”. E ci si può solo chiudere, in cerca di una difesa.
Perché l’epicentro di questa esperienza ha a che fare con la propria vita, con “l’espugnarmi questo figliocancro” che spiega molto bene tutta la tensione che un essere umano è costretto a vivere, fino all’augurata guarigione, fino all’uscita di scena di quello che è un ospite di certo non invitato.
Perché poi si può solo dire che “andrà bene/ che sia un buon lupo/ che sia un bel viaggio/ che stiamo in bocca/ a un qualsiasi dio”; perché a tremare si impara presto e facilmente, quando “è immediato il tragitto dalla pelle all’osso/ non se non siamo affetti dall’addio, dicevi/ nell’afasia riarsa dell’attesa”.
Sandro Pecchiari in questo suo nuovo libro ha la forza di non rinunciare mai alla trasparenza, al mostrare di sé e all’indicare la necessità di un suo nuovo riformularsi, “per questo silenzio suturato”, che di certo può salvare ma che porta con sé le cicatrici di un percorso doloroso.
Queste pagine sono anche un laboratorio dove ripensare alla poesia, alla sua scrittura e al suo concepimento, per rendersi conto che “la punteggiatura è una staffilata/ il punto non è mai una quiete”.
Sandro Pecchiari sa trovare qui le nuove coordinate a cui affidare le sue frasi, le sue sospensioni, i suoi affondo, i suoi andare a capo.
“Desunt Nonnulla” vive anche di citazioni, le più disparate: dal latino a Montale, fino a Cappuccetto Rosso. Ma sono citazioni che l’autore poi ricontestualizza e modifica, le adatta al suo nuovo corso poetico, regala loro nuovo significato e respiro, le fa ancora più sue.
In questo cammino di guarigione, lento anche nei giorni di ospedale, “il corpo scava storie altrui/ intrusioni densi segnalibri”; perché è sempre il corpo il luogo dell’accadere, tanto della malattia che della salvezza. È il luogo del dolore e della convalescenza, è il perché e il come.
E in tutto il libro il poeta si rivolge ad un tu che sempre cambia, che si modifica, che muta direzione e soggetto, ma che non rinuncia mai ad essere necessità e desiderio di vicinanza, anche per confessare che “questo era il mio nome/ storpialo come puoi/ mi fido”.
Sì, la fiducia. È questa la parola magica a cui Sandro Pecchiari affida il proprio vivere e il proprio scrivere, quando ha il coraggio di ammettere che “alle nostre frasi l’aria reagisce come un cane/ qui dentro è il dialogo, non nelle cose dette”. C’è sempre da cercare un po’ più in là, sempre un movimento da fare verso una possibile verità.
E il primo nuovo passo lo si può semplicemente compiere in questo modo: “varco la porta 7D/ in un voile di teli d’ospedale/ la borsa col catetere, il cigolio del porta-flebo/ i collant antitrombo, le infradito gialle”.
Verso la poesia, verso la voglia di stare bene. Verso il giorno che inizia con una parola pronunciata e non più rimandata.

Dal libro:
shavasana è la scansione primitiva
dei non morti, li espone alla gravità
asporta i corpi scelto per salvarli.
certe morti sono più immutabili.
gli oggetti sanno come permanere –
[così parla il sasso se lo pesti
forse il gambo se lo spezzi
dentro il suono il segno dentro
ferma la linfa, il lattice
nel frusciare nel racconto]
così sfolla il cuore
il silenzio
assunto
senza sonno
*
la mia vittoria soffia come un fiume
imprecando agli inferni alterni
del tuo sguardo
sii cenere di tutti i nostri anni.
io suddivido ancora
il sale del sorriso dal sale
che non secca
ti amerò ti amerò
più d’ogni scarto d’acqua
più d’ogni pane secco
*
la sabbia l’acqua
gli alberi di fronte
spuntano il vento
prima della voce
[a questo il torace che si alza
basta sempre altro per vedersi
per rendersi visibili al respiro]
In principio verbum non erat
c’era prima questo suono solo
gutturale e tende il collo, torce
un ciglio che si inclina
l’occhio che suggerisce e mira
anche una mano in sovrabbondanza
vale molto
perché stringe forte
quello che sarà
*
è semplice il dolore
se non si ama non si aggrappa
se non nel divenire
non parole ancora
solo dopo
la prima punta bianca
muta
sillaba
suono
come pane e pesce
in questa lingua di un vincitore ignoto
che ci fa abitare

Intervista a Sandro Pecchiari:
Com’è nato il libro?
Avevo deciso di rimuovere un’esperienza difficile vissuta all’ospedale, sono stato invece esortato a ricostruirla in una specie di diario à rebours da una telefonata gradita e inaspettata di Giovanna Rosadini. Ero piuttosto titubante a ripercorrere i passi delle settimane precedenti. Nonostante la mia risposta affermativa, dubitavo fortemente che ne sarebbe uscito qualcosa, ma le poesie si sono manifestate docilmente e sono fluite senza grossi problemi.
Spesso capita che il libro si strutturi per conto suo nella mente e rimanga latente fino ad un evento scatenante che lo liberi. E così, dopo quella telefonata, seduto su una panchina sotto il sole di agosto, con le poche forze della mia prima uscita da casa, è nata la poesia iniziale, che risulta invece essere l’ultima della collezione, in inglese. Scritta velocemente sul cellulare, come se avesse avuto fretta di uscire.
La prima parte del libro è molto ‘chiusa’ in se stessa, le frasi e le stesse parole che usi creano una tensione, che poi verso la metà si distende, si apre al lettore ma anche al tuo stesso dire. Ti ritrovi in questo?
‘Chiusa’ rende bene l’idea di una persona che si ripiega metaforicamente in un cassetto assieme ai vestiti e agli oggetti del periodo precedente, quasi una spoliazione e un abbandono.
Assieme alla vita, viene deposta con cura anche la lingua quotidiana che si ritrae in silenzio. Una morte rassegnata e con poca speranza senza dubbio. Poi la ricognizione del territorio del corpo, la nuova geografia della pelle e dell’interno, la ‘geomanzia delle cicatrici’ per dir così, rende necessaria l’apertura e la presa di coscienza che si può ancora dire, che se ne può ancora parlare. E lì è iniziata la lotta per trovare il modo.
C’è una parola che mi sembra contenga tutto il libro: figliocancro. È così? E se sì, in che modo?
Il libro ha avuto il suo primo vagito come uno dei tanti libri che narrano di una esperienza complessa, il diario à rebours come suggeritomi in modo accalorato. Ma quasi immediatamente ha preso una direzione per me sconosciuta fino a quel momento: fare i conti con una maternità/paternità di cellule impazzite e in crescita, atte a distruggere il corpo ospitante.
Mi sono affacciato ad una dimensione mitologica di rivalità aggressiva tra padre e figlio senza esclusione di colpi, volta alla reciproca distruzione, in cui comunque la perdita non è alternativa alla liberazione. Senza parteggiare per nessuna delle due parti.
Facile venirne fagocitato e, a dire la verità, non ho opposto alcuna resistenza.
Il libro vive anche di molte citazioni (che in qualche modo ‘adatti’ al tuo scrivere), che vanno dal latino a Montale, fino a Cappuccetto Rosso. Cosa sono, cosa raccontano, una appartenenza, una provenienza?
Nel riporre nel cassetto tutto quanto, la lingua quotidiana in primis, al momento della riapertura sono emersi relitti di ricordi, di svariata provenienza, che sono stati ammassati e rilessicati in situazioni in cui il significato originale viene stracciato e medicato minuziosamente.
Quasi come se ne avessi smarrito i collegamenti culturali e gli spezzoni salvati brillassero autonomamente e volessero una nuova occasione, come se dovessi riprendere in mano quanto conoscevo e risistemarlo in una nuova lettura del mondo che mi veniva offerto.
Io sono sicuramente autoironico quando scrivo, così mi sono lasciato trasportare dalla curiosità per vedere cosa succedeva.

Il libro costruisce paesaggi, già dall’inizio (la sezione “Prima dei giorni”) ne tratteggia uno, nel quale fai entrare anche il lettore. Quanto sono importanti i paesaggi (esterni ma anche ‘interni’) che fai vivere in “Desunt Nonnulla”? E in che modo lo sono?
Il libro è organizzato secondo la scansione ospedaliera dei giorni di ricovero (giorno uno, giorno due e così via). L’osservazione del ‘nemico’ e del ‘campo di battaglia’ viene condivisa immediatamente con il lettore, ma la sequenza temporale non sempre collima con quella spaziale: le poesie si dipanano in una serie di campane di vetro una dentro l’altra.
Si passa dal paesaggio vero e proprio ad una lettura del paesaggio vissuto come posto gradualmente violato: la Val Rosandra, vista dalla finestra della torre chirurgica di Cattinara, appena fuori Trieste, è da molto tempo passaggio per clandestini che tentano di ritrovare una diversa e possibilmente migliore forma di vita. L’esterno, sigillato dalla finestra, si riversa speculare nella stanza e diventa la distanza impercorribile dalla finestra al letto, e poi la barriera della pelle del corpo, l’intromissione del bisturi che ne segna e modifica la geografia, e infine l’interno, simile all’intrusione dei soldati greci nascosti nel cavallo per insinuarsi e distruggere Troia, che diventa strategia di percorsi modificati.
In tutto il libro c’è un ‘tu’ a cui continuamente ti rivolgi. Sembra però non essere mai lo stesso soggetto. Mi sbaglio?
Verissimo, il tu non è quasi mai definibile in questa raccolta: può essere il tu in un monologo, in un flusso di coscienza più o meno coerente, un immaginario visitatore, il mio precedente esserci stato come simulacro in disuso. Ma soprattutto è il dialogo serrato di un figlio che vuol prevalere sul padre e un padre che trama per ucciderlo.
Una ridda di voci non organizzate in uno scorrere inarrestabile di richieste, prese di coscienza, rifiuti, affetto, risposte mancate o non ascoltate, nostalgie e decisioni.
Leggendo questi tuoi nuovi testi, mi sembra che siano anche una riflessione sullo scrivere poesia. Basta pensare al finale di pagina 25, “la punteggiatura è una staffilata/ il punto non è mai una quiete”. È così?
Con la ripresa della parola, ritrovata per necessità di chiedere aiuto agli infermieri, la lingua all’inizio si è addensata sul silenzio, sul respiro, sui suoni e sulle pause tra i suoni. Quindi non solo le parole andavano ritrovate e rilessicate, ma proprio dall’inizio anche i fiati e i significanti che assumevano un aspetto del tutto diverso, più forte e con una loro valenza riconquistata. Praticamente non solo le parole, ma le interazioni stesse diventano linguaggio.
Nel libro uso tre caratteri diversi che suggeriscono le intersezioni e il saltare tra tre piani diversi: il fluire dei pensieri esposti, stampato nel font scelto per la raccolta, un flusso di pensieri appena sussurrato che è scritto più in piccolo e racchiuso da parentesi quadre, i discorsi diretti, detti o uditi, in corsivo che agganciano all’esterno il ‘detto/pensato’ e il ‘non rivelabile’.
Proprio sul ‘non rivelabile’, il non detto, anche se immaginato, si basa il titolo del libro, “Desunt nonnulla”. La scelta felice di Christopher Marlowe che decide di interrompere il suo poemetto “Ero e Leandro” nel momento del primo loro incontro felice, anche se tutti sanno che la storia d’amore avrà un epilogo tragico. E l’autore termina la pubblicazione con la frase “Desunt nonnulla” a indicare che ne manca una parte. Che sia stata una sua scelta o la scelta del suo editore, visto che nel frattempo il poeta era morto pugnalato in una rissa, non lo si saprà mai.

L’autore:
Sandro Pecchiari, triestino classe 1951, è laureato in Lingue e Letterature Straniere, con una tesi sull’opera poetica di Ted Hughes.
Con la casa editrice Samuele Editore ha pubblicato “Verdi Anni” (2012), “Le Svelte Radici” (2013), “LʼImperfezione del Diluvio – An Unrehearsed Flood”, in versione bilingue (2015) e il lavoro antologico “Scripta Non Manet” (2018).
Con le Edizioni Culturaglobale ha pubblicato nel 2019 la plaquette “Camminiamo lenti”, stampa in cento esemplari.
“Le Svelte Radici”, con il titolo “Despojando Raíces”, sono state pubblicate in spagnolo con la casa editrice Uniediciones Sello Editorial (Colombia 2019), con la traduzione di Antonio Nazzaro.
La silloge in inglese “Kidhood” è stata pubblicata nello Special Issue, Writing in a Different Language, NeMLA, Italian Studies, The College of New Jersey, Stati Uniti.USA.
(Sandro Pecchiari “Desunt Nonnulla” pp. 77, 13 euro, Arcipelago Itaca 2020)
Immagini —————————
Brockwell Park, 2017
Dieci fotografie
di Luisa Sodomaco

Libroelibro ——————————-
In strada vado sempre di corsa
Viola Ardone, “Oliva Denaro”
di Laura Mautone


Una struggente storia femminile che muove dalla Sicilia degli anni Sessanta, da una famiglia e da una società patriarcale, in cui la madre si comporta come un padre e ripete ossessivamente, “La femmina è una brocca: chi la rompe se la piglia”, come un mantra.
Tuttavia, questo non salva la protagonista Oliva Denaro, anagramma di Viola Ardone, che appena a 16 anni, proprio quando viene deciso il suo matrimonio con un giovane di buona famiglia, viene rapita e costretta con la violenza ad accettare le attenzioni sessuali di un altro giovane, che già l’aveva importunata per strada. “[…] Io non so se sono favorevole al matrimonio […] Per questo in strada vado sempre di corsa: il respiro dei maschi è come il soffio di un mantice che ha mani e può arrivare a toccare le carni”.
Quasi quasi se lo sentiva Oliva, nell’incerta emozione dei primi batticuore e del primo affacciarsi del desiderio, che sarebbe finita così.
Alla sorella è andata peggio: sposata con un uomo che la picchia, riesce a scappare solo dopo l’ennesimo episodio che le ha fatto perdere il bambino che aspettava. Con l’aiuto silenzioso e risoluto del padre, però, e poi anche della madre e del fratello, che la sostengono, contro il paese e i potenti, le “maleforbici” Oliva riesce tuttavia a ribellarsi agli obblighi medievali cui la tradizione e la legge vorrebbero obbligarla. – “Giustizia è parola scivolosa – dice – […] Ci sta la giustizia della legge e la giustizia degli uomini, che non sono propriamente l’identica cosa. […]”.
Un libro che avvicina alla storia recente e drammatica di molte donne, fino a pochi anni fa considerate ancora, da una legge fatta dagli uomini, proprietà dell’uomo e oggetto esclusivo del loro soddisfacimento fisico, anche contro la loro volontà, che poteva essere riscattato dal “matrimonio riparatore”.
Un no, da solo, può cambiare una vita, e tanti no messi assieme possono cambiare il mondo.
La vicenda termina negli anni Ottanta con la notizia dell’abrogazione degli articoli 544 e 587 del Codice Penale italiano, quando espressioni tristemente note come “delitto d’onore” sono finalmente cancellate dalla pagina della legge.
Quanto ancora ci vorrà perché le donne siano veramente libere di scegliere?
Dal libro:
Liliana smette di scrivere e alza la mano, come faceva a scuola con la professoressa Terlizzi. – La vedova Grasso ha ragione, – dice, – però vedete che qua il torto è anche delle donne. Sono loro a insegnare alle figlie le stesse cose che sono state raccomandate a loro. Se le madri spiegassero ai figli maschi il rispetto della donna, la parità, se permettessero alle ragazze di vivere liberamente e senza chiusure, se le facessero studiare e prepararsi per un lavoro … La mentalità di chi è colpa? Solo dell’uomo o anche della donna? Io penso che deve partire proprio da noi! (p.122)
(Viola Ardone “Oliva Denaro” pp. 312, 18 euro, Einaudi, 2021)
Immagini —————————
Self portraits on washi film
Dieci fotografie
di Luisa Sodomaco

Tempo presente ——————————
La chiesetta di San Lorenzo
di Luca Buiat

Sta sopra ad una costola, sull’orlo di un dirupo
a occidente del Matajur
la scorgi passo dopo passo, lasciando l’asfalto
e ritrovando il cammino sull’erba corrosa dalla siccità
San Lorenzo è un luogo di primule
e meravigliosa solitudine
dove i peri selvatici zampettano sui prati
accanto alla pieve
c’è un paesaggio orientale che freme sul Kanin
Kanin è una parola che sfarina i granelli sui bordi calcarei
è una catena che rotola silenziosa
sui denti di una corona rocciosa
guardiamo il passaggio che fanno le correnti
dentro e oltre il Monte Forato
ci facciamo attraversare dalla valle di Robic
il nastro d’argento che corre sul fiume
il vento si alimenta sulle sue acque,
poi dobbiamo salire ancora sul sentiero
per andare dietro le rocce carsiche
dove c’erano un tempo fa le malghe di Mersino
in ogni estate rifioriva il canto dell’arnica
si mostravano al vento i vestiti candidi della domenica
accanto all’acqua fresca
che scolava dalla pozza terrena.

L’autore:
Luca Buiat è nato a Cormons nel 1971.
Il piacere nei libri lo scopre da ragazzo grazie alla lettura de “La natura ci parla” di Herman Hesse.
Dopo questo libro inizia a scrivere piccoli racconto e poesie.
Appassionato di paesaggi naturali che preferisce attraversarli a piedi o in bici, Buiat pensa che sia già tutto scritto. Occorre a “noi” osservatori percepirne la lingua che sentiamo in mezzo ai nostri passi.
Da qualche anno ha iniziato a frequentare i corsi di scrittura creativa che si tengono all’UNITRE di Cormons.
Immagini —————————
Girls, 2021 cuties
Dieci fotografie
di Luisa Sodomaco

Voce d’autore ——————————–
A son s’ciampàs i dèos, Son fuggiti gli dei
Giacomo Vit, “A tàchin a trimas lis as”
di Salvatore Cutrupi

Il nuovo libro di Giacomo Vit dal titolo “A tàchin a trimà lis as” (Cominciano a tremare le api), edito da puntoacapo, è composto da quattro sezioni, con poesie scritte nella lingua friulana di Bagnarola (PN), dove il poeta vive, accompagnate dalla traduzione in lingua italiana.
I temi trattati sono sostanzialmente due; nelle prime sezioni è presente il tema della disumanità, con il doloroso ricordo di Auschwitz e con le assurdità delle guerre che purtroppo l’invasione russa dell’Ucraina tristemente ci ripropone in questo nostro tempo. Oltre alle atrocità sull’uomo, il poeta ricorda lo sfruttamento degli animali, soprattutto cavalli, asini e muli, spesso mandati a morire accanto ai militari nelle operazioni belliche della Prima Guerra Mondiale, ”In tre, par tre, sempri in tre. /Sent e sincuanta chilos a paròn/ par menà a tocs un canon” (“In tre, per tre, sempre in tre. /Centocinquanta chili ciascuno/ per trasportare a pezzi un cannone”).
La grande tristezza descritta dall’autore, da cui nasce il titolo del libro, è causata dalla constatazione che, anche nella sua terra, vi sono migliaia di api che muoiono a causa dei pesticidi utilizzati dall’uomo con superficialità e indifferenza: “No sai cuma ditilu, Argeo, ma uchì dut a e gambiàt/ e a tàchin a trimà li’ as” (“Non so come dirtelo, Argeo, ma qui tutto è mutato/ e cominciano a tremare le api”).
Il tema ecologico, con la crisi climatica e l’emergenza ambientale, fa riflettere il poeta, così come il perpetuarsi degli incendi dolosi, “I ti scrif da un incendi,/ intant ch’a si cunsùmin,/cuma ciandelis strachis,/lis ramassis dai arbui” (“Ti scrivo da un incendio,/ mentre si consumano,/ come stanche candele, / i rami degli alberi”).
L’ultima parte del libro è dedicata a poeti e letterati friulani della seconda metà del Novecento, alcuni dei quali Giacomo Vit ha conosciuto di persona e con i quali ha condiviso l’amore per la natura e il paesaggio.
Il poeta immagina di avere con loro dei dialoghi e momenti di riflessione che poi trasferisce nei suoi componimenti, con il fervore e la passione del suo scrivere.
Quello che più colpisce nella poetica di Giacomo Vit è il suo essere sempre “dentro” alle storie che racconta, soprattutto in quelle che si riferiscono al mondo naturalistico del suo Friuli.
Con mano lieve ma ferma, trasporta nelle liriche le sue angosce e le sue inquietudini, ma anche il suo sperare e credere in un futuro più buono e più sano, “Crodi in ta l’arba, al so/pleàssi a lis pocàdis/ dal vint, par dopu tornà/ a levàssi in piè” (“Credere nell’erba, al suo/ flettersi agli spintoni/ del vento, per poi tornare/ a rialzarsi”).

Dal libro:
Coru dai umans
I stin spetant la stafeta
ch’a ni partarà il testimoni
da la nustra unanitàt
e tornà cussì a fa respirà
i palmons da la Tiara.
Ma al orizont no si viot
nissun puntin ch’al zema,
nissuna fògula ch’a si sbisìga,
doma il nuia sbiciàt tal doman,
e nualtris ch’i spetàn disvodàs
la pietàt da la pas.
Coro degli umani
Stiamo attendendo la staffetta/ che ci porterà il testimone/ della nostra umanità/ e riprendere così a far respirare/ i polmoni della Terra.// Ma all’orizzonte non si vede/alcun puntino ansante,/ nessuna fiaccola che smania,/ solo il nulla versato sul futuro,/ e noi che attendiamo svuotati/ la pietà della pace.
*
A no si sa
A no si sa, tan chista
vuera, cul vint velenòus
da ’na banda, e lis fuòis
a ponta da chèaltra,
cun chi ch’al sta il FLUN:
chi ch’a ghi noda di sot?
La truta ch’a mena
ta lis sos scais il ben
ch’a ghi è restàt impetàt
dal ON, o il bàbiu palombàr
cu ‘na fòssina di èternit?
A no si sa, tan chista
vuera, sa è ‘na scartela
chè ch’a ti resta in man
par sbarà…
Non si sa
Non si sa, in questa/guerra, col vento velenoso/ da una parte, e le foglie/ appuntite dall’altra/ con chi è schierato il FIUME:/ chi gli nuota di sotto?/ La trota che trasporta/ sulle sue scaglie il bene/ che le è rimasto appiccicato/ dall’UOMO, o lo scaltro palombaro/ con una fiocina di eternit?/ Non si sa, in questa/ guerra, se è carta (da gioco) di poco valore/ quella che ti resta in mano/ per sparare…
*
Coru dai arbui
A son s’ciampàs i dèos,
a è dibant serciàiu ucà,
fantàt ch’i ti vègnis cul to
tablet, scorsàt fin cazù
da lis malincuniis dal to
timp: di sacri a nol è restàt
pì nuia, l’on al à molàt
lis brenis dal so distìn,
adès al cor a stimp par trois
ch’a nol conos, dongia l’orli
dal abìs spalancàt drenti di lui.
Coro degli alberi
Son fuggiti gli dei,/ è vano cercarli qui,/ ragazzo che càpiti col tuo/tablet, sospinto fin quaggiù/ dalle malinconie del tuo/ tempo: di sacro non è rimasto/ nulla, l’uomo ha lasciato/ cadere le briglie del suo destino,/ ora sta correndo alla cieca fra i viottoli/ sconosciuti, vicino all’orlo/ dell’abisso spalancato dentro di lui.
*
Pierpauli
Ti vèvis bisugna, Pierpauli, pal to siun intal mond,
da li ciasis e i tìnars lens ch’a trimin tal rìul,
dai cops blancs di nèif e da la paia cuntra il nul
selèst ch’a si trovàvin doma a Ciasarsa, e in nessun
altri lòuc dal mond… Ciasarsa, il palc just induà
rapresentà la Mari -fruta, Narcìs, il Fantassùt,
Dilio e duta cuanta la miei zoventùt ch’a voleva
fermà il timp dal Friul…Ma la realtàt a no è
un cine, a ni sbusa i vui cui sos claps a ponta,
cun gòtis dùris di ploia, cun ciaviei plomps
di sanc, lontan da Ciasarsa, ta un louc neri
pì di un peciàt.
Pierpaolo
Ti occorrevano, Pierpaolo, per il tuo sogno del mondo,/ le case e i teneri alberi che tremano nel fosso/ i coppi bianchi di neve e la paglia contro il nuvolo/ celeste che si trovavano solo a Casarsa, e in nessun/ altro luogo del mondo…Casarsa, il palco vero dove/ rappresentare la Madre-bambina, Narciso, il Giovine,/ Dilio e tutta quanta la meglio gioventù che voleva/arrestare il tempo del Friuli…Ma la realtà non è/un film, ci fora gli occhi con i suoi sassi appuntiti/ con gocce dure di pioggia, con capelli zuppi/ di sangue, lontano da Casarsa, in un luogo nero/ più di un peccato.

Intervista a Giacomo Vit
In molte poesie si nota chiaramente la tua amarezza nel vedere la natura abbandonata a sé stessa. Negli ultimi decenni, secondo te, è mutato il dialogo tra l’uomo e la natura?
Credo che un vero e proprio distacco fra uomo e natura sia avvenuto con la Grande Guerra. Durante quel terribile conflitto ci fu un vero e proprio sfregio dell’ambiente, con l’inquinamento delle acque e dei terreni a causa delle armi chimiche, con l’abbattimento di alberi per uso militare, con gli scavi nella roccia.
Per non parlare dello sfruttamento e degradazione degli animali (a cui dedico una specifica sezione del libro) utilizzati in missioni pericolose.
Da quel momento storico è iniziato il depauperamento dell’ambiente, che poi, negli ultimi decenni, ha raggiunto livelli intollerabili.
In questo libro, come in altri precedenti, tu metti a nudo la ferocia e la brutalità dei comportamenti razzisti del passato e del presente. Pensi che il poeta abbia anche il compito di risvegliare le coscienze, evidenziando le disuguaglianze sociali e denunciando ogni forma di disumanità?
Bertolt Brecht, in una sua famosa poesia, scrive che “discorrere d’alberi è quasi un delitto”. Dipende dal tempo che ci è stato dato in sorte. In quello attuale credo sia un dovere etico scrivere anche di cose sgradevoli.
Si pensi alle immagini che la televisione ci mostra dei bombardamenti sull’Ucraina, con vecchi e bambini i cui fili del destino sono legati a un bombardiere, o a un cecchino appostato da qualche parte.
Sì, è compito dell’artista (scrittore o poeta, pittore o scultore, musicista o ballerino ecc.) risvegliare le coscienze assopite del secondo millennio.
“A tàchin a trimà lis as”. Da cosa nasce il titolo di questo tuo ultimo libro?
Il titolo è ispirato da un servizio giornalistico apparso su un quotidiano, il quale riportava il contenuto di alcuni filmati girati dalla Guardia Forestale. Veniva mostrato come in alcune zone del Friuli le api stavano morendo a causa dei pesticidi. Nelle immagini si coglieva uno spettacolo drammatico: le api, tantissime, cominciavano a tremare tutte insieme, poco prima di morire. Per ora è toccato alle api, e domani?
Tu scrivi quasi sempre nel friulano di Bagnarola (PN), zona in cui vivi. Qual è l’intimo motivo di questa tua scelta?
Le parole della mia parlata materna sono quelle con cui da piccolo ho imparato a nominare le cose del mondo, la realtà che mi circondava. Esse poi si sono depositate dentro di me, e quando le adopero sono qualcosa di più del corrispondente termine in italiano, hanno una particolare risonanza che contiene in sé la storia della gente, di un luogo, del presidio della memoria.
L’ultima sezione del libro è dedicata a poeti friulani scomparsi, alcuni dei quali da te conosciuti. Questi poeti hanno in qualche misura influenzato il tuo modo di poetare e di osservare il mondo che ti circonda?
Tre di essi (Argeo, Castellani e Pasolini) non li ho conosciuti, per motivi generazionali. Gli altri quattro (Cantarutti, Tavan, Giacomini, Fioretti) li ho conosciuti bene, e con loro ho dialogato in più occasioni.
Quello che mi lega a questi poeti è l’amore per la natura, per il nostro ambiente friulano e per la lingua materna. Si impara sempre leggendo e conversando con altri poeti, ecco perché è importante per chi scrive non isolarsi nel proprio orticello, ma aprirsi ad altri sguardi.
So che da molti anni scrivi haiku e insegni questo genere di poesia giapponese a studenti delle scuole elementari. Si può dire che la natura, “celebrata” dalla poetica haiku, è la protagonista preferita del tuo processo creativo?
L’haiku, per le sue tematiche naturalistiche, ha delle forti analogie con l’ambiente naturale friulano.
Diventa perciò un’interessante sfida e uno stimolo per liberare la creatività, e per invitarci, nella frenesia dei giorni, a riflettere sul tempo che scorre, fissando poi sulla carta gli attimi più significativi.
Devo dire che gli studenti (delle elementari ma anche delle medie superiori) rispondono con entusiasmo a queste sollecitazioni, e i loro prodotti sono a volte sorprendenti.

L’autore:
Giacomo Vit, già maestro elementare di Bagnarola, in provincia di Pordenone, è autore di opere in friulano di narrativa (“Strambs” 1994, “Ta li’ speris” 2001) e di poesia (tra le più recenti “Sòpis e patùs” 2006, “Sanmartin” 2008, “Ziklon B- I vui da li’ robis” 2011, “Trin freit” 2014.)
È uscita nel 2018 per puntoacapo editore la personale antologia “Vous dal grumal di aria”, che raccoglie quarant’anni della sua produzione poetica, alla quale è stato assegnato il premio Biagio Marin.
Nel 1993 ha fondato il gruppo di poesia “Majakovskij”, col quale ha dato alle stampe quattro volumi.
Con Giuseppe Zoppelli ha curato le antologie della poesia in friulano “Fiorita periferia” del 2002 e “Tiara di cunfìn” del 2011.
Ha anche pubblicato anche alcuni libri per l’infanzia in italiano e friulano.
È componente della giuria dei premi “Città di San Vito al Tagliamento”, “Barcis-Malattia della Vallata” e “Pierluigi Cappello”.
È vincitore di diversi premi, fra cui il “Pascoli”, il “Lanciano”, il “Gozzano”, il “Poesia Onesta” e il “Lerici Pea-Paolo Bertolani” assieme al gruppo Majakovskij.
Nei prossimi mesi usciranno le sue traduzioni in friulano di François Villon e un racconto per ragazzi sul tema del razzismo.
(Giacomo Vit “A tàchin a trimas lis as”, pp. 79, 12 euro, puntoacapo editore, 2021)
Immagini —————————
Diary 2022
Dieci fotografie
di Luisa Sodomaco

Margini. Di poesia ed altro ——————————–
L’azzurro di corallo/ dei monti solitudini amorose
Rosanna Mutton “Le impronte della poesia nel paesaggio di Andrea Zanzotto”, Andrea Zanzotto “Dietro il paesaggio”
di Roberto Lamantea

Un famoso verso della “Beltà” (1968) dice: “Ho paesaggito molto”; l’eco è un verso del suo primo libro, “Dietro il paesaggio” (1951): “Qui non resta che cingersi intorno il paesaggio”. Metafora del mondo, sguardo sulla natura e sulla storia, il paesaggio per Andrea Zanzotto ha un confine geografico preciso: “Dico soltanto che sono tremendamente legato a un microterritorio geografico ben definito se voglio scrivere versi (non oso dire poesia). Il tentativo della poesia, e la necessità di questo tentativo, mi s’impongono soltanto entro un territorio, quasi nel senso etologico della parola. La mia connessione con questo territorio è veramente fisica. Là soltanto provo quegli stati d’animo che mi spingono a ricercare come un “contatto”, a ristabilire una circolarità, a ravvivare una memoria, a crearmi una fiducia connessa alla parola”.
La cartografia di Pieve di Soligo: la Cal Santa (casa natale), via Mazzini (la sua abitazione), via Cimitero (il luogo dell’ultima memoria): “il triangolo diventa il fulcro perfetto dentro a mille cerchi concentrici in movimento” scrive Rosanna Mutton nel libro “Le impronte della poesia nel paesaggio di Andrea Zanzotto” (Cierre Edizioni). È il genius loci delle sue passeggiate, una geografia che da Pieve arriva fino al Montello e al Piave, le Prealpi, l’abbazia di Follina, il castello Brandolini d’Adda di Cison di Valmarino: “Ho una geografia di spaventosa precisione. Partendo dal Quartier del Piave, se mi sposto di pochi chilometri non riesco più a pensare una poesia. Posso arrivare fino all’orlo delle colline asolane, ma Asolo è escluso”.
È la Heimat di Hölderlin, il poeta svevo amato da Zanzotto fin dalla giovinezza, nido, amnio, terra natia, guscio, luogo-culla dell’infanzia, dondolante lingua, il petèl, la lallazione preverbale, la danza delle voci familiari nelle rime del Tasso, le filastrocche della nonna, un paesaggio di suoni intimamente legato a quello cromatico, i verdi e gli azzurri dipinti dal padre pittore.
L’azzurro, il colore di tanta letteratura tedesca e mitteleuropea; le lontananze azzurre cantate dallo scrittore svizzero Robert Walser in una magica sinestesia nel romanzo “I fratelli Tanner”: “Le azzurre, sfumate montagne boscose, risonavano come corni lontani” o nella novella “La passeggiata”: l’”azzurrina, biancovelata lontananza”.
In “Dietro il paesaggio” Zanzotto scrive: “l’azzurro di corallo/ dei monti solitudini amorose”; “paradisi di crisantemi/ si addensano in climi azzurri”; “e la neve che v’indugia azzurra”. In “La Beltà”: “azzurro/ più azzurro sui monti”; fino al “sognolìo e luminìo di primavera” in “Pasque e una cinquina” ora ripubblicata in “Erratici”, il libro curato da Francesco Carbognin per “Lo Specchio” Mondadori che raccoglie i testi dispersi del poeta: “Stagione dell’azzurro/ io non ricordo tutte le tue stelle/ ma tutte le tue stelle/ ad una ad una/ ricordano me”. “L’azzurro ci ha già denudati” è sempre un verso raccolto in “Erratici”, sino allo stupendo “luce che in te ti celebri”.

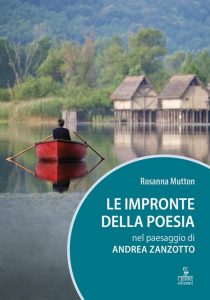
“Le impronte della poesia nel paesaggio di Andrea Zanzotto” è una guida colta e di piacevole lettura che invita a percorrere i luoghi di Zanzotto in compagnia della pittrice Nerella Barazzuol, del poeta Luciano Cecchinel (che ha il suo genius loci a Revine Lago), il geografo dell’Università Ca’ Foscari di Venezia Francesco Vallerani, il poeta, scrittore e critico Gian Mario Villalta; la prefazione è di Francesco Carbognin, dell’ateneo di Bologna, le fotografie di Luigi Dorigo. Il libro nasce dalla tesi “Le impronte della poesia nel paesaggio di Andrea Zanzotto” nel corso triennale di Lettere a Ca’ Foscari nata dal dialogo con la docente Silvana Tamiozzo, correlatrice Michela Rusi.
Come ricorda Villalta, Zanzotto “non era mai alla ricerca del locus amoenus, ma della natura che serpeggiava sui muri abbandonati, nei bordi o nei fossi delle strade urbane, nelle recinzioni dei borghi, nei ritagli di spazi contaminati tra natura selvaggia e governata. Il poeta rintraccia e indaga i graffi, le dolorose incisioni e i segni che l’uomo ha impresso nel paesaggio, assumendo il ruolo di storico e geografo dei luoghi”, sguardo che darà origine al dialogo “In questo progresso scorsoio” con il giornalista Marzio Breda (Garzanti) e al “vagabondare errando qua e là per crinali, per valli, gole, fino all’incrudelirsi delle vette” da cui nascerà “Fosfeni”: “Sono ghiacci, geli, nebbie, galaverne, nevi e colori (ori, blu, viola, rosa o azzurri) in cui qualcosa trabocca, guardandolo oltre la sua stessa presenza”.
Per il doppio anniversario zanzottiano del 2021 (cento anni dalla nascita, dieci dalla morte), l’Università di Padova ha ristampato, in una bella edizione graficamente curata dall’officina dell’editore vicentino Ronzani, “Dietro il paesaggio”, con una bella introduzione, “Il grembo e il fosforo”, di Emanuele Zinato, docente di Letteratura italiana moderna e contemporanea all’ateneo patavino, e una pirotecnica postilla di Francesco Maino (qui).

Scritto tra il 1940 e il 1948, quand’era studente dell’Università di Padova (1938-1942), pubblicato da Mondadori nel 1951, “Dietro il paesaggio” è già un titolo-manifesto di una poetica e di uno sguardo che, attraverso la lingua e l’analisi anche psicanalitica della scrittura, porterà Zanzotto ad essere la voce più innovativa della poesia italiana del secondo Novecento.
Al di là del noto rifiuto della neoavanguardia del Gruppo 63 (e dei suoi nipotini), vale il giudizio di uno studioso come Gian Luigi Beccaria in un articolo su Tuttolibri della Stampa di Torino dell’8 ottobre 2011 scritto per i 90 anni del poeta (10 ottobre): “Il suo sperimentalismo è risultato diverso dalla baldanza dell’avanguardia. […]. Penso che sia lui ad aver rappresentato l’autentica avanguardia del secondo Novecento. Come l’avanguardia, ha rotto i consueti canali della comunicazione ma senza obbedire a una presa di posizione ideologica, a una scelta aprioristica che preceda il fare, a una scelta prevista, preparata a tavolino: tutto gli nasce dentro il testo, nella partita che il poeta ha ingaggiato con la propria scrittura […]. Zanzotto è stato un maestro per tutti gli ordini e i registri della lingua”.
La copertina del libro, “Colline”, è del pittore coneglianese Giani Sartor, che ha firmato tre diverse versioni del disegno. Tra l’altro l’Università di Padova aveva già curato nel 2015 la ristampa anastatica della tesi di laurea dattiloscritta di Zanzotto, “L’arte di Grazia Deledda”, discussa con il prof. Natale Busetto nel 1942 e che resta un unicum nel lavoro di Zanzotto critico, che non si è mai più occupato della scrittrice sarda.
Nella prefazione Zinato offre un saggio perfetto per leggere non solo “Dietro il paesaggio” ma tutta l’opera zanzottiana che, anche dallo sperimentalismo della “Beltà” (1968) fino al “Galateo in bosco” (1978) e “Conglomerati” (2009), con l’irruzione dei segni grafici – come i profili dei monti sulla pagina – ha il tema del paesaggio come filigrana.
Già da questo libro, scrive infatti Zinato, il paesaggio è “distillato come dimensione dell’origine”, lo spazio è l’io, attraverso Leopardi e Hölderlin arriva alla Heimat come luogo dell’infanzia, dell’origine e di una felicità perduta.
È “Dietro il paesaggio” di Zanzotto a segnare una svolta – sfida aperta per la storiografia letteraria – nella poesia italiana del secondo Novecento e di questo scorcio del nuovo millennio.
(Rosanna Mutton “Le impronte della poesia nel paesaggio di Andrea Zanzotto” pp. 168, 14 euro, Cierre Edizioni 2021)
(Andrea Zanzotto “Dietro il paesaggio” pp. 108, 19 euro, Padova University Press 2021)
Immagini —————————
Too many parties in December
Dieci fotografie
di Luisa Sodomaco

Voce d’autore ———————————–
Chiama falso tutto quello che ignori
Michele Donati, “Il paesaggio nuovo”
di Giovanni Fierro

Il Monte Tondo è una cava, dal 1958 sono iniziate le attività estrattive, la Vena del Gesso è un affioramento unico in Europa e si sviluppa per venticinque chilometri nel territorio collinare romagnolo.
Ed è in questo punto preciso che prende vita lo scrivere de “Il paesaggio nuovo”, la raccolta poetica di Michele Donati.
E qui troviamo il lavoro con tutta la sua importanza e la sua condanna, il suo essere fulcro e dannazione della società. È il metro perfetto per misurare lo stato attuale della nostra società, e Michele Donati lo fa nel migliore dei modi, sottolineando da subito che “i lavoratori della cava/ sono coraggiosi/ anche senza adeguarsi/ alle norme/ sulla sicurezza e sull’orgoglio/ di appartenere alla multinazionale”.
È questo l’inizio de “Il paesaggio nuovo”, che si muove in tre tempi, capaci di indagare il nostro presente contemporaneo e di mettere a nudo la presenza umana.
Perché “spaccano le pietre del monte tondo/ trasformano i detriti in possibilità/ se è di questo che stiamo parlando/ di possibilità/ ne esistono infinite/ così come i detriti”, ma è il vuoto che rimane a diventare il l’assenza che si respira, che si riconosce nel più profondo di ciò che l’essere umano è adesso.
Che l’orgoglio è sempre una brutta bestia, “in europa non vi è/ polo estrattivo che possa/ competere con il nostro”, mai doma e sempre selvatica, difficile da ammaestrare; e questa dimensione diventa ben presto strategia di controllo e di annientamento, nel nome della produttività e del guadagno. Dei pochi, degli altri soprattutto…
Così la realtà inevitabile è quella di vivere uno smarrimento, “dove sono andato/ non riesco più a trovarmi/ nei luoghi che mi sono cresciuti/ dentro”, che non si può più né asciugare né nascondere. Diventa la dimensione di ogni giorno, lo stare al mondo a cui ci si abitua, ma che piano piano erode dal di dentro ogni sentire sensibile.
Perché poi si accetta anche il paesaggio a cui si è destinati, in cui si sono persi i contatti con l’altro e con se stessi, dove “le antenne sono sacre e inviolabili/ totem della comunicazione/ a loro va il coro a bocca chiusa/ di noi imbalsamati/ nella vita/ che ci sembra/ sempre/ un’altra cosa”.
E si sta un attimo a vivere ogni comunicazione come un senso di appartenenza, ma che si muove a debiti e prestiti, ormai clienti e non più cittadini, dove si vive solo di un “sogno che si riproduce/ e non esiste”, ma che costa e soffoca. Tutto è più fragile, tutto è fagocitato e trasformato, in qualcosa che comanda e si fa ubbidire.
E allora non si può che ritornare nella caverna, quella di Platone, dove è bene dire “ascoltaci/ la libertà è un concetto arbitrario/ che molti aggirano senza conseguenze/ dunque tu ignoralo e//chiama vero tutto quello che vedi/ chiama falso tutto quello che ignori”.
Le “ombre” sono qui, in un attrito di consapevolezza e degrado sociale, in queste pagine che Michele Donati, uomo di teatro, sa mettere in scena e porre all’attenzione di ognuno di noi.
L’oggi è in queste sue nuove pagine, dove il paesaggio nuovo è un nodo da sciogliere, aperto al tempo che verrà, legato a ciò che è stato finora.

Dal libro:
nel mare di grano
uomini subtropicali
vanno come fantasmi
le buste di plastica in mano
la valle è una gola vasta
percorsa dall’elettricità
non puoi che parlare
infinite lingue
*
una di queste è la lingua del gesso
l’occhio del gesso la mano
del gesso
il cuore il pube
del gesso
la vena del gesso
che scorre di sangue nel cielo armonico
degli abissi
*
per i sindacati è inammissibile
mettere in discussione
più di ottanta
più di cento
posti di lavoro
anche gli occupati
dovranno mangiare
spezzarsi le ossa
respirare le polveri
sono diritti inalienabili
sanciti dalla costituzione
l’italia è una repubblica democratica
fondata sul perforamento del terreno
*
IV
eccoci sui pianeti
dove non siamo stati
le immagini provenienti da marte
sono a colori e per questo
ci sembrano più reali
di quelle foto con i corpi ammassati
sono dettagliate e possiamo distinguere
rocce polveri crateri
possiamo
riconoscere la natura
le immagini del mondo alieno
sono il risultato di un’elaborazione
in cui molti vorrebbero abitare
ed altri si domandano se
una civiltà possa dileguarsi
senza lasciare memoria
ma anche noi un giorno saremo
tra i popoli costretti ad emigrare
da sempre chi scruta nell’universo
è scosso dai presagi

Intervista a Michele Donati:
Poesia come atto civile. “Il paesaggio nuovo” appartiene a questo pensiero?
Non credo che esistano temi più civili di altri. Anzi, il fatto che certi argomenti vengano visti come disimpegnati è forse il segno di un fraintendimento percettivo nel rapportarsi con essi e con la vita in generale.
“Il paesaggio nuovo” accoglie al proprio interno questioni sociali e ricordi personali, grotte e caverne sia reali che metaforiche, necessità e piacere. Ma la poesia davvero civile è la poesia che riesce a entrare in una relazione diretta e binaria con la realtà di cui fa parte.
Questo deve osservarlo la critica, non può proclamarlo l’autore.
La prima parte del libro è un allarme. Gli uomini sono prossimi ad essere le nuove macchine, o mi sbaglio?
Gli uomini sono già le nuove macchine. O le macchine sono già i nuovi uomini, ma più fortunate.
Individui incollati al cellulare che perdono la percezione dello spazio circostante. Quando ci spostiamo con l’occhio al navigatore inibiamo le parti del cervello deputate all’orientamento. Immaginiamo chissà quali altre parti, per chissà quanto altro tempo, moltiplicando esponenzialmente la quantità e la qualità delle esperienze tecnologiche.
Non è detto che al progresso della tecnica debba corrispondere il progresso dell’uomo. A me pare sinceramente di vedere il contrario, la tecnica contro l’uomo, ad esempio nei sistemi di sorveglianza sempre più pervasivi, nelle armi sempre più letali.
Si può obiettare: ma è l’uomo che usa la tecnica contro se stesso. Vero, e infatti se l’uomo oggi è capace di questo, non ho alcun dubbio che un’intelligenza artificiale nel futuro potrà sviluppare una qualche sofisticatissima forma di odio e crudeltà nei nostri confronti.
Anche l’uomo sarà in grado di fare altrettanto nei confronti delle macchine. Più che avventurarsi in ipotetici neoluddismi, dovrebbe però avere il coraggio di responsabilizzarsi.
La sensazione è che viviamo in una società in cui, a forza di scavare, poi non rimane più nulla. Che è proprio il contrario della poesia. Cosa ne pensa?
Mi viene in mente la metafora del poeta-minatore di Caproni, che affonda nell’Io per poi ritornare alla luce con una manciata di pepite. Poche, ma splendide. A quanto pare, le profondità della coscienza sono anfratti naturali che non hanno bisogno di essere scavati per essere percorsi.
Perforare la terra vera è altre cose, tra cui vari simboli: spaccare la propria base d’appoggio, polverizzare gli antenati, auto sabotarsi. Profanare la terra nei pressi dei luoghi dove gli antichi celebravano il loro culto dei morti.
Sono tutte azioni che mancano di consapevolezza e così il paragone che mi propone avvera uno strano contrappasso: nelle profondità dello spirito troviamo la conoscenza (come già avvertiva l’oracolo di Delfi) tanto quanto, addentrandoci con foga nelle viscere della terra, troviamo l’oblio.

(veduta della cava di Monte Tondo)
E, ancora di più, che il lavoro (e di conseguenza la mancanza di lavoro) è sì il perno della società, ma piano piano ne è diventato una condanna. È solo una mia impressione?
Il lavoro potrebbe, dovrebbe essere il fondamento della nostra vita civile. Ma purtroppo bisogna stare attenti a quello che chiamiamo lavoro: a volte, con il passare degli anni, dei secoli, le parole restano le stesse, ma l’oggetto che descrivono muta.
Molto dipende dallo spirito del tempo, Alfieri fece delle considerazioni simili sul tiranno. Sento spesso i politici dire: “Fra 30, 20, 10 anni la metà delle persone farà un lavoro che oggi non esiste”.
E oggi, invece? Quanto è il lavoro che non esiste, non perché non è stato inventato, ma perché non è stato pagato, riconosciuto, rispettato, mentre si vanno normalizzando precarietà e sfruttamento?
I significati della parola “lavoro” variano a seconda della persona con cui parliamo.
La seconda parte sottolinea, mi sembra, uno stato di totale confusione. Pone l’accento sul nostro presente e di come tutto sia così fragile, affidato com’è ad una ‘comunicazione’ che tutto fagocita e tutto trasforma. Anche le certezze in paure. Non si può più tornare indietro?
I testi della seconda sezione sono tutti ispirati all’esperienza reale, diretta o mediata, di paesaggi, sono come trasfigurazioni virtuali di luoghi reali, per significare una commistione tra i due elementi prossima all’inestricabilità. Le dimensioni slittano l’una nell’altra, dentro e fuori un soggetto la cui presenza in un interregno del genere è inevitabilmente sofferta e confusa.
Tornare indietro non è possibile, anche l’eventuale ritorno a un qualche status quo (ma a quando?) sarebbe in realtà un andare avanti.
Possiamo farlo coscientemente, attivamente – mi pare che comunque non manchino gli elementi propositivi nella società – oppure possiamo farlo in maniera precipitosa e passiva, seguendo il corso degli eventi.
Pensando poi alla terza parte, mi viene da dire che il buio della caverna è un buio che, in qualche modo, attraversa tutte le pagine. È questo il filo conduttore de “Il paesaggio nuovo”?
Anche se concludono il libro, i testi de “La caverna” sono i primi che ho scritto: la loro posizione potrebbe quindi rappresentare un segnale interpretativo. Il filo conduttore, però, non può essere il buio: non è infatti questo a dominare nella caverna, ma le immagini delle ombre, l’unica cosa che possono vedere i prigionieri. Il mito platonico descrive la contemporaneità, il nostro sguardo fisso sullo spettacolo mediatico di un presente senza prospettiva.
Nella caverna vediamo fino a che punto l’uomo può essere schiavo di se stesso o di un padrone, ma non va dimenticato che vediamo anche la capacità che ha di liberarsi dalle catene che lo legano e il suo gesto di vera condivisione. I testi rappresentano anche un movimento introspettivo: iniziai a concepirli diversi anni fa, ma ho preso a scriverli solo quando ho ricevuto l’ispirazione meditando su un sogno ricorrente del passato. E sento che “La caverna” non è ancora un testo finito.

(L’incendio che colpì la Lotras nell’agosto del 2019 a Faenza)
A fine libro si vive una netta sensazione di smarrimento. Ma che smarrimento può essere?
Lo smarrimento apre il testo fondamentale della letteratura italiana, la Commedia di Dante. La caduta è necessaria a risollevarsi, perdersi serve a ritrovarsi, a patto che si intenda seguire tale percorso rifuggendo scorciatoie e stratagemmi, senza farsi sconti.
Lo smarrimento che lei ha avvertito alla fine del libro è quello che provo quando osservo paesaggi devastati dall’uomo, quando vedo ripetersi, diverse nella forma ma uguali nella sostanza, dinamiche di assoggettamento dei popoli a nuovi, striscianti autoritarismi, quando sento che chi mi circonda si astrae in non luoghi virtuali.
Questi sono fattori, come innumerevoli altri, di cui credo che molta gente si renda conto. Eppure, nei fatti, vengono accettati, se non addirittura assecondati nell’indifferenza. Ciò provoca smarrimento in me e in chi comprende quali aspetti dell’esistenza siano messi in gioco in tale deriva.
Siamo veramente consapevoli di questo smarrimento? O la nostra coscienza va riempiendosi, come gli account social, di notifiche non lette? Il messaggio ci arriva, ma lo ignoriamo. Ma se c’è vera consapevolezza, lo smarrimento si tradurrà in azione.
In tutto il libro il paesaggio è protagonista assoluto. Ma quale è il paesaggio che sopravvive, agli occhi di chi ogni giorno si chiede in quale realtà sta vivendo?
Il paesaggio nuovo si sostituisce al vecchio e pone inediti paradigmi spazio-temporali. Difficile distinguere verità e finzione, lo diciamo sempre quando ci riferiamo all’informazione, ma è valido anche per i luoghi.
Prendiamo la foto, anzi l’icona, scattata da Charles O’Rear alla fine del secolo scorso: colline verdi, cielo azzurro pennellato di nuvole. Fu utilizzata da Microsoft come sfondo predefinito del sistema Windows XP. Un vero paesaggio, verrebbe da dire. E invece quella è l’immagine primaria dei non luoghi contemporanei, appiattiti in proiezioni virtuali che non hanno alcuna dimensione spaziale né temporale.
L’aggettivo “nuovo” è da intendere anche, come facevano i latini, con una sfumatura di inquietudine: novus è l’evento misterioso che arriva e sconvolge ciò che credevamo ci fosse noto. Può essere straniante, ed è una accezione piuttosto lontana dal modo di pensare che domina le masse di oggi, così infatuate della novità.
In tutto questo, il teatro che ruolo può avere?
Il teatro ha un ruolo essenziale. È l’unica forma d’arte che abbia mantenuto l’aura, conservando così la propria vocazione spirituale, sacra. Basti vedere gli esiti del “teatro a distanza” durante il periodo della reclusione pandemica: un fallimento, perché non si potrà mai sottrarre al teatro la sua natura di accadimento immediato hic et nunc.
Per questa e altre caratteristiche penso che il teatro sia l’arte più rivoluzionaria, anche in senso politico. In particolare, ho una passione viscerale per l’opera lirica, caleidoscopio delle miserie e delle glorie umane, fatta di sentimenti estremi: mi sono divertito a nascondere nel libro alcune citazioni, come in un gioco enigmistico, come in uno spazio di libertà.

L’autore:
Michele Donati (Faenza, 1994) si è laureato in Italianistica all’Università di Bologna con una tesi in Poesia italiana del ‘900 su Clemente Rebora e la musica: un estratto è stato pubblicato sul numero 23 della rivista Smerilliana (2020) con il titolo “Per un Rebora mal noto. Indagine su Rebora e il melodramma”.
Scrive sul quotidiano Corriere Romagna, è vicepresidente dell’associazione IndependetPoetry, con cui cura appuntamenti e letture poetico-musicali (“Melusina” di Antonio Porta, “L’ospite che non giunse” di Nella Nobili, “La libellula” di Amelia Rosselli nello spazio espositivo Officina Matteucci, Faenza, 2018-19).
È autore e regista di spettacoli teatrali: “Mazapégul”, Museo Carlo Zauli (Faenza), “Festival Tres Dotes” (Tredozio) 2018; “Canone a specchio”, Fringe Festival (Edimburgo), Teatro del Navile (Bologna), 2019. Alcuni suoi inediti sono inseriti nell’antologia “Distanze Obliterate” (Puntoacapo, 2021) curata da Alma Poesia.
(Michele Donati “Il paesaggio nuovo” pp.59, 18 euro, Il vicolo 2021)
-La prima foto ritratto di Michele Donati è di Virginia Morini
Immagini —————————
Trieste/London 2017-2018
Dieci fotografie
di Luisa Sodomaco


(foto di Elise Corten)
Intervista a Luisa Sodomaco:
di Giovanni Fierro
In questa selezione di immagini c’è sempre la sensazione di vivere in un tempo sospeso. Che divide il prima dal dopo. È così?
Direi di sì, pensando all’atto di fotografare in sé ovvero di catturare il momento, questo può creare un confine netto tra prima e dopo lo scatto anche se, essendo il tempo relativo, forse la sospensione che si può sentire è quella del mio punto di vista dietro la macchina; in cui smetto di vivere il momento per immortalarlo, come quando per osservare meglio una scena di un film lo si può mettere in pausa al fine di conoscerne meglio i dettagli.
La forza dello sguardo di queste immagini è che invita chi le guarda a chiudere gli occhi. Ma mi domando, per cosa vedere cosa di più? O meglio?
Chiudere gli occhi porta (spero) a una riflessione, riaprendoli lo sguardo è già diverso/nuovo da quello che era. Si diventa capaci di vedere particolari che a una prima occhiata possono essere sfuggiti, oppure durante il momento di chiusura possono nascere delle domande, e forse osservando ancora si possono trovare delle risposte.
Di primo impatto è la sensazione, guardando foto dopo foto, che qualcosa si è perso, ma cosa? E in che modo?
Allora, qui potrei farti un racconto lunghissimo di traumi e brutte esperienze, ma infine credo che l’unica cosa che si perda veramente sia solo il tempo, purtroppo nessuno te lo può tornare.
Credo di aver iniziato a fare foto proprio per colmare la paura del tempo che passa, salvandolo e rendendolo ricordo visivo, allo stesso tempo c’è anche la spinta/paura di non rivedere mai più quella scena, situazione, espressione, movimento che sia.
Sono immagini che vivono di colori tenui, leggeri e mai invadenti; cosa c’è alla base di questa scelta?
L’uso della pellicola in questo è fondamentale, riesce a catturare frammenti di colori onirici e magici.
Poi cerco di catturare più luce possibile quando scatto, talvolta arrivando a sovraesporre; in alcuni casi vorrei che la luce potesse uscire dalle mie foto in modo che, guardandole, si abbia l’effetto di guardare direttamente il sole, bello ma un po’ doloroso, come gli insetti che sono attratti da lampadine e fiori non mi trovo troppo diversa dal loro desiderio di luce.
Le presenze umane sono di persone sfuggenti, come i loro sguardi. Come i loro pensieri?
Quando fotografo le persone ho bisogno di instaurare dell’intimità. Questo però non significa che ci siano subito delle confidenze, i loro pensieri non li conosco a meno che non sia loro scelta parlarne.
Non amo le situazioni posate e finte, trovo che in un momento di distrazione una persona riesca a raccontare qualcosa di più, come in uno sguardo distratto o un movimento improvviso.
A volte, guardando questi scatti, mi domando (e chiedo), in che modo interagiscono con il quotidiano?
Diventando testimonianze di tempi passati e presenti. Ad esempio mi piacciono molto i graffiti (ma anche le tag brutte) perché sono segno palese del passaggio umano, solo che spesso finisce che vengono riverniciati, almeno in foto continuano a esistere.
La bellezza di questi scatti è anche nel silenzio che contengono, mi sembra. Che silenzio è? o potrebbe essere?
In un mondo con così tanto rumore un po’ di silenzio può essere una salvezza. Trovo difficile osservare veramente qualcosa se c’è troppo caos, fotografando si creano diversi silenzi; spesso il mio silenzio, spesso il silenzio delle altre persone, e a volte si è in silenzio insieme come in una meditazione, magari sono momenti vuoti di parole ma se si ascoltano bene pare già di sentire le quattro stagioni di Vivaldi.
Per certi versi mi hanno ricordato alcune polaroid di Andrej Tarkovskij….
Lo prendo come un gran bel complimento, grazie!

L’artista:
Luisa Sodomaco (Trieste, 1994) è una fotografa ed artista visuale che vive e lavora a Trieste.
Si diploma all’Istituto d’Arte in Moda e Costume e continua studiando Fotografia alla Royal Academy of Arts (KABK) presso l’Aia, in Olanda, frequentando ma non concludendo ufficialmente gli studi.
Successivamente continua la sua ricerca nel campo della fotografia; attualmente lavora su commissione e insegna camera oscura.
Il suo lavoro si basa su una continua e profonda analisi e rappresentazione visiva dei propri pensieri, essendo molto legata al tema della sensibilizzazione sulla salute mentale.
Narrando i più intimi dettagli della sua vita quotidiana, documenta sé stessa e come la sua persona si modifica, in base alle persone ed al contesto in cui si relaziona.
rivista Fare Voci
curata da Giovanni Fierro
collaboratori:
Roberto Lamantea, Salvatore Cutrupi, Ilaria Battista, Laura Mautone, Livio Caruso.

