
La proposta di Fare Voci continua nel suo muoversi, dentro ed attraverso il panorama culturale ed artistico del nostro tempo contemporaneo. Tra novità e scoperte, ritorni e conferme.
È la pittura di Lindsey Harald-Wong, artista statunitense che ora vive in Malesia, ad aprire il numero di novembre, che subito si amplia con la nuova raccolta poetica di Anna Toscano, “Cartografie”, nuovo punto di svolta del suo fare poesia.
Dalla Slovenia ospitiamo Gregor Podlogar, che ci propone due testi inediti in italiano, nella traduzione di Michele Obit.
La voce d’autore è anche quella di Giulio Mazzali, con la novità del suo nuovo libro “La pratica del buio”.
E d’autore è anche il mondo della poesia in friulano, che esploriamo con i nuovi libri di Lussia di Uanis e di Matteo Bellotto, rispettivamente con “di tiara e aga” e “Pôre di nuie”.
Una sorpresa è anche lo scrivere di Claudia Fabris, due suoi libri,“La Cameriera di Poesia. Piccola ristorazione dello spirito” e “Parole sotto sale. Piccolo vocabolario poetico”, sono l’occasione per entrare in un mondo davvero originale.
“Tutta l’acqua che può essere tenuta in una mano” è il testo inedito della giovane Margherita De Boni, il suo raccontare è occasione di meraviglia.
Massimiliano Stefani ci porta nella dimensione della narrazione, con “Victoria non esiste – all’improvviso un’esplosione a Trieste”.
Buona lettura e visione.
Giovanni Fierro
(la nostra mail à farevoci@gmail.com)
Immagini ———————
Jungle night walker
Undici dipinti
di Lindsey Harald-Wong

Voce d’autore ———————-
Ho discusso con una virgola
Anna Toscano, “Cartografie”
di Roberto Lamantea

Dopo “Controsole” (2004), “Doso la polvere” (2012), “Al buffet con la morte” (2018), Anna Toscano pubblica da Samuele Editore, nella “Gialla” di Pordenonelegge, la nuova silloge, “Cartografie”, testo che conferma come la scrittura della poeta e fotografa veneziana abbia affinato una malinconia dello sguardo che si traduce in una dolcissima percezione del tempo.
“Al buffet con la morte” è un delicato libro di figure leggere, amate e volate via, presenze-ali, acquarelli della vita che trascolora, come nella “Chambre verte”, il film di François Truffaut (1978) dai racconti di Henry James. In “Cartografie” il tempo non porta via i momenti della vita, ma li trasforma in disegni a matita da guardare con tenerezza e anche le voci e i volti sono silenzio. Il dato stilistico dà voce a questo sguardo della memoria: se Anna Toscano continua a prediligere i testi brevi, nel nuovo libro è l’intonazione a colpire il lettore: quasi voce fuori campo, a volte da film noir d’altri anni un po’ alla Carver, immagini alla Hopper, quei quadri stupendi, struggenti, dove una stanza, un bar vuoto, lo scompartimento di un treno, non sono ambientazioni ma specchi dell’anima: si veda uno dei testi più belli del libro, “Da un pullman a San Paolo”; o “Riavvolgere le stanze”, metafisico gioco di interni/esterni; “Soglie piene”, dedicata a Goliarda Sapienza.
Si può leggere e rileggere “Temperamatite”, dove l’odore di legno secco di una matita è una madeleine, richiama – in una fitta al cuore – il passato: odori, sapori e luci aprono persino con violenza una faglia nel tempo.
In “Cucire arazzi” Anna vorrebbe unire tutti i frammenti, gli strappi, le foglie perse della vita – “foglietti bordi angoletti/ biglietti scatole ma anche bugiardini/ buste e pizzini, brandelli/ di vita scritti ovunque,/ idee nelle tasche/ pensieri persi nelle borse/ sparsi nei cassetti:/ dovrei raccoglierli, farne un collage/ un arazzo forse, cucirli insieme”. Per poi bruciare tutto con un fiammifero.
Da un certo punto – più o meno da pagina 34 – l’autrice (“Nel viavai”) si diverte e gioca con una danza metrica e rimica, tra Gozzano, Palazzeschi, Rodari, ma anche Lamarque (“La pagina del giornale”) e persino Valeri, fino ad osare la rima cuore-amore (Saba: “M’incantò la rima fiore amore, la più antica difficile del mondo”), con semplicità disarmata, innamorata, tenerissima (“Calle del Vento”, l’ultimo libro di Diego Valeri, del 1975, è forse uno dei più teneri inni alla vita della poesia del Novecento). Anna Toscano gioca con la punteggiatura, punti, virgole, come fossero soldatini a guardia della frase.
“Cartografie” è anche un libro di viaggi, e di ricordi di viaggi dove ogni città invoca l’altra, ha nostalgia dell’altra, come se viaggiare fosse insieme scoperta e fuga, fosse non il vagare/fluttuare da uno spazio all’altro ma all’interno di se stessi.
E su spiagge, rive e case ecco figure lontane nel tempo ma che sono qui, in una Venezia di pietra, acqua e fantasmi: con i loro berretti sbilenchi, la sciarpa di lana rossa annodata storta, un sigaro spento, come uno sguardo che “ama gli altri inutilmente” (Mario Stefani).
“Cartografie” è uno di quei libri che ti prendono per mano, con gli occhi un po’ tristi, e ti portano in un “bàcaro” – quelle vecchie osterie veneziane dove gustare “ombre” e “cichèti”, o nei “fritoìni” di pesce fritto e vin bianco – a far “ciàcoe” (chiacchiere), e dove intuisci un rossore nascosto.
Al mercato di Rialto, la mattina presto, puoi vedere il ciuffo bianco di Susan Sontag, la giacca a scacchi di Brodskij, il tabarro di Mariano Fortuny, mentre “Diego Valeri è quello con taccuino e giornale/ sotto il braccio, pare stia scrivendo/ la guida d’oltretomba della città” [Valeri ha scritto “Guida sentimentale di Venezia”, ed. Le Tre Venezie 1942, Passigli 1997]; “e lui, lui che cammina quasi saltellando/ è Daniele Del Giudice”. Ed eccola, la rima cuore-amore in una figura alla Pierrot: “Ho incontrato in un vaporetto/ un antico e triste amore/ chiedeva un euro/ per ritrovare il suo cuore”.
Saranno le parole a danzare per sempre, oltre il tempo e la nostalgia, i frammenti delle cose e il loro ricordo, un vecchio amore forse solo immaginato: “Voglio un’eternità/ piena di parole, libere”.
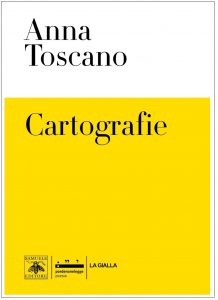
Dal libro:
Da un pullman a San Paolo
Ti parlo da questa umida notte,
una notte delle solite.
Sono sceso al bar perché non dormo più.
Il tempo di entrare in casa e già ero fuori.
Sto qui seduto a mandarti messaggi a cui non rispondi,
a leggere messaggi che non mi hai spedito.
A scriverti che le notti ora sono così,
sanno di fritto rancido e di detersivo
per pavimenti a basso costo.
A non ascoltare gli altri ma
ad aver bisogno del loro rumore.
A guardare le macchine passare,
guardarci dentro per cercarti.
A contare i pullman che tornano dall’aeroporto,
ad aspettare di vedere il tuo viso al finestrino.
Ma che tu sia nel mondo o qui è lo stesso,
perché questa città ne contiene tutti i fusi orari
le razze i generi i suoni i cieli le nuvole i venti i toni i colori gli odori.
Sono le regole intransitive della vita:
il mondo non è San Paolo, ma San Paolo è il mondo.
Tu a non scrivermi, io a leggerti.
Tu a non tornare, io ad aspettarti.
*
Temperamatite
Facendo la punta alla matita
l’odore di legno secco,
cerco nella memoria da dove
questa fitta al cuore.
Ed ecco il tuo temperino a manovella
confinato nella penombra
della soffitta e tu che le temperi
tutte una dopo l’altra.
E allora telefono a mia sorella
«fammi un regalo, domani
portami il temperamatite di papà,
quello giallo, lo tengo qua».
*
Trasformazioni
Ho discusso con una virgola
non voleva stare all’inizio
e nemmeno alla fine
mi diceva: Liberami dal verso!
Le ho implorato di fermarsi
mi ha risposto Non sono un trattino!
le ho chiesto di calmarsi
ma era disturbata dalle congiunzioni,
sosteneva di esser nata per la prosa.
L’ho trasformata in un punto.
*
Amica mia
Come vorrei esserti più vicina
un caffè un cinema
una telefonata di mattina
per dire poi arrivo
per sentire
prendo lo scooter
e vengo da te.
Una vita, insomma,
con dei perché.

Intervista ad Anna Toscano:
“Cartografie” è anche un diario di viaggi nelle città del mondo, figure e ricordi, dove passato e presente s’intrecciano, sembrano disegnare un’unica identità: il transitare, il passare, vivere in un luogo più nel suo ricordo che nel presente. È così?
Sì è esattamente così, è quasi una creazione di un tempo senza tempo, direi forse un passato senza passato, che sta nel presente e viceversa, il presente sta nel passato: un tempo ampio che tiene in sé i luoghi, le persone, gli oggetti.
Perché dove se non nella parola possiamo tenere ciò che vogliamo tenere, così che la vita ci porta via, per un motivo o per l’altro, ciò che la memoria si porterebbe via quando non tratteniamo più il ricordo. La parola scritta, il verso, la poesia, come luogo e tempo dove stare, dove accerchiarsi di ciò che si vuole ricordare.
Mi viene in mente una poesia di Anna Maria Carpi in cui scrive di lei che torna bambina per un attimo e sta seduta sul tappeto con tutti i suoi giochi attorno. Ecco, le mie cartografie sono in un certo senso questa cosa: io sul tappeto con attorno le mie geografie umane.
Il tuo precedente libro di versi, “Al buffet con la morte”, è del 2018: che cosa è cambiato in sei anni nel tuo rapporto con la scrittura?
Mi ci fai pensare ora, di certo con “Al buffet con la morte” ho attraverso la parola scollato la morte dalle mie immagini, immagini visive ma anche in versi. Ho travasato in versi quegli attimi che mi invadevano la testa, gli attimi di addio al corpo – anche lui oggetto caro, e quanto ci costa! – gli attimi del saluto, gli attimi in cui i corpi restano lì e noi, noi che restiamo qui piegati in due dal dolore. I miei lutti, gli abbandoni, le perdite, le separazioni, mi durano decenni, non posso che covare versi per viverci insieme.
Ora il tempo mi si è allargato – benché diventi più corto – la scrittura ne risente e io scorrazzo con versi che sono storie e storie che sono versi, come se mi stessi accomodando più ampiamente nella scrittura senza starci, come per anni, “seduta in pizzo”, come diceva mio padre.
È sempre più, la scrittura, per me un luogo e un tempo dove sto bene.
Tra le città e i paesaggi del libro è naturalmente Venezia, dove vivi, il tuo luogo del cuore. Ma Venezia è ancora una città letteraria? Penso alla Venezia di Brodskij, Thomas Mann naturalmente, ma anche Diego Valeri, Mario Stefani, l’elenco è lunghissimo…
È proprio con questo elenco lunghissimo che c’è ancora una Venezia letteraria, una Venezia viva e piena di cultura. Al tuo elenco aggiungo molte donne, scrittrici e artiste, che di questa città hanno fatto un luogo di arte, letteratura, bellezza, cultura come anche di umanità e condivisione. Penso a Rosalba Carriera, a Giulia Lama, Veronica Franco, Susan Sontag, Peggy Guggenheim, Alda Monico, Anna Maria Carpi, Bianca Tarozzi, solo per citarne alcune.
Venezia vive, vive nonostante tutti i tentativi di spegnerla, di renderla un menù fisso per l’ottusità. Lei vive.

L’Italia è un Paese strano: moltissimi scrivono poesie, la maggior parte con uno stile molto naïf, una piccola casa editrice specializzata nel settore riceve una media di dieci/venti manoscritti al giorno, ma pochissimi leggono libri di poesie, mentre la produzione editoriale del settore, sia di marchi piccoli che grandi, fra novità e traduzioni propone decine di titoli al mese: come interpreti questo paradosso?
Il discorso sarebbe lunghissimo, ma per non dilungarmi troppo aggiungo che anche nel mondo della pittura, dell’arte, della musica, ci sono moltissime persone che senza saperne nulla si lanciano verso un pubblico.
Un conoscente mi ha proposto una sua raccolta, gli ho chiesto subito cosa leggesse, che poeti gli piacessero, mi ha risposto che non leggeva, che non conosceva poeti, che si proclamava “autodidatta”.
Che dire, non ho più tanto tempo per intraprendere una crociata su questi argomenti.
La maggior parte dei tuoi studi critici è rivolta alla letteratura delle donne, da Goliarda Sapienza alle voci minori: oggi c’è più attenzione alla letteratura femminile rispetto al passato o persiste una specie di “esilio”?
La chiamerei non la letteratura femminile ma delle donne, scrittrici e poete e artiste in senso ampio. E non parlerei nemmeno di voci minori, da Janet Frame a Briana Carafa passando per Paley, Szabo, Prato, Oppezzo, Ravikovich, solo per citarne alcune, sono tra le voci maggiori della letteratura non solo italiana. Sono la letteratura.
L’esilio è esistito perché il canone letterario è stato costruito da una editoria maschile su un’altissima percentuale di autori, così com’è accaduto anche per i manuali scolastici. L’esilio non è un qualcosa che accade, le porte non si aprono o vengono chiuse non dal vento, ma da chi decide di chiuderle, o non aprirle, lasciando fuori una immensità, di numero e qualità, di voci.
Certo, anche dieci o venti anni fa si facevano convegni sulle scrittrici non abbastanza considerate, ma allora si parlava dei pochi nomi già famosi e stimati, penso a Morante o Ginzburg per esempio.
Oggi, grazie a un lavoro fecondissimo di critiche, studiose, lettrici, editrici, accademiche, imprenditrici – lavoro fecondissimo e faticosissimo, bisogna dirlo – finalmente stiamo uscendo dal box a fondo pagina delle antologie dedicate alle “donne”, usciamo dal ghetto, perché il mondo della letteratura inizia a rimettere in circolo i capolavori, le opere imprescindibili delle scrittrici.

L’autrice:
Anna Toscano vive a Venezia, insegna all’Università Ca’ Foscari e collabora con altre Università. Un’ampia parte del suo lavoro è dedicato allo studio di autrici donne, da cui nascono articoli, libri, incontri, spettacoli, corsi, conferenze, curatele, tra cui “Il calendario non mi segue. Goliarda Sapienza” e “Con amore e con amicizia, Lisetta Carmi“, Electa 2023 e le antologie “Chiamami col mio nome. Antologia poetica di donne” vol. I e vol. II.
Molto l’impegno per la sua città, sia partecipando a trasmissioni radio e tv, sia attraverso la scrittura e la fotografia, ultimi: “111 luoghi di Venezia che devi proprio scoprire”, con Gianni Montieri (2023) e in “The Passenger Venezia” (2023).
È nel direttivo scientifico di Balthazar Journal e della Società Italiana delle Letterate. La sua sesta e ultima raccolta di poesie, prima di “Cartografie”, è “Al buffet con la morte” (La Vita Felice, Milano 2018); liriche, racconti e saggi sono apparsi in guide, giornali, manifesti, copertine di libri, mostre personali e collettive.
Il suo sito web è www.annatoscano.eu
(Anna Toscano “Cartografie” pp. 96, tredici euro, Samuele Editore – Pordenonelegge “La Gialla” 2024)
Immagini ———————
Trees
Undici dipinti
di Lindsey Harald-Wong

Tempo presente —————————-
Sreča je neznane oblike La felicità ha una forma oscura
Due testi inediti in italiano
di Gregor Podlogar

Okajeni Joseph Haydn na skrivaj pleše
Mrzla noč klasicizma,
napeta kot struna violine,
pripravljena, da njen zvok
prereže železno tišino
in se spremeni v Stvarjenje.
In nomine Domini.
Imam samo eno upanje,
delček mene, delček dečka,
izgubljenega
med dunajskimi konji
v blatu 18. stoletja.
Največ sem se naučil
s poslušanjem.
Ustvarjam kot nor. Za mnoge
priložnosti, potem vidim
morje, morje, vzkliknem,
vidim Anglijo, London,
vidim parni stroj,
a moja edina naprava
je veliki čembalo.
V letih šaljivosti in dvorjenja
sem spoznal,
da je edina prava institucija
institucija smrti.
Z lahkoto se sprehodim
po imenih mojega časa:
Esterházy, Franc II., Ludvik XVI.,
Katarina II., Voltaire, Robespierre,
Napoleon, Marija Antoaneta.
Letijo glave, topovske krogle,
topa bodala prodirajo med rebra,
strupi se razlivajo v telesih veljakov,
krogle se zarivajo v čela vojakov,
nekje daleč oklenjeni črnci
na ladjah čez Atlantik …
Tu sem. S starim, dolgim nosom.
Ampak, hej, preživel sem
črne koze,
zborovodja bi mi v mladosti
skoraj odrezal jajca,
kot bakla je gorela moja hiša.
Na zdravje, gospod Tokaj.
V šepavih mislih me prešine,
da v onostranstvu ni potreb,
da neskončnost in večnost
postaneta tvoje telo
kot utelešenje usode.
Včasih se mi prikaže.
Danes sem jo videl
v kapljici rose, kapljici,
ki je zgodaj zjutraj polzela
navzdol po listu trave
na bojnem polju tik pred bitko.
Kriki. Kri. Križ.
Molim kot nor. Za mnoge,
blagoslovljen bodi vsak zvok,
na vekov veke.
Pa ja ne boste rekli,
da je vse ustvarjeno resna zadeva,
filozofija in morala spadata v glasbo,
a vanjo spustim še drugo,
vsaj veselje. Naj se glasba sliši,
vedno in vsepovsod,
naj bo za vse, ne le za izbrance.
Prisluhnite, za božjo voljo,
sonce že igra kvartete.
Sreča je neznane oblike.
Vse zvezde na nočnem nebu
pariške pomladi so
v tebi,
pravim, ko plešem sam
v tèmi.
Samodejno zapiram oči.
Pozno je, celo za večnost.
Moje gosje pero, notni zapisi,
čisto črnilo, dogorela sveča,
moje miši, njim momljam,
ko komaj premikam noge:
Smrt je resnična šele, ko si mrtev.
Joseph Haydn brillo balla di nascosto
Fredda notte del classicismo,
tesa come una corda di violino,
pronta affinché il suo suono
interrompa il ferreo silenzi.
E si trasformi in Creazione.
In nomine Domini.
Una sola speranza ho,
Una minima parte di me, una del ragazzo
perduto
tra i cavalli viennesi
nel fango del 18. secolo.
Le cose più importanti le ho imparate
ascoltando.
Sto creando come una pazzo. Per varie
occorrenze, poi vedo
il mare, il mare, scandisco,
vedo l’Inghilterra, Londra,
vedo una macchina a vapore,
ma il mio unico congegno
è un grande clavicembalo.
Negli anni della giocosità e della corte
ho compreso
che l’unica vera istituzione
è l’istituzione della morte.
Passeggio facilmente
per i nomi del mio tempo:
Esterházy, Francesco II, Ludovico XVI,
Caterina II, Voltaire, Robespierre,
Napoleone, Maria Antonietta.
Volano le teste, le palle di cannone,
pugnali non appuntiti penetrano tra le costole,
i veleni si riversano sui corpi dei baroni,
le palle si conficcano sulle fronti dei soldati,
lontano dei neri avvinghiati
sulle navi oltre Atlantico…
Io sono qui. Con il vecchio, lungo naso.
Però, ehi, ho vissuto
la pelle nera,
quand’ero giovane il direttore del coro
mi avrebbe quasi tagliato le palle,
come una torcia bruciava la mia casa.
Alla salute, signor Tocai.
Nei pensieri zoppicanti mi pervade l’idea
che nell’aldilà non ci siano bisogni,
che l’infinito e l’eterno
diventano il tuo corpo
come personificazione del fato.
A volte mi appare.
Oggi l’ho visto
in una goccia di rugiada, una goccia,
che al mattino presto è scivolata
giù per una foglia d’erba
sul campo di battaglia prima dello scontro.
Urla. Sangue. Croce.
Prego come un pazzo. Per i tanti,
benedetto sia ogni suono,
Nei secoli dei secoli.
Poi non direte
che tutto il creato è una cosa seria,
la filosofia e la morale fanno parte della musica,
Ma in essa c’è ancora qualcosa,
la gioia se non altro. Che la musica si senta,
sempre e in ogni dove,
che sia per tutti, non solo per gli eletti.
Ascoltate, per l’amore di dio,
il sole già suona i quartetti.
La felicità ha una forma oscura.
Tutte le stelle nel firmamento notturno
della primavera di Parigi sono
in te,
dico mentre ballo da solo
nel buio.
Chiudo automaticamente gli occhi.
È tardi, finanche per l’eternità.
La mia penna d’oca, le annotazioni,
l’inchiostro puro, la candela bruciata,
i miei ratti, a loro brontolo
non appena muovo i piedi:
La morte è reale solo quando sei morto.

Alma Mahler: potovanje skozi čas
Tudi jaz vas ne poznam.
Človek je v bistvu vedno človek.
In samo človek. Er ist Mensch.
Zgodbe se pišejo.
Vlaki izginjajo v nevidna mesta.
Pomnijo jih zbledele razglednice.
Topot konjskih kopit.
Ptičje petje. Prihodi pomladi.
Nekaj se pokaže in izgine.
Pariz. Praga. Dunaj. Ljubljana.
Trst. Zagreb …
… večina dogodkov je neizrekljiva,
zgodijo se v prostoru, v katerega ni
nikoli stopila beseda… Pariz.
Trst. Ampak jaz sem tu. Lebdim.
Sredi ničesar. Wonach … wohin?
Vse to skupaj …
Tvoja zgodba je rodila 20. stoletje.
Tvoja zgodba je 20. stoletje.
Kot komaj posušeno črnilo
notnega zapisa v neki odmaknjeni,
skoraj nevidni sobi. Zunaj časa.
Zunaj vrvež, ki piše pisma.
Pišem pisma.
Gledam skozi okna kočij.
Sneg. Škrtanje z zobmi.
Podobe na sliki tega ne vidijo.
Škrlatni zvok srebrnega pribora.
Odbijanje not. Odbijanje besed.
Nur dich!
Nur dich!
Nur dich!
Nikoli ti nisem pokazala
niti note niti sebe.
Moj Dunaj. Moje stvari.
Moj svet. Moji glasovi.
Bili smo slepi. Slepi ste.
Niemand gefällt mir.
Še vedno me nosi zvok violine,
sto let kasneje vstopam
skozi iglo na gramofonu –
Gustav Mahler: 8. simfonija.
Postajam kristalni čas.
Vem, da obstaja …
Ich fand sie in der Musik.
Tukaj vstopi bolečina.
Kako me veter podarja vetru.
Kako me veter nese v vihar,
vihrava čustva,
nikoli pozabljene trenutke
onkraj vsakega življenja.
Kako vedno bolj čutim.
Kako vedno bolj strmim.
Kako strmim.
Vedno bolj čutim.
Umiva me milost.
Glagol. Samostalnik.
Samostalnik. Glagol.
Vem, da me ljubiš.
Jaz sem drugje. Glagol.
Skrita sva v besedi in.
In nikoli nič ne rečeš.
Alma Mahler: viaggio nel tempo
Anch’io non la conosco.
Un uomo è in sostanza sempre un uomo.
E solo un uomo. Er ist Mensch.
Le storie si scrivono.
I treni scompaiono in luoghi invisibili.
A ricordarli delle cartoline scolorite.
Un calpestio di zoccoli di cavallo.
Il canto degli uccelli. La primavera che arriva.
Qualcosa appare e scompare.
Parigi. Praga. Vienna. Lubiana.
Trieste. Zagabria…
… quasi ogni cosa che avviene è indicibile,
Accade in un luogo nel quale non è
mai entrata la parola… Parigi.
Trieste. Io però sono qui. Sospesa.
In mezzo al niente. Wonach … wohin?
Tutto questo assieme…
La tua storia ha fatto nascere il 20. secolo.
La tua storia è il 20. secolo.
Come l’inchiostro appena asciugato
di un’annotazione in una lontana
quasi invisibile stanza. Al di fuori del tempo.
Fuori un trambusto che scrive lettere.
Io scrivo lettere.
Guardo attraverso il finestrino della carrozza.
Neve. Stridore di denti.
Le figure nei quadri questo non vedono.
Il suono scarlatto delle posate.
Il riflesso delle note. Il riflesso delle parole.
Nur dich!
Nur dich!
Nur dich!
Non ti ho mai mostrato
né le note né me stesso.
La mia Vienna. Le mie cose.
Il mio mondo. Le mie voci.
Eravamo ciechi. Siete ciechi.
Niemand gefällt mir.
Ancora mi porta il suono del violino,
cent’anni più tardi passo
Attraverso un ago sul grammofono –
Gustav Mahler: 8. sinfonia.
Divento un tempo di cristallo.
So che esiste…
Ich fand sie in der Musik.
Qui arriva il dolore.
Come il vento mi concede al vento.
Come il vento mi porta nella tempesta,
sentimenti impetuosi,
momenti mai dimenticati
al di là di qualsiasi vita.
Come percepisco sempre di più.
Come fisso lo sguardo sempre di più.
Come lo fisso.
Percepisco sempre di più.
Mi lava la grazia.
Il verbo. Il sostantivo.
Il sostantivo. Il verbo.
So che mi ami.
Io sono altrove. Il verbo.
Ci celiamo nella parola e.
E tu non dici mai niente.

L’autore:
Gregor Podlogar (1974) ha concluso gli studi di filosofia a Lubiana. Per molti anni è stato redattore della sezione slovena del portale poetico lyriklinr.org.
Ha pubblicato varie raccolte poetiche, da “Naselitve” (Insediamenti) del 1997 ad “Atlas” del 2022, per la quale è stato finalista dei premi Veronikina nagrada e Jenkova nagrada.
Le sue poesie sono state tradotte in molte lingue e pubblicate in antologie straniere, tra queste in “Loro tornano la sera. Sette autori della giovane poesia slovena” (cura e traduzione di Michele Obit, ZTT – Editoriale Stampa Triestina, 2011).
Attualmente, dopo un lungo periodo trascorso a Vienna, è redattore presso il terzo canale di Radio Slovenija.

Il traduttore:
Michele Obit (1966) vive a Cividale (Udine).
Ha pubblicato le raccolte poetiche “Notte delle radici” (1988), “Per certi versi/ Po drugi strani” (1995), “Epifania del profondo / Epiphanje der Tiefe” (Austria, 2001), “Leta na oknu” (2001), “Mardeisargassi” (2004), “Quiebra-Canto” (Colombia, 2004), “Le parole nascono già sporche” (2010), “Marginalia/Marginalije” (Lubiana, 2010) e “La balena e le foglie” (2019).
Ha curato e tradotto il volume “Quel Carso felice”, antologia di poesie dell’autore sloveno Srečko Kosovel, edita da Transalpina nel 2018.
È direttore del Novi Matajur, il settimanale sloveno della provincia di Udine.
Ha tradotto in italiano i più importanti poeti sloveni della nuova generazione e le opere degli scrittori Miha Mazzini, Aleš Šteger e Boris Pahor.
Immagini ———————
Untitled
Undici dipinti
di Lindsey Harald-Wong

Voce d’autore ————————–
E l’attesa si è fatta tempo
Giulio Mazzali, “La pratica del buio”
di Giovanni Fierro

“Mondo, frastuono di cicale –// tramonta il giorno, s’accende/ sulla schiena la linea d’orizzonte”. Basta questa immagine per costruire l’ambito poetico dentro il quale si collocano le poesie di Giulio Mazzali, contenute nel suo nuovo “La pratica del buio”.
E il suo scrivere si muove così nei meandri dell’appartenenza dell’uomo a se stesso, nell’impegnativo proposito di riconoscersi ogni giorno, nel suo più profondo motivo d’esistenza.
Perché è un compito non facile, diventato però indispensabile, per porre fine alla confusione e allo smarrimento che il nostro tempo quotidiano, e la nostra società, stanno sempre più imponendo.
“Vana la speranza sarà/ cattivo tempo, sguardo/ immoto dalla riva”, di fronte ad un mare (o un fiume?) che rispecchia ogni possibile difficoltà, quando si esprime con la sua forza innata.
In un tempo dove “Non danno voce i morti,/ solo calce e cenere,/ come questa nebbia,/ che avvolge nella sera/ muri e linee d’ombra”; ma non è il momento di trovare la resa, anzi, perché “Tra macerie/ gratto il rimasto./ È tempo di guerra,/ ma il mandorlo/ saluta i rami/ scampati alla notte”.
Il rimanere è quindi la cifra stilistica dello stare al mondo, il riconoscere che “Lotta l’anima, non cede”.
Giulio Mazzali sa scegliere molto bene le parole a cui affidare la propria poesia. Necessarie e desiderate, le parole de “La pratica del buio” sono un disegno che a volte ha i tratti dell’incisione, in altri passaggi si abbandona alla trasparenza dell’acquerello, in altri ancora trova la forza della materia nuda, nella sua più sincera espressione primordiale.
Ed è sempre un continuo e totale avventurarsi, anche dove sarebbe meglio non guardare: “Precipita nel buio/ lo spettacolo del vuoto:/ la notte nel cuore dell’uomo”.
Il buio del titolo a volte è contenitore, altre è essenza di significato, non sta mai fermo nel suo palpitare, quasi come luce che brilla, che promette una chiarità. Come nel dire “Ma l’Amore scalda,/ rende l’ombra cosa salda”.
La natura in queste pagine è sempre presente. A volte controcanto, a volte confronto; sempre e comunque presenza che mostra la sua importanza, in un dialogo che svela e racconta, che indica e mostra, per riconoscere “la storia, gli affanni,/ il riflesso della notte/ nelle acque del mattino”; o nel suo avvicinarsi con fiducia ad una profezia che possa aiutare, “Sognare ciò che ancora non è dato:/ che l’albero ritorni alla sua terra,/ alla gioia viva della prima semenza”.
“La pratica del buio” è il gesto che rimane, la parola che nasce di nuovo.

Dal libro:
Dopo un’omelia
La delusione è imminente,
come quando alla partenza
hai promesso a tutti noi
che avresti richiamato.
E l’attesa si è fatta tempo
vuoto, lenta pratica del buio.
*
III
Dove sono i canti
le lievi piume d’ali?
Tace l’usignolo,
così la mia terra –
e quella sera
durata più a lungo
di una notte intera.
*
XI
Leggiamo ostinati
i vecchi segni,
nuova la via da seguire.
Il ricordo non è altro
che un viaggio di ritorno.
*
XIII
Sulla strada che da sempre
percorro, c’è un enorme
traliccio coperto d’edera.
Mio figlio vede in lui
un pugile pronto alla ripresa;
io, un nuovo crocifisso
prima della resa.
*
VI
L’uomo del mio tempo
crede ancora che una foglia
voli in alto senza vento.
*
Profezia
Crescerà tra notti e storture
la nuova umanità.
Come fico strappato
al morso della roccia,
lasciato al vento
freddo dei coltivi.
Fallirà il mare
nudo al proprio corso:
morirà nelle sue onde
sulla linea d’orizzonte.
*
Foglie
Attendono quelle rimaste
la carezza che solo l’inverno
può dare. Sagge come radici
sanno del buio, del silenzio
che accoglie chi cade perché
tutto sia nuovo, vivo nel tempo.

Intervista a Giulio Mazzali:
Riportare tutto alla dimensione originale dell’uomo, quella più vicina alle sue radici. Compiere il proprio passo verso il senso più profondo dell’essere umano. È questo l’invito di tutta “La pratica del buio”?
A tal proposito credo che le parole di Margherita Guidacci, scelte a introdurre l’ultima sezione del libro, chiariscano con nettezza il motivo generale dell’intera raccolta: “Patria dell’uomo è l’uomo e noi siamo tutti in esilio”. È l’esilio, infatti, inteso come buio smarrimento di una condizione originaria, a ispirare l’intero libro.
In apertura di raccolta esso è presentato con l’immagine borġesiana della rosa, che perduta nel buio della notte è però capace nella luce del ricordo di ardere più intensa della sabbia del deserto a cui l’uomo ha destinato sé stesso. Condizione, quella del deserto, caratterizzata da vuoto e disincanto, dall’assenza di visioni e paradigmi culturali alternativi. Una “stagione di sconforti” – usando le parole di Valerio Magrelli – in cui a sgomentare di più non è l’insensata e innaturale “voglia d’infinire”, ma il rifiuto, ormai diffuso, di qualsiasi caduta o inciampo.
Ai “vecchi segni”, ostinatamente seguiti, si contrappone però un’altra via, la possibilità di iniziare un nuovo viaggio di ritorno, capace di restituire all’essere umano una dimensione più autentica e non ancora totalmente compromessa. Ricordare sé stessi, senza disperare, scorgere nei gesti curiosi di un bimbo, nelle sue intuizioni, le tracce di un’umanità ancora vigile e in grado di fiorire.
Il libro è anche il riconoscere la propria identità, il portarla in rilievo. Il dialogo con il mare, con il tempo che si fa sera e il tramontare del giorno, con gli usignoli e i cani, è l’accadere a cui fare riferimento, per compiere questo atto? È la possibilità di conoscere e sviluppare nuove, o rinnovate, sfumature del proprio stare al mondo?
Ogni libro, letto o scritto, rappresenta un incontro, un’occasione per riconoscere e rilevare i caratteri della propria identità. Nella lettura la voce dell’altro consente nella sua peculiarità di delineare e definire con consapevolezza “con – fini” in grado di promuovere contaminazioni o forme di comunione.
Nella scrittura, al necessario dialogo intessuto con altri autori, si aggiunge il rapporto personale con la natura e le sue varie manifestazioni, spesso minute o usuali, forme a cui l’osservatore attribuisce un significato in grado di consentire una relazione che a volte si fa unica, misteriosa.
Il mare, la circolarità di un tempo quotidiano scandito da luce e ombre, il verso degli usignoli, il latrare dei cani, tutto trascende la dimensione puramente oggettuale per alludere a condizioni umane ed esistenziali. Relazione necessaria, quella con la natura, perché – come scrive Claudio Damiani nella Prefazione alla raccolta – “tutti torniamo alla natura, ci dobbiamo tornare, siamo costretti a tornarci”.
Natura in cui siamo immersi e che si trasforma senza interruzione, costringendo con il suo continuo e instancabile accadere alla maturazione di uno sguardo nuovo capace di cambiare il nostro stare nel mondo.
Perché poi ci pensano il vento e le foglie a ricordare la caducità della vita umana. È così?
Credo che non solo il vento e le foglie, ma la natura tutta, se osservata nelle sue forme, rammenti all’uomo la caducità e la precarietà della sua esistenza. Ma foglie e vento sono certamente speciali. È il loro incontro, infatti, a svelare nella quiete la presenza tangibile del tempo, la sua voce ridotta a muta assenza dal frastuono quotidiano, la presenza vigile, instancabile della morte.
Chi non ricorda Giacomo Leopardi, i versi contenuti nell’idillio “L’infinito”: “[…] E come il vento/ odo stormir tra queste piante, io quello/ infinito silenzio a questa voce/ vo comparando: e mi sovvien l’eterno, / e le morti stagioni, e la presente/ e viva, e il suon di lei […]”.
Lo stormire del vento, il fruscio delle fronde nel capogiro dell’eterno. Ma non basta. Tra le foglie alcune sono destinate per natura a un ciclo che dopo la caduta e la nudità invernale le restituisce al verde della fioritura. Sono loro, protagoniste di un’alterna vicenda mai interrotta, a chiarire allo sguardo di qualunque osservatore il carattere naturale della morte.
Essa, infatti, se ben considerata, rappresenta solo una variazione di ritmo nel fluire continuo della realtà.
E tutto questo lavoro di costruzione si rispecchia nella ricerca delle parole usate. Con la necessità di sceglierle in modo misurato, poche e significative. Quasi ad incidere la materia di cui si occupano, dandole così ancora più valore. Da cosa nasce questa decisione, questo scrivere?
L’individuazione del dettato, così scarno ed essenziale, è l’esito di un lavoro testuale che si propone di procedere per sottrazione, eliminando ogni elemento superfluo.
Se tale postura nei confronti della parola si pone in continuità con l’insegnamento ungarettiano, voluto è il tentativo di proporre una poesia che nella chiarezza della lingua pieghi il verso all’andamento del pensiero, che adatti – come ha scritto Evaristo Seghetta in un commento pubblico – “la parola all’idea”. Pensiero, che rinunciando ad ampie e usuali volute argomentative, si svolge per frammenti, prese d’atto e rimandi, con l’intento di conciliare concisione e forza concettuale, poeticità e leggibilità.
Nelle scelte compiute, oltre al modello ungarettiano, innegabile è lezione meditata nel tempo di alcuni poeti particolarmente amati, dall’ultimo Caproni a Montale, da Borges a Margherita Guidacci.
I testi de “La pratica del buio” indagano a loro modo il nostro tempo quotidiano. Che adesso è?
Se la poesia, come afferma Davide Rondoni, “mette a fuoco la vita”, contribuendo alla sua conoscenza, allora è plausibile – e forse inevitabile per il poeta – confrontarsi con il presente.
Questo è ciò che è accaduto nella stesura de “La pratica del buio”, la cui composizione, avvenuta a partire dal 2020, ha coinciso con accadimenti che hanno segnato in modo irrevocabile la nostra quotidianità.
Non solo il diffondersi della pandemia, ma l’introduzione di nuove tecnologie capaci di modulare profondamente comportamenti e percezioni, di promuovere mutamenti cruciali in ambito antropologico e sociologico.
La digitalizzazione, implementando la presenza dell’immagine nella quotidianità, e velocizzando attività e processi, non ha solo contratto vistosamente la nostra capacità immaginativa, ma trasformato gli usuali tempi di reazione, rendendoci “impazienti”, incapaci di sostenere l’attesa e la sua tensione.
A tali mutamenti, spesso accompagnati da una conseguente “crisi” del desiderio – a cui attesa e immaginazione sono legate – si aggiunge lo spazio assai generoso concesso dai media a eventi bellici, a emergenze o catastrofi climatiche, le cui immagini, trasmesse quasi quotidianamente, sono intervallate da programmi di intrattenimento e tentativi falsamente consolatori di pubblicizzare bellezze artificiali e beni superflui.
Se questo è il nostro presente, quale spazio può esserci per la poesia? A riguardo, in verità, ho pochi dubbi: se la poesia è dono dell’esilio, frutto maturato alla luce del ricordo, allora – oggi più che mai – i poeti sono necessari. Non solo a svelare le deformazioni di un presente dominato da una logica spietata, ma a rammentare senza mistificazioni la natura profonda dell’umano, a suggerire, rovesciando prospettive abituali, possibili visioni del futuro.

L’autore:
Giulio Mazzali è nato a Velletri (RM) nel 1979. Vive stabilmente a Cisterna di Latina, dove lavora come insegnante negli Istituti Superiori. Ha esordito nel 2018 con la sua prima raccolta poetica, dal titolo “Tempora”, con la quale nel 2019 ha partecipato a numerosi Premi, ottenendo riconoscimenti di merito e recensioni su riviste e blog.
Nel luglio del 2020 una sua breve raccolta di editi, “L’ora della veglia”, è stata inclusa nell’antologia dal titolo “Tramontana”.
“La forma nascosta della luce”, pubblicata nel giugno 2022, è la sua seconda raccolta poetica.
Dal settembre 2022, inoltre, collabora con la rivista De Cultura Magazine Artes, trimestrale edito dalla Fondazione De Cultura.
(Giulio Mazzali “La pratica del buio” pp. 91, 15 euro, 2024 peQuod 2024)
Immagini ———————
Heaven and earth
Undici dipinti
di Lindsey Harald-Wong

Voce d’autore ———————–
Domo piardint si podarâ cjatâ Soltanto perdendo si potrà ritrovare
Lussia di Uanis, “di tiara e aga”
di Giovanni Fierro

Tornare alla natura, alla sua dimensione spirituale e generatrice, tenendo gli occhi ben aperti sul nostro presente, nutrendo così il proprio sguardo di rinnovata sorpresa e chiara capacità critica.
Perché è questa la sfida del nostro tempo, riuscire ad appartenere a ciò che rimane dell’umanità conosciuta e condivisa, e non farsi sottomettere da una società che ha ormai dimenticato e violentato ogni innata appartenenza al mondo naturale.
E tutto questo lo si respira a pieni polmoni nel nuovo libro di Lussia di Uanis, “di tiara e aga”, raccolta poetica che copre la sua produzione poetica degli ultimi trenta anni.
Un libro di terra ed acqua, di sincera difesa di quel poco che rimane a ricordarci del nostro vivere in sintonia con la Terra, immerso in attimi di pura percezione umana, attimi dove tutto trova il suo perché, quando “distirâts suntun rapâr dal Isuns/ cjalìn nûi svelts che arin chist fasolet di sîl,/ siarât tra li ramassis ancjamò crotis/ da li agassis” (“stesi sull’argine dell’Isonzo,/ guardiamo nuvole veloci arare un fazzoletto di cielo/ chiuso fra i rami ancora nudi delle acacie”).
Lussia di Uanis costruisce così una geografia dove la terra, l’acqua, il mare, l’aria, i venti, sono il luogo dell’appartenenza primordiale, da rinvigorire e da cantare, anche se può solo essere un dolente canto di primavera: “Se no podi vistimi/ dal sflandôr/ di flôrs d’amôr/ m’incalmarai al cûr/ ros , sanganant/ cuntun ramàs/ di cuargnâl zâl” (“Se non posso vestire/ lo splendore/ di fiori d’amore/ m’innesterò il cuore/ rosso, sanguinando/ con un ramo/ di corgnolo giallo”).
La bassa friulana e Grado, Monfalcone e il monte Sernio, sì, questa geografia si rinforza dal suo scrivere in friulano, lingua legata alla terra, gesto di fiducia nel tempo che è stato e che ancora può essere, nel suo mostrarsi come bisogno di sacro – ma il sacro di Pasolini – e desiderio di trovare nuove ed altre coordinate del vivere, in contrasto con l’attuale società che nel profitto vede la propria fede, l’unico possibile credo.
“Mâr di Monfalcon/ sitât sensa orizont/ sclissada fra/ rotais e puart/ mont e mâr,/ l’orizont mai” (“Mare di Monfalcone/ città senza orizzonte/ schiacciata tra rotaie e porto/ monte e mare, l’orizzonte mai”), lo sguardo di Lussia di Uanis non accetta compromessi, è in costante ricerca di verità con cui confrontarsi, scava dentro le apparenze, non si ferma di fronte all’ovvio, non accetta le facile risposte consolatorie.
Anche quando si trova sul golfo di Panzano, sulla Sdobba: “Ai simpri cjalât chist mar/ cui pîs su la tiara/ di nort a sud spietant svint/ maregjadis e l’inaltrò/ contant lis stelis tal so grin neri/ e smirant lunis inta sôs aghis/ inneant paraulis vita misteris/ ta lis sôs distansis” (“Ho sempre guardato questo mare/ con i piedi a terra/ da nord a sud aspettando vento/ mareggiate e l’altrove/ contando stelle nel suo nero grembo/ e ammirando lune nelle sue acque/ annegando parole vita misteri/ nelle sue distanze”).
C’è un che di raccolto ed intimo in tutto “di tiara e aga”, una parola sospesa che rimane fra le altre parole dette e scritte, una sospensione che contiene tutto il silenzio necessario per portare a sé l’attenzione che si deve alla vita stessa, al sua manifestarsi con la bellezza – e fragilità – della natura, in quel cortocircuito di senso che porta a mettere in evidenza discrepanze e mancanze, illuminazioni e radici, vuoti e incrinature, desiderio di rivalsa e gioie, attimi che fiorisco ed altri che si perdono: “A viarzi i vôi/ su la tiara sfrutada/ come i cuarps des feminis,/ tirade su fin al ultim grignel/ a lustri sensa arbatis/ sensa rivâi sensa ritualitât/ sensa lunis e cjants di prosperitât” (“Apro gli occhi / sulla terra sfruttata/ come i corpi delle donne,/ ripulita fino all’ultimo granello/ tirata a lucido senz’erbacce/ senza sponde, senza ritualità/ senza lune e canti di prosperità”).
È un camminare il fare di poesia di Lussia di Uanis, a passo libero e attento, una mappa sensibile dove poter trovare gli occhi buoni per riconoscere un momento, raro e prezioso, di pace, a Porto Buso, nella laguna di Grado, dove “la casa dei finanzieri/ affacciata al mare/ ha il tetto crollato/ e le finestre divelte/ tutti i venti vi fanno il nido/ assieme alle rondini/ che si tuffano intrepide/ nel cielo cangiante della sera”.

Dal libro:
Piardi
Domo piardint si podarâ cjatâ.
La devastazion che mi à sfolmenâda
sarà al frait da semensa
che al rinassarâ in forment.
(Dael 1993)
Perdere
Soltanto perdendo si potrà ritrovare./ La devastazione che mi ha stravolta/ sarà il marcio del seme/ che rinascerà in frumento.
(Aiello del Friuli, 1993)
*
Mari
Jo soi fia di mê Mari e
mê Mari je bionda come me.
A’nd ài tetât tal so grim
l’odôr di tiara indurmidida
cuant che ancjamô i mei vôi
erin infinît.
A’nd ài tetât al so dismovisi
ta viarta
tal nulôr di violis e primulis.
Jo soi fîa di mê Mari e
mê Mari je bionda come me.
Bionda
sensa cunfîns!
Bionda
nuia barrieris!
E al pàs dal turc
dal ungjar, venit, talian, cruc
l’àn violada
l’àn bagnada
ta l’oscuretât crudela dal sanc.
Mê mari
ta viarta resurìs.
Ta sô madrassa
la muart doventa vita
la semensa forment.
Jo soi fîa di mê Mari e
mê Mari je bionda come me.
No vin bandieris tal grin,
né vuardiis,
al nulôr nol si ferma sul stec.
(1996)
Madre
Io sono figlia di mia Madre e/ mia Madre è bionda come me.// Ho succhiato dal suo grembo/ l’odore di terra addormentata/ quando ancora i miei occhi/ erano infinito./Ho respirato il suo risveglio/ a primavera,/ nel profumo di viole e primule.// Io sono figlia di mia Madre e/ mia Madre è bionda come mè./ Bionda/ niente confini!/ Bionda/ niente barriere!// E il passo del Turco,/ dell’ungaro veneto italiano crucco/ l’ha violata/ l’ha bagnata/ nell’oscurità crudele del sangue.// Mia Madre a primavera/ risorge./ Nel suo ventre/ la morte diventa vita/ il seme frumento.// Io sono figlia di mia Madre e/ mia Madre è bionda/ come me./ Non abbiamo bandiere/ in grembo,/ né guardie/ il profumo non si ferma fra i rami.
*
Luna plena
Ta gnots di luna plena, gravida,
ancja jo orès implenâmi,
scuintrâmi cuintra un cuarp
che’l vedi teneressa
e muardôns e voi profonts,
scuintrâmi cuintra
mans, argagn e bocja
par sberghelâ cun me
tant che licantropos
suntuna colina blu
a chista luna smavida di lui.
(1996 – Monfalcon Cors dal Popul)
Luna piena
Nelle notti di luna piena, gravida,/ anch’io vorrei riempirmi,/ scontrarmi contro un corpo/ che abbia tenerezza/ morsi e occhi profondi,/ scontrarmi contro/ mani e attrezzo e bocca/ per ululare con me/ come licantropi/ su una collina blu/ a questa luna sbiadita di luglio.
*
Laguna di Grau
La gnot si spielava in laguna
e il cjar grant poiava al timon
su li ciminieris da zona industriâl
Aussa Cuar.
Jo pagaiavi
tal grin neri da laguna
lavi dentri al incjant
sul or dal cei dal mont.
(2015)
Laguna di Grado
La notte si specchiava nella laguna/ e il Grande Carro appoggiava il timone/ sulle ciminiere della zona industriale/ Ausa Corno.//Io pagaiavo/ nel grembo della laguna/ mi inoltravo nell’incanto/ sull’orlo dell’orizzonte.

Intervista a Lussia di Uanis:
Le poesie di “di tiara e aga” coprono uno spazio temporale che va dal 1993 al 2023. Cosa è cambiato, in questo lungo periodo, del tuo scrivere, e cosa invece è rimasto uguale, lo stesso?
La mia raccolta “Di tiara e aga” attraversa trenta anni di vita, è gran parte della mia vita consapevole, sono l’arco di tempo in cui ho cominciato a fermare la mia coscienza con un segno tangibile nero su bianco e la metà dei miei anni su questo pianeta.
Quando ho cominciato a scrivere le parole uscivano veloci, irruenti, necessarie come un respiro, uscivano dal dentro al fuori, dall’oscurità alla luce. Come una giovane fonte.
Ora, le parole le lascio spesso andare, senza fermarle con una specie di stanchezza, con una specie di rassegnazione. Forse non le trovo più vitali, forse ne ho visto la vanità, forse sono invecchiata.
Queste tue pagine sono anche uno sguardo molto critico verso il decadimento della nostra società. Ed in particolare per quello che è l’impatto devastante del cemento, ma dell’urbanizzazione sfrenata in generale, nel nostro territorio. Che presente stiamo vivendo?
Provengo dall’altro secolo, dall’altro millennio, sono testimone di ciò che non c’è più. Parlo della pianura da cui provengo, della pianura che mi è Madre. Acqua che si poteva bere, campi curati con amore, i pesci nelle rogge, lepri caprioli, fagiani, boschetti, fiori a primavera, fiori ad ogni stagione.
Ho sempre camminato nei campi, fin da quando ero piccola. Mi rendo conto che questi discorsi sembrino di rimpianto, ma quello che muore sulla terra è tragicamente la vita stessa, io posso non esserci ed è naturale, ma se muore l’acqua, le piante le diversità questo è angosciante, è senza ritorno.
Nel mio scrivere quando ero più piccola, la natura era semplicemente la forma e la metafora del mio essere, poi con gli anni ha cominciato a rivelarsi la verità. Se all’inizio della mia vita, guardavo soltanto la bellezza poi ho incominciato a vedere, a mettere nel mio quadro espressivo anche la maledetta mano dell’uomo, mano che deturpa e violenta.
Tutto “di tiara e aga” ha un respiro spirituale, che riporta alla dimensione di madre terra. Quanto, e in che modo, è importante viverlo e difenderlo?
A mio parere è molto importante che l’essere umano prenda coscienza piena del luogo che gli è radice, senza cercare in cielo lo spirito dell’essenza è qui, siamo fatti della stessa materia dell’universo, in nostro pianeta lo è, noi lo siamo. L’essere umano “grazie” anche a certe religioni da alcuni millenni si sente superiore a tutto ciò che è vivente, il suo è un atteggiamento di sfruttamento, pionieristico, direi mascolino. La Madre è in noi però, subisce e restituirà. Noi siamo poco importanti nel tutto, le nostre civiltà, scompariranno prima o dopo e gli sbagli verranno pagati.
Terra e mare in questo tuo libro si incontrano. C’è quasi un parlare tra di loro, di cui tu sei testimone e la tua poesia ne è la voce…
Terra, mare, cielo, sono i luoghi della regione in cui vivo. Cieli così grandi come in pianura non ce ne sono, la corona di monti che la cinge, visibile dal mare, accorcia la profondità dello sguardo ma in qualche modo lo rende più maestoso.
La terra è luogo di passi, di cammino lento in cui andare, rotolando nei pensieri, fra le distanze coperte e l’essenza interiore, così anche il mare attraversato lentamente sulla mia piccola imbarcazione in solitudine. Andare a zig zag “trastolonant” come un marinaio ubriaco è libertà, di questo sono certa, uscire dallo schema dei “devo” è libertà. Farsi pronti ad accettare quello che accade fuori dalle consuetudini è libertà.
In questo piccolo libro ho a volte messo il riferimento delle strade che attraversavo mentre nascevano le parole, perché i luoghi diventavano i miei pensieri e i miei pensieri ho restituito in queste pagine andando dai monti della Carnia da dove provengono i miei avi al mare che mi ha sempre cullato con i suoi orizzonti aperti.
Con l’acqua ho un sentire fondo, viscerale, di terra mi sento, la carne è terra. Ho attraversato terre mari e fiumi e terre mari e fiumi mi hanno attraversato, tutto qui, tutto qui.

L’autrice:
Lussia di Uanis è nata nel 1964 ed è originaria di Aiello del Friuli (Ud). Ha fatto parte del gruppo poetico Trastolons e del movimento artistico Usmis. Ha scritto per il teatro e realizzato spettacoli per bambini e scritto i testi per diversi gruppi musicali friulani, come Zuf de Zur, Bande Tzingare, Ulisse e i Ciclopi. Dal 2000 ha lavorato come animatrice in scuole e biblioteche con progetti narrativi volti alla creatività. Ha pubblicato i libri “Intal sac da fantasia”, “L’arbul Feliç”, “Benrivâts tal marimont”, “Il gjalut postin”, “La gnot dai muarts”, “Pierin Pieron e la strie Bistrie”, “Gno von Bepopalon” e il quaderno di lavoro di educazione ai sentimenti “Mai più Barbablù – Il lieto fine incomincia dall’inizio” con la collaborazione di Linda Battiston e Francesca Benvenuto.
Negli ultimi anni ha tenuto incontri con i ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori della regione sul tema della violenza sulle donne. Ha realizzato il video bilingue “Il bon acet / L’accoglienza”.
(Lussia di Uanis “di tiara e aga” pp. 73, 12 euro, Kappa Vu 2024)
Immagini ———————
Mars harbour
Undici dipinti
di Lindsey Harald-Wong

Voce d’autore ————————
Insegnami nel corpo la danza urgente del fiorire
Claudia Fabris, “La Cameriera di Poesia. Piccola ristorazione dello spirito” e “Parole sotto sale. Piccolo vocabolario poetico”
di Roberto Lamantea

Attrice, vocalist, poeta, Claudia Fabris è la “signora dei palloncini”: va in giro per le strade e le piazze delle città con dei palloncini annodati ai capelli. Trasforma i luoghi in stanze magiche: uno spazio pubblico o una casa privata, un teatro o una piazza. Il pubblico può scegliere il menu, “antipasti, dolci, caffè, liquori, grappe e amari di parole”. Siamo accolti con dolcezza, ci offrono delle cuffie cordless, Claudia è al computer e al mixer. Oltre alla voce-canto delle sue poesie ascolteremo la voce-canto del cielo, degli oceani, e una pagina tra le più belle della musica lirica, “Casta diva” dalla Norma di Bellini: “Casta diva che inargenti/ queste sacre antiche piante”: la casta diva è la luna.
A Mirano Claudia Fabris – grazie a Echidna e Comune di Mirano – ha allestito lo spettacolo al castelletto di Villa Belvedere, una torre neogotica ottagonale costruita a metà Ottocento con grotte e misteriosi canali sotterranei, circondati dal bosco, con un emozionante effetto fiaba.
Nel 2020 Claudia ha pubblicato da animaMundi “Parole sotto sale. Piccolo vocabolario poetico”; ora l’editore di Otranto dà alle stampe “La Cameriera di Poesia. Piccola ristorazione dello spirito” che, dello spettacolo, è l’anima, la nervatura, il vestito.
L’universo canta. L’acqua canta, cantano le stelle, anche le pietre cantano. Il canto delle balene: è un canto d’amore, infinito, struggente, della balena madre ai suoi cuccioli, un sonar per le altre creature dell’acqua, un’invocazione, una preghiera. E noi superiore specie umana le arpioniamo e le ammazziamo, lentamente con fiocine e bombe, e l’oceano cambia colore da blu a rosso.
Anche le stelle cantano: il loro suono arriva dall’infinito ed è un coro, un’invocazione, sembra una laude. Il canto delle stelle è stato catturato da un radiotelescopio negli Stati Uniti: è struggente. Sono vive, le stelle?
Canta l’acqua e ha una voce diversa se “suona” – come strumenti musicali – dei ciottoli larghi o più piccoli, ruvidi o lisci. Le pietre cantano, come aveva intuito Marius Schneider.
Cantano le lingue, con le loro note e i loro accordi di fonemi, il concerto delle etimologie che, da un’antica sapienza a oggi, rivelano come le parole – dal sanscrito, l’ebraico, il greco antico, il latino, agli idiomi romanzi all’inglese – ci raccontano chi siamo e come siamo nel mondo. Cor, cordis, sino alla lallazione delle prime sillabe. E infanzia, dal latino infantia, da infans, composto da in-, negativo, e il participio presente del verbo fari, parlare, significa letteralmente “che non parla”: ma dalla sillaba labiale ma- ma- nasce mamma.
È poesia tutto questo. Poiesis: fare (dal verbo greco poieo). È poesia è canto ed è ascolto, è sentire l’universo, sentirsi universo, non nell’universo ma parte di esso.
Claudia Fabris è nata a Padova nel 1973, ha lavorato con il Tam-Teatromusica, è fotografa, attrice e cantante, vive perlopiù nel Sud Italia. Dal 2011 è “cameriera di poesia”. È “gentilmente nomade”.
Poesia è voce: lyrica nasce con la lira, la poesia greca, grazie alla sua metrica stupenda, si cantava. “La poesia deve essere detta, suonata. Deve essere letta ad alta voce, risuonare, riverberare”. È l’incanto fonico di Mariangela Gualtieri e della Valdoca – “incanto fonico” è una formula di Amelia Rosselli: “La poesia, nata con la voce, con il canto, deve essere letta ad alta voce, risuonare, riverberare”, scrive Fabris all’inizio del libro, “il ‘900 l’ha relegata in una relazione intimista, una relazione di coppia silenziosa tra gli occhi del lettore e la pagina del poeta, l’ha rinchiusa nella mente, ma la poesia è un fare, un fare del corpo (deriva dopotutto da un verbo greco che significa per l’appunto “fare”) e se non la dici, se non la canti, vive solo a metà”.
Ci sono poesie cristallo, scrive Claudia nella premessa del libro, poesie fiori, poesie ruscelli, c’è anche la prosa quotidiana messa in versi: “Comporre questo libro è stato attraversare il tempo e la forma e a dire il vero non posso dire di quale natura siano le poesie che leggerete, non ho certo la pretesa siano cristalli, anche se forse qualche piccolo cristallo di rocca c’è, di sicuro ci sono fiori, qualche ruscello e delle prose incorniciate in versi. Un mazzo di fiori di campo, raccolti in stagioni diverse”.
Claudia Fabris crede così tanto nella poesia – nella poesia che rigenera chi l’ascolta – da chiedere che sia riconosciuta come servizio sociale.
Se la sua visione può in parte essere accostata alla lirica di Mariangela Gualtieri o Chandra Candiani – ma lo sguardo d’amore per ogni cosa, un’ape o lo stelo d’un fiore, rinvia all’immensa Emily Dickinson – e proprio la Gualtieri, racconta, le ha rivelato la poesia come “brivido del corpo” – “La Cameriera di Poesia” è un inno.
La fiaba-apologo “La farfalla”, delicata come le ali del lepidottero; l’invito all’erba perché le insegni a rinascere; la preghiera “Madre Nostra”; l’etimologia che ci rivela chi siamo (“Il corpo inizia con il cuore”: cor-); “Credo”: un cantico delle creature. Fino alla poesia esplicitamente erotica di “Vorrei”, che rinvia a Saffo (ma c’è anche un omaggio a Catullo: “Sono tutta bocciolo/ Pienezza che s’apre al morso. […] Baci/ datemi/ Baci/non la solitaria solita attesa/ Baci voglio/ lunghissimi e lenti”.
Explicit, come ha scritto Guido Celli: “Un giorno un giornalista andò da un poeta/ e gli chiese:/ ‘Qualora le si incendiasse casa, lei cosa salverebbe?’// Il poeta rispose:/ “’Il fuoco’”.

Dal libro:
La farfalla
È l’alba
una farfalla è posata a terra sulla ghiaia bianca
Sbatte le ali
Vola un attimo e cade
Vola un attimo e cade
La prendo in mano delicatamente per aiutarla
ma
Vola un attimo e cade
Riprovo
Cade
Sta morendo
il mio cuore perde un battito
arriva un amico
gliela mostro commossa
la guardiamo morire
distogliamo lo sguardo
e lei senza suoni
senza avvisare
dopo l’ennesima caduta
spicca il volo senza esitare
Non stava morendo
Stava solo imparando
ma io non sapevo vedere la differenza
anche se ero lì immobile a guardare
*
Vegetale Abbondanza
preghiera per il tempo che viene
e lo chiederò all’erba
calpestandola per ore
Insegnami
Insegnami
la scandalosa tua verde abbondanza
che non ha mai misura
La danza con dentro un canto
che non fa mai un conto
e non ha paura
La crescita sfacciata dopo ogni taglio
che profuma l’aria a ricordare il suo rigoglio
Insegnami la fede perfetta del seme
che ovunque cade
e sull’asfalto sogna il fiore
E tu uomo
che cammini in fretta lo incontri
e lui col suo coraggio
ti allaga il corpo di stupore
Insegnami nel corpo la danza urgente del fiorire
che va sempre a tempo
quel suo sbocciare al sole senza alcun pudore
senza alcun tormento
e segnami nel cuore la promessa
di ogni fiore che sarà frutto
e si farà seme
e morirà e germoglierà
ancora e ancora
senza misura
senza paura
e allora forse sarò anch’io docile e visionaria
come la quercia immobile
che immagina nuove crescite
mentre tu spezzi i suoi rami senza chiedere
*
Madre Nostra
Madre nostra
che sei qui in terra
sia santificato il tuo Corpo
sia benedetto il tuo Cuore
Avvenga la tua Primavera
Come in alto così in basso
Nelle vette e negli abissi
tra le stelle e i nostri corpi
Fiorisca la tua natura
e crescano i tuoi semi
Siano forti i tuoi desideri
Dacci oggi il nostro cibo quotidiano
e nutrici nell’abbondanza
Come noi nutriamo i nostri figli
Insegnaci il tuo Amore
Insegnaci il tuo Dolore
Insegnaci la tua Violenza Pura
Insegnaci a danzare la tua Furia
Liberaci dal desiderio di possesso
e della Morte liberaci solo dalla paura
Così sia
*
Il corpo inizia con il cuore
2020 durante il lockdown
C’è un luogo del corpo in cui siamo tutti Uno
uomini, animali, rocce e minerali
pianeti e vegetali
Il tuo cuore
Il corpo inizia con il cuore
tiene proprio il coraggio
il corpo inizia con il cuore e lo corregge
fino al perdono lo regge
Nel corpo è la sapienza
il ricordare
“perché se non è nella carne
la conoscenza fa solo rumore”
Il corpo è il nostro confine
il nostro spazio nel tempo
e ad occhi chiusi non ha mai fine
corpo sapiente
corpo paziente
corpo perfetto
corpo corretto
corpo tradito
corpo punito
corpo adorato
corpo lavato
Mi sono accorta lentamente
che il Corpo inizia con il cuore
Cor-cordis – il cuore in latino
e se la P in ebraico è la lettera della bocca che si fa parola
il corpo diventa allora un cuore
che si fa lingua e parola
Devo curarlo di più
questo mio povero corpo
se è la lingua del mio cuore-amore
Gli esseri umani lo scoprirono per caso
in un orfanotrofio
perché i corridoi erano molto lunghi
e il tempo per le carezze c’era solo all’inizio
I bambini nel fondo venivano ben lavati e ben nutriti
ma non c’erano mani per toccarli
e morivano
Senza che avesse alcun senso per la mente, morivano
Ma il corpo inizia dal cuore e non sa mentire
Morirono denutriti, anche se mangiavano
Chi sopravvisse non camminava e non parlava
Allora lo seppero
Noi esseri umani abbiamo più fame di carezze
che di cibo
Noi vogliamo essere toccati per avere un po’ d’affetto
Noi esseri umani abbiamo bisogno di essere toccati
per esistere
Tocar è suonare in spagnolo
se tu mi tocchi io suono
se tu mi tocchi io sono
e mi fai essere

Intervista a Claudia Fabris:
Tu non ti definisci poeta e scrivi che la poesia relegata nella pagina e vissuta solo con gli occhi “è vissuta a metà”. Mariangela Gualtieri, citando Amelia Rosselli, parla di “incanto fonico” della poesia. La poesia – sottolinei – è canto, voce, corpo, teatro. Penso anche al fenomeno recente della poetry slam . Nell’antica Grecia la poesia è nata con la musica (“lirica” deriva da lyra). Secondo te, anche grazie al tuo lavoro, stiamo riscoprendo queste radici? E che cosa pensi della poetry slam?
“La Cameriera di Poesia” è nata per far sentire agli altri quello che io provavo leggendo, come ho scritto nel libro, mi è accaduto davvero spesso di avere come ospiti persone che prima di iniziare ci tenevano a dirmi di non essere frequentatori e amanti della poesia, quasi mi volessero preparare, e che alla fine tornavano stupiti a dirmi che l’esperienza li aveva toccati.
Di sicuro la poesia sta tornando a vivere, ad essere suonata, condivisa e letta a voce alta, anche se il mio angolo prospettico sulla questione è un po’ troppo partigiano, nel senso che fa parte del mio lavoro e frequento persone particolarmente sensibili al tema.
Partecipo dalle prime edizioni al festival “La Luna e i Calanchi” di Aliano creato e diretto da Franco Arminio, una sorta di happening ininterrotto di quattro-cinque giorni, che trova nella poesia e nel desiderio di condividerla nel quotidiano il proprio fulcro e devo dire che ho visto costantemente crescere la partecipazione e l’interesse negli anni, sia per il festival in particolare che per la poesia in generale; anche la parabola del successo che coinvolge direttamente Franco, in una certa misura, mi sembra confermi questo risveglio della poesia.
Una cosa la penso spesso: alla fine dell’800 non sarebbe stato improbabile che alla proverbiale domanda “Cosa vuoi fare da grande?” un giovane rispondesse “il poeta”. Ora credo sia assai difficile, per non dire impossibile e il motivo penso stia nell’aver isolato la poesia per molti anni in una torre d’avorio quasi inaccessibile frequentata solo da intellettuali ed esperti, averla separata dal corpo, sociale e personale. Ridarle la voce è restituirla al corpo, perché da un corpo sempre nasce, farla tornare in gestazione nei corpi di chi la legge perché possa rinascere, sempre.
A dire il vero non conosco bene la poetry slam, so cos’è, ho visto qualche video, mi riprometto sempre di andare a vedere qualche incontro, magari anche di iscrivermi, ma l’idea che ne ho è piuttosto vaga.
A quanto ho capito, mi sembra un buon modo per avvicinare la gente alla poesia, o meglio per avvicinarla al nostro tempo, personalmente credo di prediligere una dimensione più intima, quando i versi rimbombano nel silenzio anche se sono sussurrati, ma potrebbe essere solo un pregiudizio e non escludo affatto di provare a praticarla in futuro.
Ci racconti come sono nate le tue performance? “La Cameriera di poesia”, “la Signora dei palloncini”…
“La Cameriera di poesia” ha avuto una lunghissima gestazione. Nel 2004 avevo creato un reading per l’Università di Padova sulla poesia della Galizia, all’ennesima replica con Silvio Barbiero, l’attore con cui condividevo la scena, decidemmo di creare una sorta di osteria nello spazio teatrale dei Carichi Sospesi, che lui aveva aperto da poco con altri soci. Eravamo vestiti da camerieri e le persone accomodate in lunghi tavoli in mezzo alla scena avevano delle tovagliette con le poesie stampate.
Prendevamo le ordinazioni delle poesie e tra un servizio e l’altro offrivamo vino e tortillas spagnole che avevo cucinato per giorni. Ritrovai in quella occasione il ruolo della cameriera, dopo anni che non era più il mio lavoro; ricordo che mi piacque tanto da pensare di riprenderlo, in scena.
In quel momento immaginavo una performance più semplice, molto duttile, da poter portare ovunque, un menù di testi da cui il pubblico potesse ordinare e io che, indossando i panni di una cameriera li servissi, recitandoli.
Quella sera ai Carichi mi sorse il dubbio di essere un’attrice migliore indossando la maschera della cameriera, una maschera dietro cui ero libera di agire e sparire per creare una relazione intima con il mio ospite nel momento in cui ha bisogno di me per nutrirsi. Quest’idea rimase dentro, in gestazione, per sette anni, e quando nel 2011 pensai di utilizzare delle cuffie wireless, da una postazione con microfono computer e mixer, capii che era arrivato il momento di creare la perfomance, perché le cuffie generavano la possibilità di una reale intimità e di lavorare su tonalità delicate della voce per far provare a chi ascoltava ciò che io provavo leggendo.
Mi è sempre piaciuto essere il tramite tra una persona e il cibo, è una situazione in cui gli esseri umani si rilassano e aprono un varco nelle loro barriere di difesa. In quel momento la figura della cameriera mi è sembrata perfetta per chi è a doppio servizio, del pubblico e delle parole, per chi deve farsi strumento e sparire dietro quel ruolo.
“Nostra Signora” è tutta un’altra questione, l’immagine è nata nel bagno di casa mia, da un’altra performance, La Bambola. Avevo avanzato un po’ d’elio in una bombola usa e getta e ho provato a vedere cosa succedeva se legavo una ciocca dei miei capelli a un palloncino, ricordo l’eccitazione davanti allo specchio, era gennaio-febbraio 2013.
Quell’anno d’estate ero in residenza a Napoli ad Altofest per l’Operappartamento con altri due artisti e l’ultima immagine di quel lavoro divenne io che apparivo dietro una grande finestra su una terrazza con i palloncini che sorreggevano i miei capelli. Al termine di una replica di quella performance un regista di Milano, Marco Linzi, mi disse: ma così dovresti andarci per la strada.
E così feci, il giorno di San Gennaro del 2013 a Padova decisi di farmi una camminata per la città con la terra sotto i piedi e il cielo tra i capelli, inizialmente era questo il titolo. Ricordo che appena misi il primo palloncino mi prese una sorta di leggera euforia.
In quei giorni ragionavo sul fatto che spesso quando l’arte diventa il tuo lavoro, il cuore, la gioia creativa rischia di diventare ciò che fai nei ritagli di tempo dopo che ti sei occupato di tutto il resto, i contratti, la comunicazione, le questioni organizzative e che avevo la necessità di concedermi di fare qualcosa solo per la gioia di farlo, senza organizzarlo, comunicarlo e senza neppure farmi pagare, come un regalo a me stessa e a chi avessi incontrato per ricordarmi perché faccio quello che faccio.


Come costruisci un tuo spettacolo?
Con la mia vita. A volte dico che i miei lavori li costruisce la vita, io semplicemente li raccolgo. Sono il frutto di ciò che ho incontrato, compreso, amato e sono sempre direttamente connessi con ciò che ho vissuto e crescono, si trasformano con me. La Cameriera quando è nata nel 2011 era molto differente, c’era un menù da cui gli ospiti sceglievano, era diviso in tre sezioni, Classici, Contemporanei e della Casa.
I piatti della Casa erano i miei testi originali, ogni sezione era suddivisa in antipasti, piatti e piatti unici e le persone potevano ordinare cosa ascoltare esattamente come al ristorante. Poi si sono aggiunti i dolci, le canzoni, mi sono resa conto di poter cantare, i primi dolci erano a due voci e due lingue, una registrata e l’altra dal vivo, tratte da quel famoso recital sulla poesia della Galizia da cui tutto aveva avuto inizio.
Dal 2013 si sono poi aggiunte le Parole sotto sale, le definizioni del mio piccolo vocabolario poetico. Poi sono arrivati gli amari, i liquori e i caffè, aforismi e versi brevi, lapidari, con cui chiudere come con una sequenza di fuochi d’artificio.
Dopo una conferenza-spettacolo a Roma di Marcello Sambati, grande poeta, performer e regista, in cui faceva ascoltare, tra una poesia e l’altra, registrazioni del vento fatte durante tutta una vita, mi sono comprata un piccolo registratore digitale e ho iniziato a tenerlo sempre con me per registrare i suoni e le voci che incontravo e che mi sembravano interessanti e ho iniziato a inserire quei suoni.
Poco alla volta, negli anni, la parte sonora è divenuta importante quanto quella della parola e ora creo io il percorso drammaturgico che credo possa aiutare i miei ospiti nell’abbandono all’ascolto.
Un altro grande passaggio, per la Cameriera di Poesia ha riguardato l’inserimento dello sguardo scientifico, trovo ci sia un’immensa, commovente poesia nella comprensione della fisica e dell’universo che abitiamo, togliere le barriere tra poesia e scienza fa parte del mio percorso da sempre e negli ultimi anni ho iniziato a collezionare testi e riflessioni scientifiche che rivelano la poesia della Natura, ho anche chiesto a dei ricercatori di inviarmi le loro riflessioni in merito.
Per rispondere alla domanda più in generale ciò che mi accade di solito è di avere un’intuizione, una visione e farla crescere con me, farla lievitare vivendo fino a che non trovo la forma in cui la sento sufficientemente compiuta da poterla condividere e questa forma diviene quasi sempre il primo step di un lavoro che spesso non conoscerà una fine.
Nel 2006 ho scattato le prime foto di un lavoro dedicato all’ombra, che poi è cresciuto, poco alla volta, con video, testi, un’installazione praticabile, una performance e infine una drammaturgia in cuffia da ascoltare percorrendo la mostra.
“Hombre, la rivelazione della luce”, questo è il titolo, ha trovato la sua forma più compiuta nel 2018, ma non l’ho ancora realizzato interamente per come l’ho immaginato e nel frattempo continuo a scattare foto e fare piccoli video che lo arricchiscono.
“Akis Calendar”, lo spettacolo forse più bello che io abbia fatto nel 2015 a Napoli, nasce dalla ricostruzione della relazione sorprendente e puntuale tra la mia vita e un mito greco ambientato in Sicilia, quello di Galatea. Il viaggio che mi ha condotto al riconoscimento della tessitura di coincidenze, come una mappa nascosta in filigrana a partire dal mio nome, è stato una vera e propria caccia al tesoro iniziata il 6 gennaio 2008 riannodando fili apparentemente lontani nel tempo e nella mia vita.
L’opera ha trovato nel 2015 la sua forma più coerente, la sua più precisa rivelazione, in una immagine che avevo cercato di creare a Malta nel 2000, senza per altro riuscirci allora nella forma che desideravo: una piscina di latte in cui nuoti un corpo su cui vengano proiettate delle immagini.
Mentre il latte assorbe l’immagine rendendola opaca, il corpo la riflette facendosi schermo e strumento della rivelazione. Questa era l’ultima scena dello spettacolo a Napoli. Ho appena realizzato a Bitonto per Verso Sud “La Luce della voce” una performance di quaranta minuti per luce e voce, in cui un organo di luce, una installazione luminosa ispirata alle lampade teatrali di Leonardo, dialoga con l’ascolto in cuffia di parole e suoni.
Questo lavoro aspettava dal 2011 di venire alla luce, letteralmente, da quando feci l’installazione in una misura ridotta, che risultava solo un quadro, all’interno di uno spettacolo molto più ampio. Ora oltre ad aver trovato una nuova forma fisica, ben più grande, che ne onora la bellezza e la rende unica protagonista dell’opera, le ho costruito attorno una drammaturgia di suoni e parole da ascoltare in cuffia, che accompagnano, approfondiscono ed esaltano la visione.
Prima d’ora non le avevo queste parole, la parola è arrivata per ultima nella mia vita.
Quali sono i poeti che ami di più?
Non sono una studiosa o un’esperta di poesia, mi considero piuttosto ignorante, la frequento da amante, la leggo in maniera disordinata fissandomi sui testi che mi colpiscono, e che custodisco ad uno ad uno, e quindi come per la risposta precedente direi che i poeti che amo sono quelli che ho incontrato e mi hanno parlato, non li ho cercati studiando, mi sono venuti incontro. Per esempio non ho letto l’Antologia di Spoon River, ma c’è una sua poesia, regalo di un’amica, che porto con me da anni.
Comunque per rispondere ti direi che il primo che ho amato e che, curiosamente, non ho ancora inserito nella Cameriera, forse per una sorta di rispetto, è Dante. Mi sono più volte ritrovata a pensare come l’Italiano sia nato con lui e poi nessuno lo abbia più usato con una tale vivida ricchezza. In ordine di tempo viene sicuramente Montale, conosciuto in quinta liceo, lui forse è in assoluto uno dei miei preferiti. Quando ho scoperto che Ossi di seppia l’aveva pubblicato da solo perché nessuno voleva pubblicarglielo ho deciso che anche io potevo pubblicare per conto mio il primo libro delle Parole sotto Sale, superando il pregiudizio che nutrivo in merito.
E poi in ordine sparso ti direi Mariangela Gualtieri, dal cui ascolto dal vivo nel 1995 in teatro è nato probabilmente il seme che mi ha portata alla Cameriera di Poesia, e sicuramente Emily Dickinson, ogni volta che la leggo si rinnova lo stupore per la modernità della lingua, l’asciuttezza dello stile, l’intensità nella sintesi, l’Inglese magnifico.
Marcello Sambati: l’ho già nominato a proposito delle registrazioni, ma è stato in un laboratorio teatrale per mettere in scena il suo magnifico Prometheu, nel 1997, che ho scoperto di avere una voce e quei testi li servo ancora nella Cameriera.
Ho un aneddoto interessante che riguarda Petrarca, quando l’ho studiato a scuola non ne ho compreso la grandezza, dopo più di dieci anni dalla fine della scuola l’ho reincontrato in teatro. Dovevamo costruire un recital sulla sua poesia e scegliere i testi, mi lessi il Canzoniere in pochi giorni e rimasi folgorata dalla modernità della sua lingua e dalla bellezza delle immagini.
Aggiungerei solo due nomi: Christian Bobin, autore francese da poco scomparso che scrive in prosa, ma a me sembra poesia e mi fa venire voglia di scrivere quando lo leggo, e Guido Celli, caro amico che mi commuove per l’intensità e la densità della sua parola.

L’autrice:
Claudia Fabris (Padova 1973) si avvicina all’arte a 16 anni con la fotografia. In seguito incontra la danza, la creazione d’abiti e il teatro con Tam Teatromusica (premio Speciale Ubu 2014) con cui collabora per anni come performer, costumista, fotografa e aiuto regia.
Nel 2011 inizia un percorso nella parola con “La Cameriera di Poesia”, che porta ovunque in Italia. Nel 2013 inizia a scrivere le “Parole sotto sale” e ad apparire nelle città come “Nostra Signora dei Palloncini”. Intreccia il proprio percorso con Altofest a Napoli dal 2011, La Luna e i Calanchi ad Aliano (Matera), Verso Sud a Corato (Bari), del quale condivide la direzione artistica dal 2022.
(Claudia Fabris “La Cameriera di Poesia. Piccola ristorazione dello spirito” pp. 230, 15 euro, AnimaMundi edizioni 2024)
(Claudia Fabris “Parole sotto sale. Piccolo vocabolario poetico” pp. 232, 13 euro, AnimaMundi edizioni 2020)
Immagini ———————
Night walker
Undici dipinti
di Lindsey Harald-Wong

Tutta l’acqua che può essere tenuta in una mano
Un testo inedito
di Margherita De Boni

Ispirato alle parole che non hanno una traduzione in altre lingue
Cafunè
Passare le dita tra i capelli della persona amata Saudade ti inghiotte
la nostalgia di quel momento portatoti via di quella persona là vissuta nella realtà o nella tua reale fantasia?
sui ricordi scorrono lacrime sui sogni
Komorebi quando gli aculei del sole pungono le foglie in giochi di riflessi caldi gialli su verdi rossastri
Tsundoku
accumulo di vita mai letta
smania di conquistato sapere disperde il piacere e
Wabi sabi Accetto. Accetto
Che Venere nasce dalla conchiglia dell’imperfezione e dolce ti accolgo, disarmata figlia di natura, morte Age otori
è quando usciamo dal parrucchiere e stiamo peggio di prima (In tedesco)
Zweisamkeit
soli io e te solo io e te
solo il palpito dei nostri soli cuori
che di questa nostra alienazione dal mondo godiamo
Sehnsucht (o toska in russo) malattia di desiderio
il mío spirito un Icaro Odisseo naufragato condanna di inquietudine di chi cerca cerca l’irraggiungibile
Psithirisma (dal greco)
La voce del vento che canta tra le chiome degli alberi Tiam (dal farsi)
È Scintillio d’incontro
con occhi sconosciuti: sbucano fuori sommersi da rughe come boccioli contagiose pupille di mondi neonati ti trapassano
imbambolato senza fiato rimani massa di unici occhi anonimi Hoppípolla (in islandese)
Salti nell’acqua di strada fretta ti specchi coi piedi sui tetti (dall’ inglese) Petrichor
aroma della terra secca che benedice la pioggia (Cinese) Zi zi zhi shou Yu zi xie lao
Mani negli anni cresciute ad incastro in lacci di vene fino alla fine dei tempi Hanyauku (dal rukwangali)
punte di piedi baccanti al respiro di fuoco della sabbia
(In arabo) Tarab
É estasi di musica in galassie sono dove suono
Gurfa
Tutta l’acqua che può essere tenuta in una mano
Merak
sento il senso, completezza nella bellezza ama granelli di giornata, io che con voi appartengo noi
che siamo che possiamo sull’universo
Manabamatè (dal rapanui)
la mancanza di appetito che si prova quando ci si innamora
-e che francamente, per quanto inguaribile innamorata, è una sensazione che non ho mai provato-

L’autrice:
Margherita Federica De Boni è nata a Milano nel 2001. Si è diplomata col massimo dei voti al liceo classico G. Carducci di Milano. Nel 2019 incontra il teatro ed il Poetry slam e frequenta questi mondi tra Milano, Padova e Granada. Si è laureata col massimo dei voti in Psychological Science a Padova.
Nel 2022 frequenta il corso pre professionale con Teatro D’Emergenza a Lugano e nel 2023 il propedeutico presso l’Accademia Nico Pepe.
Ha portato a Udine il primo torneo di Poetry slam, presso il locale BirraStore Nuovo Gambrinus, e sempre ad Udine ha iniziato il progetto “poesie in strada”.
Nel 2024 si è qualificata per la fase nazionale di Poetry Slam 2024, come rappresentate della Lombardia. Attualmente lavora ad un suo spettacolo che unisce teatro, poesia e stand up.
Immagini ———————
Blue baby
Undici dipinti
di Lindsey Harald-Wong

Voce d’autore ———————–
Vevin di viodi prime di capî Dovevamo vedere prima di capire
Matteo Bellotto, “Pôre di nuie”
di Antonello Bifulco

Ci sono paure che non sono generate da un oggetto specifico, né da un imminente pericolo. Il tutto deriva da un sentire primordiale, spesso lo associamo a elementi positivi come la meraviglia, lo stupore.
Italo Calvino diceva che l’uomo porta dentro di sé le sue paure bambine per tutta la vita, e che arrivare a non avere più paura è la meta ultima dell’uomo. Così come fa Matteo Bellotto nel suo esordio poetico tra le pagine e le parole di un inaspettato “Pôre di nuie”, edito da KAPPA VU Edizioni, silloge accompagnata da una magistrale prefazione di Paolo Patui che descrive perfettamente quali i sentieri presi dall’autore per avvicinarsi alla Paura, paura che Matteo Bellotto indaga, scruta, somatizza, che cerca trovandola dentro ogni attimo della nostra vita “Parcè che ducj/ I vin pôre/ Di alc/ E i voressin une man/ Ch’a nus cîr./ Parcè che/ No je vere/ Che i fasìn di bes-sôi” (“Perchè tutti/ abbiamo paura/ di qualcosa/ e vorremmo una mano/ che ci cerca./ Perché/ non è vero/ che facciamo da soli“), a cominciare dalla solitudine che è una delle principali vie che conducono a scrutare dentro la paura.
Poesie senza fronzoli che non ammettono replica, scritte in lingua Friulana e tradotte in Italiano dallo stesso autore, poesie che dei Friulani e del Friuli ne fanno un racconto vero e complicato, lucido e alle volte spietato, i Friulani sono i bicchieri che bevono, abitano una terra che si dimentica da sola, il Friuli poi tace per fare un piacere a quelli che hanno voglia di dire qualcosa e quelli che dicono qualcosa magari lo fanno a Udine una città stanca, dimentica, quella città che non ti aspetta, che tace e sa ascoltare, Udine alle volte è ozio con qualche amico a parlar di campagna senza aver mai visto una pala (“A tabaiâ di cjamps/ Cence vêi mai viodû une forcje”).
La paura prende certo la parola ad ogni pagina ad ogni capitolo, quattro capitoli Blanc, Neri, Tocai e Refosc che introducono il lettore al tema della paura inebriandolo prima un po’; tema focalizzante che si apre e si divide in un ventaglio di concetti che tentano di spazzare retorica e luoghi comuni. Matteo ci racconta che le bugie non hanno repliche al contrario della verità, che la stessa verità sta sotto alle parole, ci ricorda che la nostalgia è un bicchiere non bevuto o che abbiamo dimenticato di bere, ci consiglia, anzi, ci sprona a vivere la vita assaggiandola come si fa con un buon vino e che mai ci capiterà di sputarla senza aver capito niente.
Ci racconta che se solo riuscissimo a tacere saremmo la più bella delle poesie, che ci sono stagioni che vanno vissute per quello che sono saggiandone ogni sfumatura anche in quei campi piantati a bestemmie perché comunque dentro ad ogni sacrificio c’è sempre dentro una poesia.
Silenzio, solitudine, bugie, verità, nostalgia, fuga dalle consuetudini, l’amore declinato col contagocce ma che si affaccia piano e ti rimane attaccato come quella cartolina pinzata ai raggi di una bicicletta solo per credere che ogni rumore possa diventare amore, possa diventare un gioco che porta bellezza, che insegna a giocare con l’ironia con se stessi.
È una poesia quella di Matteo Bellotto, che si pone molte domande, domande che non chiedono risposte immediate ma una semplice riflessione; con le sue parole mette in evidenza quelle verità scomode, quel mostrarsi agli altri senza la paura di essere giudicati, finanche essere capiti. Matteo ti mette davanti ad una porta chiedendoti di avere il coraggio di aprirla, perché alla fine esiste una sola verità quella che si vede soltanto imparando a sognare: “Ma se tu ti piardis/ Tai voi/ Di qualchedun/ Tu âs di deventâ/ La poesie/ Che tu voressis/ Contâ” (“Ma se ti perdi/ negli occhi/ di qualcuno/ devi diventare/ la poesia/ che vorresti/ raccontare”).

Dal libro:
Une volte
Tu puedis contâ
Une bale
Dome une volte
Ma la veretât
Simpri
Ogni volte.
Ancje mai.
Quella volta
Puoi raccontare/ Una bugia/ Soltanto una volta/ Ma la verità/ Sempre/ Ogni volta./ Anche mai.
*
Cence lûs
Son dîs scûrs
Cence lûs
Cuant che di fûr
Al plûf
Ma no ti bagne
E bisugne
Tignî dûr
Prime di fâsi freâ
Un’altre volte
Da primevere.
Ogni stagjon
La vin tai voi
Cuant che i vaìn
Cence fâsi viodi
Di bessôi.
Jeri frut
Ch’i jeri stuf
Di une ploe
Ch’a no bagne
E di un amôr
Ca no ti fâs vaî.
Senza luce
Sono giorni scuri/ Senza luce/ Quando fuori/ Piove/ Ma non ti bagni/ E si deve/ Tener duro/ Prima di farsi fregare/ Un’altra volta/ Dalla primavera./ Ogni stagione/ L’abbiamo negli occhi/ Quando piangiamo/ Senza farci vedere/ Da soli./ Ero bambino/ Ed ero già stufo/ Di una pioggia/ Che non bagna/ E di un amore/ Che non ti fa piangere
*
Ti tocje
Ti tocje
Ogni dì
Di fâ fente
Di ce ch’a no ti covente.
No ti covente
La mutande
Par nascuindi
Il pudôr
No ti covente
Une machine
Par lâ
Atôr
S’i fossin
Ducj crots
Ogni peraule
A sarès une mascare
Par scjampâ
Dibant
Devant da gole di fâ l’amôr.
Si pierdìn
Dome par pôre
Di lâ atôr.
Devi
Devi/ Ogni giorno/ Fare finta/ Di ciò che non ti serve/ Non ti serve/ La mutanda/ Per/ Nascondere/ Il pudore/ Non ti serve/ Una macchina/ Per andare/ In giro/ Se fossimo/ Tutti nudi/ Ogni parola/ Sarebbe una maschera/ Per scappare/ Inutilmente/ Davanti alla voglia di fare l’amore./ Ci perdiamo/ Solo per paura/ Di andare da qualche parte.
*
Nadâl
Nadâl je une bussade
Dongje da bocje
Da none
Cu la muse strente
E cu la voe di lâ
A zuiâ.
Nadâl je une bussade
Da none
Ch’a no je plui
E che tu mastùis
Tal arost
E la polente
Ma dal so amôr
No tu puedis stâ cence.
Nadâl
Al è stâ
Bessôi
A preâ
Di vêi un Dio
Almanco par blestemâ.
Natale
Natale è un bacio/ Vicino alla bocca/ Della nonna/ Con la faccia stretta/ E con la voglia di andare/ A giocare./ Natale è un bacio/ Della nonna/ Che non c’è più/ E che mastichi/ Tra l’arrosto/ E la polenta/ Ma del suo amore/ Non puoi fare a meno/ Natale/ È rimanere/ Da soli/ A pregare/ Di avere un Dio/ Almeno per bestemmiare.
*
Lis mans di tô mari
Lis mans di tô mari
A tabain cence vôs
E ti tocjin di dôs bandis
Prime tal cûl
E dopo tal cûr.
Lis mans di tô mari
son l’unic puest
Sigûr
Par lavâ la bocje das
Bausiis
E podêi vaî cence pôre
Dal scûr.
Lis mans di tô mari
No àn dûl
E ti cjalin
Tasin
Lassant che tu restis
Il frut
Ch’al fâs casin.
Lis mans di tô mari
Son l’amôr
Cence che al scuegni
Mai
Deventâ poesie.
Le mani di tua madre
Le mani di tua madre/ Parlano senza voce/ E ti toccano da due parti/ Prima il culo/ E poi il cuore./ Le mani di tua madre/ Sono l’unico posto/ Sicuro/ Per lavar la bocca dalle/ Bugie/ E poter piangere senza paura/ Del buio./ Le mani di tua madre/ Non hanno pena/ E ti guardano/ Tacciono/ Lasciano che tu resti/ Il bambino/ Che fa rumore./ Le mani di tua madre/ Sono l’amore/ Senza che debba/ Mai/ Diventar poesia.
*
Pôre di nuie
Vin pôre dal scur
Ogni volte
Ch’a si impie une lûs.
Vevin di viodi
Prime di capî
Ma capî nuie.
La pôre ti covente
Par no colâ
E dopo gjoldi
Di stâ cence
Dut
Ce che tu volaressis
No contâ.
Ogni gnot
Ti somee
Come un siump
Ogni gnot
Ti covente par fa fente
Vie pal dì.
E dopo un tai
Par tabaiâsi.
Paura di niente
Abbiamo paura del buio/ Ogni volta/ Che si accende una luce/ Dovevamo vedere/ Prima di capire/ Ma capire niente./ La paura ti serve/ Per non cadere/ E poi godere/ Di rimaner senza/ Tutto/ Quello che vorresti/ Non raccontare/ Ogni notte/ Ti somiglia/ Come un sogno/ Ogni notte/ Ti serve per far finta/ Durante il giorno./ E poi vino/ Per parlarsi.

Intervista a Matteo Bellotto:
Si dice che la Poesia sia una compagna che vive con noi da sempre, che è insita in ognuno di noi, la Poesia è sempre lì dove siamo noi. In “Pôre di nuie” ci fai conoscere la tua poesia, ma la Poesia come entra tra le pagine di Matteo Bellotto?
La poesia, per me, c’è sempre stata e come scrittore credo che il mio compito sia essere un insieme vuoto capace di contenerla e farla emergere. Sono sempre riuscito ad evadere con la poesia, a costruire mondi dentro le parole e per me è una grande scuole di umiltà.
La vedo abitare ogni parte di ciò che vivo e cerco solo di stare attento a coglierla ovunque anche dove sembra non esserci. La poesia è la parte fondante dell’essere quella che lo rende magico e bello da abitare. È il linguaggio più umano possibile.
“Pôre di nuie”, la Paura come tema dominante in queste poesie, il tema della Paura trattato in tutte le sue declinazioni, in quattro capitoli che parlano di vino: Blanc, Neri, Tocai e Refosc, libro scritto in lingua Friulana con traduzione a lato, ci racconti come nasce il libro e perché la Paura?
Il libro nasce su spunti molteplici. Io scrivo poesie da anni ma mai avrei avuto il pensiero di pubblicarle. Un giorno ho preso coraggio ed ho inviato alcune poesie al professor Paolo Patui, che cura la splendida introduzione al libro, che mi ha spinto a pubblicarle.
Da lì la disponibilità successiva di KAPPAVU di farle emergere ed è stata una grande emozione. Al di là di questo ogni mio scritto nasce dall’esigenza, dalla necessità, di dire qualcosa e fare qualcosa per la mia terra e per la mia lingua.
Per me il Friulano, come lingua, è il veicolo della poesia, che parla la lingua con cui parlo con mia madre. Poter porre un piccolo tassello verso questa nostra grande ricchezza per me rientra nel tema dei diritti di tutto il mondo di utilizzare la pro-pria lingua per scrivere, pregare, cantare e comunicare.
Non è dunque una difesa apodittica ma uno strumento dei diritti di tutte le lingue e la poesia è l’arma più potente che abbiamo.

Il Friuli, i Friulani, la terra, questa terra che, sembra dalle tue parole, non riesca a darsi il giusto riconoscimento, la giusta importanza, per timidezza o cosa? Poi dici: “in Friuli non si sogna, si aspetta una tragedia”, ne vogliamo parlare?
In Friuli impari a ridere coprendoti la bocca. Credo sia un retaggio storico, qualcosa che ci portiamo dentro dai tasselli della nostra storia sconosciuta ai più. Essere ai margini e pensare che altrove sia il posto giusto è un pensiero col quale è cresciuta anche la mia generazione. Il livello di talento e capacità di questa terra è straordinario ma credo che sia sempre complesso riconoscere a chi credi di conoscere di essere speciale o di talento. Credo faccia parte di un atteggiamento provinciale molto comune.
Le tragedie sono poi motore potente perché creano connessioni ancestrali, enpatia, qualcosa che questa terra ha sempre sperimentato e che le rimane incollato addosso. La poesia, ancora una volta, ha il potere di svelare la maschera della retorica.
Il Friulano una lingua forte, musicale, essenziale. Come la tua poesia, una poesia senza fronzoli, che punta diretta al nocciolo. Una poesia e una lingua che non fanno paura. Si dice che sia difficile tradurre in italiano ciò che si pensa nella propria lingua, tu che hai riportato in italiano la musicalità del Friulano quali difficoltà hai trovato, sempre che ve ne siano state?
È stato più complesso tradurle che concepirle queste poesie soprattutto per il ritmo che ogni lingua si porta dentro che non è lo stesso per accenti e intenzioni. Ci sono espressioni friulane che hanno una forza intrinseca che una volta tradotte diventano monche.
Ma la traduzione ha sempre questo problema ed è per questo che esistono i traduttori che sono anime di una sensibilità unica e capaci di magie. Io ho cercato di salvare il ritmo e la forza del messaggio. Mi piace che le mie poesie possano essere spietate e gentili.
Tema principale la Paura, ma altri se ne evidenziano in queste pagine: le bugie, la verità, Dio, le bestemmie e il vino, naturalmente. Questi e altri temi che non citiamo sembrano pregnare i tuoi versi, ce ne parli?
Sono tanti i temi che emergono nei miei scritti che si ripetono e ritornano. Sono uno sciame di api attorno al giardino del Friuli e che io tento di scomporre con le poesie visto che spesso si presentano insieme. Siamo abitati da concetti che sono presenti, passati e che raccontano i passi singoli delle nostre anime. L’importante, per me, è avere il coraggio di dirli, di farli emergere e di non nascondersi dentro una retorica bucolica che spesso abita un certo racconto del Friuli profondo. La poesia non può permettersi la retorica.
Ironia sottile in tutti i capitoli, ho particolarmente apprezzato “Udine è ozio al bar a parlare di campagna senza aver mai visto una pala”, quanto è importante l’ironia nella vita, nella poesia?
L’ironia intesa come alleggerimento dell’essere è molto importante e ci dovrebbe insegnare a non prenderci troppo sul serio. Anche questo è un tema in Friuli.
Ci dimentichiamo di ridere di noi, delle nostre macchiette, delle nostre debolezze e delle nostre tenerezze. Eppure io ho vissuto e vivo situazioni di sarcasmo e ironia molto spinte e che mi fanno molto sorridere soprattutto con le persone che conosco con le quali ci si prende in giro anche pesantemente per imparare ad accettarci con ironia e rispetto. L’ironia è una forma di stima per la realtà che si accetta di vivere.
È una poesia che si pone molte domande, che mette in evidenza molte verità, soprattutto quelle che non vogliamo sentire, una poesia delicata che sa offrirti un buon “taj” per addolcire la pillola amara. Quale vino consiglieresti da abbinare alla lettura di questo tuo libro?
Difficile consigliarlo ma credo che il vino più poetico che abbiamo in Regione sia il Friulano. È un vino che è capace di parlare tutti gli accenti diversi di ogni paese e di ogni parte della nostra terra, sempre generoso in campagna, difficile da comprendere in vendemmia, costante nel calice ed emozionante ad ogni stagione. Con un calice di Friulano o Tocai, per chi ancora lo chiama così, è impossibile non sentire dentro la poesia della terra che sta vibrando.

L’autore:
Matteo Bellotto è nato a Gemona del Friuli e vive a Udine. Ha studiato filosofia e lavorato per molti anni in bar e osterie in Italia e all’estero, raccogliendo continuamente storie e testimonianze che non ha voluto fossero perdute.
Da anni studia e lavora nel mondo del vino, a contatto con produttori e contadini, alla ricerca dell’identità perduta del Friuli contemporaneo.
Nella sua opera c’è il tentativo di recuperare il linguaggio contemporaneo attraverso il vino e il silenzio.
I suoi racconti sono stati pubblicati in raccolte come “Locanda Tagliamento” (Bottega Errante), e “Friulani per sempre” (Edizioni della sera). “Storie di vino e di Friuli Venezia Giulia” è la sua prima pubblicazione organica ed originale per Biblioteca dell’Immagine, seguita dal romanzo “Di Terra e di Vino – Romanzo Friulano”.
(Matteo Bellotto “Pôre di nuie” pp. 128, 13 euro, KAPPA VU Edizioni 2024)
Immagini ———————
Morning sailing
Undici dipinti
di Lindsey Harald-Wong

Tempo presente ———————–
Andare dall’altra parte
Massimiliano Stefani, “Victoria non esiste – all’improvviso un’esplosione a Trieste”
di Anna Piccioni

Il sottotitolo all’improvviso un’esplosione a Trieste è l’inizio del romanzo: è il 1981 a Trieste, con i ragazzini delle medie che salgono sull’autobus per tornare casa, anche Victoria è su quell’autobus che sfiorerà la tragedia, visto che passa per la via Mazzini nel momento in cui scoppia un appartamento per una fuga di gas e Paolo, che ha assistito da lontano è preso dall’angoscia e dalla, paura per la sorte dei suoi compagni, ma di Victoria principalmente.
Quell’esplosione può anche essere interpretata come una forte presa di coscienza di Paolo dei sentimenti che lo legano a Victoria. Perché Paolo, il protagonista, un ragazzino della Trieste degli anni settanta, e poi ottanta e novanta, in prima persona racconta la sua vita attraverso gli anni, ma non sempre in modo cronologico; rimbalza dal periodo della scuola elementare, alla scuola media, alle superiori, all’università. C’è un continuo rincorrersi di fatti e di sentimenti (l’amore per la nonna, la perdita della madre in un incidente, il riflesso del suo volto sul serbatoio della moto del padre), un prima e un dopo che si intrecciano. La figura dominante però è Victoria, una bambina coetanea di Paolo, un’amica preziosa, malattia e medicina, come la definisce lui stesso.
Questo passare dall’infanzia all’adolescenza in alcuni momenti si dissolve: Victoria esiste o non esiste? e Paolo? Esiste o non esiste? C’è qualcosa di sospeso, quasi di irreale.
Potrebbe essere un sogno. La stessa atmosfera a volte è impalpabile, fluttuante, surreale. Oppure Victoria è l’amica immaginaria, che spesso i bambini solitari, e presi di mira dai bulli come succede a Paolo, s’inventano?
Nel proseguire nella lettura si è meravigliati da alcuni eventi che superano la realtà: certe visioni e situazioni in cui si trova Paolo potrebbero essere un sogno o il vissuto in un’altra dimensione.
Un romanzo sui generis: una storia d’amore e d’amicizia e di solitudine; una storia narrata sullo sfondo di luoghi ben definiti: il Parco della Rimembranza di San Giusto, il Casermone grigio di Melara, i giardinetti dell’Osservatorio Astronomico, il mare di Trieste.
L’epilogo inaspettato lascia il lettore sorpreso, attonito, ma diventa la chiave di lettura e centra il tema fondamentale: quale strumento abbiano noi per distinguere il sogno dalla realtà, la vita dalla morte? Poter distinguere un vissuto reale dal vissuto in un’altra dimensione? Le sensazioni, i sentimenti sono forti e coinvolgenti, in qualsiasi dimensione li viviamo.
La morte poi, come dice la nonna di Paolo, è semplicemente andare dall’altra parte, altrove. Proprio come il paesaggio che scorre davanti al finestrino di un treno e cambia continuamente, ma non sparisce, sparisce solo dalla nostra vista: così le persone che non ci sono più non sono scomparse, ma semplicemente sono … dietro l’angolo.
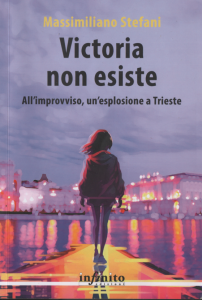
Dal libro:
“Amavo nonna. Era una vecchina nata nei primi anni del secolo. Piuttosto secca, minuta; ma il suo viso era dolce e rassicurante. Mi raccontava tante storie che sapevano d’antico e mi rivelavano un mondo che mi affascinava proprio perché non esisteva più. Mia madre era la sua unica figlia e l’aveva avuta tardi rispetto agli standard della sua epoca, quando le ragazze diventavano madri intorno ai vent’anni o persino prima. Il marito, invece, lo aveva perso presto e da allora aveva allevato mia mamma da sola, tra mille difficoltà. Finché mia madre si era sposata e lei era tornata a vivere in solitudine. La sua era una vita povera ma dignitosa. La amavo, era mia nonna. A casa sua, dopo aver pranzato, lei si coricava nel letto grande. Io rimanevo da solo in cucina per circa un’ora. Giocavo con l’unico giocattolo disponibile che mia nonna, prima di andare a riposare, tirava fuori spostando il lembo di una tendina bianca che separava la parte più bassa della camera. Era una casa in miniatura fatta interamente di latta. Allegra e colorata, era grande abbastanza da occupare una buona parte del tavolo della cucina, dove mia nonna veniva a posarla per me. Quella casa di latta era appartenuta a mia madre bambina e quando ci giocavo provavo sempre l’emozione di immedesimarmi nella lei di tanti anni prima. Più di tutto, mi piaceva scoperchiare il tetto, che era smontabile, e prelevare i piccoli mobili di plastica dalle stanze, divertendomi poi a rimetterli dentro scombinandone l’ordine: posizionavo il frigorifero e la lavatrice nel salotto; la televisione (era il modellino di una moderna casa americana dei primi anni Cinquanta) nel bagno; la vasca per lavarsi con il soffione della doccia in cucina; il tavolo della sala da pranzo nella camera da letto e così via”.

Intervista a Massimiliano Stefani:
Questo è il tuo terzo romanzo, dopo “Bersaglio Umano” e “Trieste, 1974”, con un tema e un intreccio totalmente diverso, oppure c’è qualcosa che comunque li lega assieme?
Questo mio terzo romanzo rappresenta al tempo stesso un punto di rottura e di continuità con i precedenti. Nel segno della rottura c’è il notevole spazio che ho voluto dare alla dimensione fantastica e surreale. La continuità, invece, riguarda il mio interesse per il mondo giovanile, per i temi più universali quali l’amore, la solitudine, la difficoltà nelle relazioni umane, la vita e la morte.
Rispetto all’ultimo romanzo, poi, c’è senz’altro come elemento comune la meravigliosa Trieste, città in cui sono nato, ho vissuto e vivo tutt’ora.
Cosa ti ha spinto a scrivere questo romanzo; come si è sviluppato l’intreccio?
Dopo aver scritto un romanzo a sfondo storico, con riferimenti di cronaca ben precisi e documentati come “Trieste, 1974”, ho voluto liberare la mia fantasia. Questo romanzo, in un certo senso, “si è sviluppato da solo” e scriverlo è stato come una specie di gioco. In tutto il libro, infatti, si gioca sulla distinzione fra realtà e immaginazione, che ho voluto rappresentare come dimensioni separate da una linea molto sottile.
Quanto sono importanti i luoghi descritti in “Victoria non esiste”? E quanto ti sono familiari?
Sono fondamentali. Alcuni, come San Giusto, Parco della Rimembranza, Scala dei Giganti, oltre ad essere, secondo me, molto “letterari”, sono anche e soprattutto i luoghi della mia infanzia, visto che abitavo da quelle parti. Inoltre, ho voluto dare spazio alle periferie, ambientando una parte del romanzo all’interno del Quadrilatero di Melara, edificio di edilizia popolare realizzato in stile “brutalista”, ai margini della città. Spero di essere riuscito a mettere in luce l’aspetto positivo di quel quartiere di Trieste, considerato sempre, a torto, come una specie di “Bronx”, ma in verità vivo e vitale, ricco di fascino.
C’è qualcosa di autobiografico in Victoria…
Direi di sì, in quest’ultimo romanzo molto più che nei due precedenti ci sono aspetti autobiografici. Il protagonista Paolo mi assomiglia parecchio, sia per alcuni episodi del suo vissuto personale, sia per il suo modo di porsi nei confronti della vita: molto riflessivo e meditativo; tendenzialmente un solitario, ma che ha bisogno di essere rassicurato e di misurarsi con gli altri.
Come hai scoperto di essere uno scrittore che ha molte cose da dire?
A dire il vero lo sto scoprendo ora, da qualche anno, ossia da quando ho trovato delle case editrici che, per quanto piccole, hanno creduto nelle mie possibilità (senza chiedermi soldi per pubblicare) e i riscontri sono stati positivi.
La scrittura ha sempre accompagnato la mia vita, ma l’idea di provare a pubblicare quello che scrivevo mi è venuta molto tardi. Prima nemmeno ci pensavo e scrivevo soltanto per me stesso. Come scrittore, a ogni modo, mi sento ancora in crescita e spero che il meglio debba ancora arrivare.

L’autore:
Massimiliano Stefani è nato a Trieste nel 1969. Laureato in giurisprudenza, abilitato alla professione di avvocato. Lavora nell’ufficio legale di un ente pubblico e si occupa di diritto del lavoro.
Forte lettore e appassionato di scrittura. Ha pubblicato i romanzi “Il bersaglio umano. Storie di bullismo” (ed. Eugraphia, 2019); “Trieste, 1974” (Infinito edizioni, 2022), prossimamente tradotto in lingua slovena; “Victoria non esiste. All’improvviso, un’esplosione a Trieste” (Infinito edizioni, 2024).
(Massimiliano Stefani “Victoria non esiste – all’improvviso un’esplosione a Trieste” pp. 228, 17 euro, Infinito edizioni)
Immagini ———————
River trees
Undici dipinti
di Lindsey Harald-Wong

Intervista a Lindsey Harald-Wong:
A cura di Giovanni Fierro e Sandro Pecchiari

Nel suo dipingere il colore è molto importante, è una presenza che si impone, un qualcosa che nel suo dire esce dalla tela. Questa sua presenza così fisica, in che modo contraddistingue il suo dipingere?
È difficile per me sapere quale impatto potrà avere il mio uso del colore nella mia pittura su chiunque lo incontri. Perché esiste su più livelli, è la voce con cui parlo, è una forza vibrazionale attivata dagli altri colori che incontra sulla tela o sulla carta, e che anche, nella totalità dell’opera finita, può ispirare le emozioni o l’immaginazione dello spettatore.
Ma, come punto di introduzione, vivo in isolamento nel sud-est asiatico da venticinque anni ormai, in Malesia, dove c’è pochissima pittura, soprattutto pittura astratta. Quando sono arrivata mi sono davvero chiesta “che cos’è l’arte?“, arrivando da una completa immersione, durata dodici anni, nel mondo dell’arte professionale di New York City. Ho pensato che l’arte è solo luce, senza categorie o periodi definiti da artisti non professionisti.
Quindi ho ricominciato da capo. Mi sono posta come limite l’uso del carboncino e della carta, con l’idea di cercare la mia voce, in un oceano di veri e propri giganti creativi della pittura astratta. Ho lavorato partendo dalla natura, disegnando piante di orchidee, non raffigurando la pianta in sé ma la geometria della sua forma e di ciò che forma non ha.
Ho lavorato senza usare il colore per diciassette anni, finché ho dimenticato completamente la teoria del colore e qualsiasi regola che ho potuto aver imparato o insegnato.
Durante i giorni bui del lockdown a causa del covid ho scoperto una custodia piena di pastelli a gesso di alta qualità, di produzione tedesca, nel negozio d’arte con cui lavoro qui. Erano lì da molto tempo, perché nessuno usa più questo materiale, e così ho cominciato a disegnare con il colore, invece di usare il carboncino.
Questo mi ha permesso di rispondere in modo intuitivo al colore, mentre parlavo attraverso il segno.
Sto continuando ad aumentare la complessità del mio esprimermi, ora, e sto cominciando a sostituire l’uso dei pastelli a gesso con la pittura ad olio.
Quello che ho imparato è di non immischiarmi con la materia; ci vuole tempo per apprendere i limiti della relazione tra la materia e la carta o la tela. La luce è lì, la terra.
Cosa significa per lei l’astratto? Cosa le ha fatto scegliere questa espressione artistica? Quali le possibilità che ha dato al suo esprimersi?
Nella vita tutto ora è in realtà un insieme astratto di relazioni, il visibile e l’invisibile, il conosciuto e l’ignoto, tutto ciò che riguarda la mente è sorprendentemente astratto.
Le culture orientali dell’Asia e le culture tribali animistiche abbracciano i principi primordiali di yin e yang, la luce intrecciata del tantra e tutto questo hanno influenzato profondamente il mio lavoro da quando mi sono trasferita qui.
Il mio studio è in un santuario cinese nel quartiere Tao di Georgetown a Penang, ed era formalmente conosciuto come il regno infernale quando sono venuto a lavorare qui.
Assomigliava molto al Lower East Side di Manhattan da cui provenivo, solo che qui vivevano principalmente i cinesi. Ogni mattina il portare a spasso il mio cane, attraverso questo vecchio mondo di edifici distrutti e infestati, è come camminare attraverso una galleria di calligrafia cinese ed islamica, e di enigmatici incantesimi taoisti, ognuno un dipinto astratto in bianco e nero, unico e avvincente. Ce n’è uno su ogni porta di casa, come protezione dai fantasmi, ed arbitro di prosperità e di buona salute.
Così ho iniziato una lunga serie di disegni in bianco e nero, basati sulla creazione di linee calligrafiche come una sorta di racconto auto-rivelatore. Ho spesso lavorato con uccelli e fiori in allestimenti di natura morta, lasciando che gli oggetti diventassero una struttura o un’impalcatura, e poi ho permesso che il ritmo naturale del movimento spostasse il lavoro in un automatismo del disegno, e alla fine ha cominciato ad emergere un surrealismo astratto.
Così, rimuoverei l’oggetto per tornarci poi su, fino a quando non avrò che una chiara visione del rapporto emotivo in movimento, tra me e il processo del disegnare.
Specificatamente, per rispondere alla tua domanda, l’astrazione offre infinite possibilità per creare ambienti e segni in cui l’immaginazione può trovare dimora, e può mettere radici nella creazione.


Tutte le immagini, che qui proponiamo, mi sembra che escano dal silenzio di una riflessione, di una emozione, di un sentire personale. È così?
Il disegno “Trees” è nato da una percezione, da uno studio della luce e della forma. La delineazione degli alberi costituisce l’intelaiatura della struttura di questo disegno.
Lavorare sulla natura è calmare il movimento pensante e oggettivante della mente. La mano si muove con i ritmi e i bordi degli alberi, mentre l’occhio dissolve i confini tra cielo e foglia, ramo e nuvola.
Il disegno si è spostato, da questa struttura ad una risposta lirica e intuitiva alla luce, e alla totalità dell’esperienza dell’ambiente.
Sia che l’immagine, disegnata o dipinta, rappresenti la descrizione reale di questo paesaggio, o che sia una propria interpretazione, l’attività è il muoversi in un linguaggio astratto, lavorando nella terza dimensione su di una superficie bidimensionale.
Percezione, riflessione ed emozione combinate assieme, potrebbero effettivamente fondersi in una dimensione di frequenza più elevata, anche se non so come ciò possa essere misurato.
Un disegno che deriva dall’esperienza interiore e non dalla percezione, è il dipinto “Sword master”, registrazione del ricordo di un’esperienza seria che cambia la vita.
Il colore rosso era una scelta ovvia per evocare la realtà fisica e la risonanza emotiva di ciò che vedevo nella mia mente. Realizzare questo disegno ha voluto dire proiettare un’immagine dei miei sentimenti, il dare loro un posto, documentare un momento importante e inquietante della mia vita. Non una riflessione ma piuttosto una reazione.
Sempre di più tutto ciò mi porta a lavorarci, per poi trovare un luogo tranquillo e sicuro dove esprimere una sorta di poesia visiva. È una storia, rappresentata.
Alcune tele (penso a “Heaven and earth”, a “Blue baby”..) mi danno l’idea di rappresentare un qualcosa di irrisolto, che deve ancora trovare una soluzione. Stanno cercando una risposta a domande che mi sembrano importanti. Mi sbaglio? E in caso, che domande sono?
“Blue baby” e “Heaven and heart” sono simili ai due quadri della domanda precedente, in cui uno riguarda il paesaggio e l’altro vive in uno spazio interno, come un grembo materno. Caos e ordine, nascita, morte e distruzione esistono in perpetrata eternità, e qui in relazione alla cosmologia taoista cinese.
Il simbolo yin e yang del taiji, il “Supreme ultimate” è magicamente apparso e organizzato in queste immagini.
Nessuna delle due immagini era stata pensata prima, entrambe sono un disegno automatico (automatismo), in quanto mi sono avvicinata loro completamente senza un’idea, ma probabilmente con solo un’emozione, o una reazione intuitiva a un disegno precedente.
“Heaven and earth” suggerisce un grande paesaggio, con una tempesta potente e imminente che scende dal cielo per avvolgere la terra. La soluzione a questa narrazione è sconosciuta, ma potrebbe portare l’immaginazione alla possibilità di una distruzione, di una devastazione, di morte, perdita, rigenerazione, e a tutte le inevitabili conseguenze della violenza meteorologica o di quella causata dalla guerra.
Il rapporto gestalt che c’è tra il pastello di gesso e la carta di cotone ha raggiunto nel disegno un equilibrio di opposizione e accordo, per liberare proprio questa questione.
“Blue Baby è stato un processo più complesso e stratificato, di spinta e trazione, addizione e riduzione, per risolversi in un equilibrio di due forme positive fuse in una forma embrionale. Non nata sulla carta, la sua storia potrebbe iniziare nella mente e nell’immaginazione dello spettatore.

Lo sguardo di chi si pone di fronte a queste sue immagini si immerge in una sospensione temporale, che diventa l’occasione per indagare ed esplorare sempre qualcosa che è nel vivo di un accadere. È il raccontare di un qui ed ora che diventa esperienza diretta?
Penso che “qui e ora” sia una definizione molto interessante; e come la presenza dell’artista, lasciata nella forma e nell’energia dell’opera, che parla in qualche modo alla persona che guarda il dipinto o il disegno.
Ci sono i due momenti in cui l’opera viene creata nello studio, nella mente dell’artista e nel suo gesto. L’esperienza e la conoscenza dell’artista si intrecciano così in un’opera d’arte finita, nel luogo in cui viene vista e contemplata da un’altra persona, completamente diversa, complessa e dal proprio vissuta mentale.
Qualcosa nel più primordiale e astratto stato di relazioni, che hanno luogo e devono agire nel subconscio collettivo, affinché possa avvenire questo trasferimento di esperienza e connessione emotiva.
La realtà della morte e la creazione della vita umana è radicata nella semplice iconografia grafica di luce ed oscurità, espansione e contrazione, e nella magica dimensione fisica dell’interazione dei colori.
Quando stavo lavorando al dipinto “Europa”, con in mente la grande opera di Tiziano “Il ratto di Europa”, solo alla fine solo alla fine del mio dipingere è apparsa una donna nella sua sensualità.
Molti altri disegni diversi erano apparsi e scomparsi mentre continuavo a lavorarci. Più tempo passava, più io diventavo una sorta di strumento per trasmettere l’immagine e la forma, ero un insieme complesso e risolto di informazioni materiali, tecniche e spirituali. Come l’uccisore di un drago, mi interessa attivare una poesia visiva e dinamica, prima che diventi poi gravata da tutto il lavoro e si perda. E in questo modo c’è un’esperienza che trasporta lo spettatore a vivere il dipinto.
Da cosa dipende la scelta delle tecniche usate per creare questi quadri?
Lo studio dove lavoro assume una sua propria vita, e anche il dipinto lì appeso, su cui sto lavorando, ha una presenza molto reale e talvolta imponente. Per mantenere vivo il flusso della creatività lavoro in sequenze diverse, che si sono evolute intuitivamente e attraverso il processo lavorativo.
Quindi, spesso, quando inizio a lavorare, parto dal lavoro precedente, e spesso mi capita di fare un qualcosa che ne è quasi l’opposto. Quindi se il lavoro di ieri è un grande dipinto a olio, mi può succedere di pensare che non funzioni più, così da iniziare con un piccolo disegno di linee, a grafite.
Oppure, se provo una forte emozione, posso lavorare su un vecchio disegno, cancellandolo e poi iniziandone uno nuovo, lasciando che i due momenti si fondino assieme.
Mi metto sempre alla prova, anche solo per ottenere un grande o un piccolo fallimento, per iniziare, e il disegno è un modo diretto di comunicare e liberare energia.
Dopodiché tornerò a lavori più grandi, dipinti o disegni, e continuerò a lavorare con la pittura ad olio e forse dedicherò molte ore al mio lavoro, finché non sarà lui a dirmi di fermarmi, o perché c’è bisogno che si asciughi.
La tecnica che sto usando ora è una risposta intuitiva a ciò che c’è, lavorando con un pennello o con la mia mano, sul muro o sul pavimento, un’immagine che sia aperta, complessa e vivente, o pura poesia.
C’è molto da affrontare nella creazione di una relazione tra la struttura spaziale e la superficie, trovare l’equilibrio tra caos e forma concreta, e tutte le tecniche entrano in gioco per consentire l’innovazione e l’autentica esperienza.

L’artista:
Lindsey Harald-Wong è nata a Denver, Colorado, negli Stati Uniti.
Ora vive in Malesia dove continua il suo lavoro artistico. Si è formata alla facoltà del Pratt Institute e alla Parsons School of Design a New York, dove ha insegnato disegno.
Ha ottenuto un Master of Fine Arts in pittura e disegno al Brooklyn College, a New York.
I suoi primi lavori hanno avuto a che fare con l’immaginario della natura morta 8come i fiori, specialmente le orchidee). Il suo lavoro all’inizio degli anni duemila si è spostato verso l’incontro con superfici come carta e tela, grazie al dipinto “Small Cosmos” del 2005, esposto poi in una mostra collettiva alla galleria Reising and Taylor Contemporary di Los Angeles, nel 2024.
Abitando in Malesia, Lindsey Harald-Wong lavora in un relativo isolamento dai contesti economici e sociali dell’arte contemporanea.
Ma proprio in questo isolamento ha coltivato un metodo di lavoro che si sviluppa in un profondo senso del tempo, che si evolve unicamente attraverso il suo linguaggio artistico.
Attualmente sta lavorando ad una mostra personale che sarà ospitata alla galleria Reising and Taylor Contemporary di Los Angeles.
www.lindseyharaldwong.comhttp://www.lindseyharaldwong.com
Immagini ———————
Sword master
Undici dipinti
di Lindsey Harald-Wong

Gli undici dipinti di di Lindsey Harald-Wong qui proposti:
Jungle night walker
pittura ad olio su tela 2024 162×172 cm 2024
Sword master
pittura cinese 152×152 cm 2024
Heaven and earth
pastelli a gesso su carta 56×76 cm 2024
Mars harbour
pastelli a gesso su carta 76×56 cm 2024
Night walker
pittura ad olio su tela 162×172 cm 2024
Blue baby
dipinto su carta 56×76 cm 2024
Trees
pastelli a gesso su carta 30×46 cm 2024
River trees
pastelli a gesso su carta 56×76 cm 2024
Europa
pastelli a gesso su carta 38×44 cm 2024
Untitled
pastelli a gesso e a olio su carta 30×46 cm 2024
Morning sailing
grafite e pastelli a gesso su carta 56×76 cm 2024
Immagini ———————
Europa
Undici dipinti
di Lindsey Harald-Wong


