
Ci ritroviamo con il numero di maggio di “Fare Voci”.
Anche questo mese il piacevole intrigo è quello di inventare e riconoscere nuove vie alla scoperta di autori che con la propria espressione artistica possono essere un punto di riferimento per l’umano vivere.
Ad iniziare dal poeta sloveno Aleš Šteger e la sua antologia “Sopra il cielo sotto la terra”, ben curata e tradotta da Michele Obit, che ci racconta anche la poetica di questo importante autore.
E c’è anche il significativo ritorno di una firma come Pasquale Di Palmo e le sue nuove poesie contenute in “Vertebrae”.
La voce d’autore vibra anche con Saragei Antonini e il suo prezioso libro in dialetto “A virìna”, e con l’intensità che Adalgisa Zanotto esprime nelle pagine di “Ho da dirti un segreto”.
Il ti racconto è nel proporre e narrare la lettura di “La manutenzione dei sensi” di Franco Faggiani e di “Passaggi segreti” di Federico Pace.
Il da qui è il ritornare sulla figura di Piera Oppezzo, per riscoprirla con il suo “Esercizi d’addio, Poesie inedite 1952-1965”.
Il tempo presente è nei nove haiku inediti di Valentina Mariani e nel ritorno di Massimiliano Bottazzo, con il suo “Scalzo per errore”.
Le immagini sono le otto fotografie di Alessia Ambrosini.
Buona lettura.
Giovanni Fierro
(la nostra mail è: farevoci@gmail.com)
Immagini ——————————-
Ballo da sola
Otto fotografie
di Alessia Ambrosini

Voce d’autore ——————————-
Zato sem mu hvaležen, Per questo gli sono grato
Aleš Šteger, “Sopra il cielo sotto la terra”
di Giovanni Fierro

Aleš Šteger è figura di riferimento della poesia slovena, e ormai anche nome riconosciuto nel panorama europeo.
A sottolineare la sua caratura ed importanza, arriva ora l’antologia “Sopra il cielo sotto la terra”, che contiene una scelta di sue poesie, a partire dal volume “Kašmir” del 1997, fino a “Nad nebo pod zemljo” raccolta del 2015, assieme anche ad alcune sue nuove poesie inedite.
L’antologia è a cura di Michele Obit, anche autore di tutte le traduzioni in italiano che vi sono contenute.
È quindi l’occasione per addentrarsi nel mondo poetico di Šteger, scrittore cosmopolita, critico, traduttore, instancabile viaggiatore e anche ideatore e organizzatore di importanti festival ed eventi letterari.
La particolarità della sua scrittura emerge subito, ed è un tratto continuo che caratterizza ogni suo libro, pur nella variazione di sintonia ed intonazione, di sguardo e passo narrativo, che definisce al meglio ogni sua pubblicazione.
Emerge in lui la volontà – quasi una sfida, una ragione d’essere, una appartenenza – di vedere ciò che solitamente si preclude alla vista, ciò che si nasconde, ma di cui si avverte l’esistenza, lo stare al mondo: “Parlare non significa parlare di cose non finite? E non dovrei prima chiedere cosa sia mai la fine, se è tutto uno spostare la polvere?”.
In questo suo costruire domande, trova anche alcune risposte, “Noi invece viviamo nel caos del sole. Andarsene significa girare una pagina non letta”. E ci dice che è anche facile smarrirsi; ed è proprio lì, in quell’attimo, che si ha la possibilità di inventare una nuova geografia, emotiva e di pensiero, “E ora: soffia. Sì, soffia. Lentamente, attendi che il fiato/ porti via tutto quanto si sia raccolto di te”.
Sì, il suo scrivere si fa seme, dentro ogni suo libro, dentro ogni possibile terriccio di attenzione e pulsione, perché il suo è un continuo rivoltare l’ordine consueto delle cose, per creare e riconoscere nuovi punti di vista, occasioni ed esperienze che lo portano a scrivere dentro una poesia che si nutre di sorpresa e nuovi codici espressivi. Perché è tutto da ridefinire: “Come posso intendere il tempo nel quale anche il più forte finisce per cedere?”. Ecco un’altra domanda…
Aleš Šteger mette in evidenza, porta in superficie l’unico a cui appartenere, la ‘verità’ da mostrare e osservare, quasi nel desiderio di riconoscere un ‘creatore’ – il poeta stesso? – a cui ricondurre tutto, a cui affidare ogni ‘perché’.
Il suo fare poesia è quasi visionario, ma ha la saggezza di fermarsi sempre un attimo prima, rimanendo sempre dentro alle cose, al loro peso e alle loro ombre, nella luce che sanno creare e nell’orizzonte di cui sono fatte. Alla loro semplice realtà.
Ed ha la chiarezza di spiegare bene le due anime di cui è composto un poeta, la sua duplice veste d’autore: “Quando sono lui, scrivo. Quando sono io, guardo ciò che ho scritto. Per natura sono un essere eretico. Nei miei calzini c’è il caos”.
Aleš Šteger è sempre in viaggio, nella sua natia Slovenia come negli stati che fanno l’Europa, sulla pagina scritta e sulla pagina da scrivere, e tutto questo sempre “Perché amo il ritorno, perché sto/ Sopra il cielo, sotto la terra, per sempre”.

Dal libro:
Ritorno a casa
Sulla gradinata in acciaio,
Attorno ai vasi con dei fiori appassiti,
Fiorisce la ruggine.
Le valigie colme di biancheria sporca
E di vecchie domande mi rendono traballante.
Come se, di soglia in soglia, muovessi l’inquietudine.
Nei seguenti quattrocento chilometri abbiamo taciuto.
Nessuno di noi due sa se avremo la forza di tacere
Anche il silenzio dell’arrivo.
Lo sguardo nello specchio del bagno,
Dal quale tanto lontano sono fuggito,
Neppure per un attimo mi ha perso di vista.
*
Sasso
Nessuno sente quanto il sasso contiene in sé.
Minuscolo, è solo suo, come il dolore,
Imprigionato tra il cuoio della scarpa e la pianta del piede.
Quando ti scalzi, le foglie volteggiano nei nudi viali.
Quanto è stato non lo sarà mai più;
E mucchi di altri segni nella decomposizione.
L’odore degli ambulanti vicini. Muto prosegui.
Ciò che serbi dentro di te, nessuno lo sente.
L’unico abitante del tuo sasso sei tu.
L’hai appena gettato.
*
Moj mali bog
Ob rojstvu
Se je v mene skril
En mali bog.
Jaz se spreminjam,
On pa je ves čas
Le samosvoj.
Ne prekrivava se scela.
Pogosto ga kličem,
Pa ga ni.
Včasih seže iz mene,
Boža bogove drugih,
Ne da to opazim.
Ni slab ta moj mali bog,
Četudi nerazumljen in sam.
Smili se mi.
Ne bi bil rad v njegovi koži.
On pa je v moji,
Zato sem mu hvaležen.
Il mio piccolo dio
Alla nascita/ In me si è nascosto/ Un piccolo dio.// Io mi trasformo,/ Lui invece continua/ Ad essere autonomo.// Non corrispondiamo del tutto./ Spesso lo chiamo,/ E lui non c’è.// A volte si estende da me,/ Carezza gli dei degli altri/ Senza che me ne accorga.// Non è cattivo questo mio piccolo dio,/ Pur se incompreso e solo./ Mi fa compassione.// Non vorrei essere nella sua pelle./ Lui però è nella mia,/ Per questo gli sono grato.
*
Smehljanje pesnikov
Čemu se smehljajo naši pesniki?
Ničesar smešnega ni v našem plemenu.
Mnogi ležijo umorjeni v grapah.
Naše ženske in otroci so lačni in bosi.
Med nami kosijo neznane bolezni.
Nove vasi še niso zgrajene in kmalu bo sneg.
Kljub vsemu smehljanje ne splahni z lic naših pesnikov.
Kot da jih spričo gorja obhaja nerazumna, skrivnostna radost.
Ko jih vprašamo, kaj je smešnega, se molče namuznejo,
In nič drugače, ko jim ukažemo, da v temačnih časih razvedrijo še nas.
Razlog za njihovo smehljanje varujejo izključno za lastno zabavo.
Vse manj jim zaupamo, manj verjamemo njihovim redkim besedam.
Zares skrivnostni so nasmeški naših pesnikov v teh ubožnih časih.
Se jim je pomračil um? Se posmehujejo naši skupni nesreči?
Njihovo smehljanje včasih zareže bolj okrutno od orožja naših sovražnikov.
A motijo se, če mislijo, da nas bodo ukanili.
Naše pesnike ubijemo šele tedaj, ko iz njih iztisnemo njihovo skrivnost.
Pri življenju pustimo le tiste najbolj blebetave, resnobnega lica in nam podobne.
Il sorriso dei poeti
Di cosa sorridono i nostri poeti?/ Nulla c’è di divertente nella nostra tribù.// Molti giacciono uccisi nelle forre./ Le nostre donne e i bambini sono affamati e scalzi.// Malattie ignote ci falciano./ I nuovi villaggi non sono ancora costruiti e tra poco nevicherà.// Nonostante tutto, il sorriso non scompare dai volti dei nostri poeti./ Come se di fronte ai tormenti aleggiasse un’incomprensibile, misteriosa allegria.// Quando chiediamo loro cosa ci sia da sorridere, ridacchiano silenti,/ E non cambiano quando ordiniamo loro che in tempi bui divertino anche noi.// La ragione del loro sorridere la custodiscono unicamente per proprio gaudio./ Quanto meno ci fidiamo di loro, tanto meno crediamo alle loro poche parole.// Davvero misteriosi sono i sorrisi dei nostri poeti in questi miseri tempi./ Si è offuscata loro la ragione? Si beffano delle nostre disgrazie comuni?// Il loro sorriso a volte taglia più ferocemente delle armi dei nostri nemici./ Ma si sbagliano, se pensano che ci raggireranno.// I nostri poeti li uccidiamo solo dopo aver fatto fuoriuscire il loro segreto./ Lasciamo vivere solo quelli più chiacchieroni, dal volto serio e simili a noi.

Intervista a Michele Obit:
(Curatore e traduttore del volume “Sopra il cielo sotto la terra” di Aleš Šteger)
Quale pensi sia il tratto che contraddistingue lo scrivere di Aleš Šteger?
Se posso usare un’immagine, direi che la scrittura di Šteger è una sorta di magma alla ricerca della sua forma. In questa ricerca si innescano vari aspetti della sua poetica, dall’estetica alla metafisica, dall’intimità all’idea del movimento, del viaggio. In ogni caso è spesso capace di mettere il lettore in una posizione scomoda, di ripensamento, di dubbio, cosa che per me è una qualità.
Nel tempo, libro dopo libro, che percorso d’autore ha costruito?
La raccolta cerca di dare una senso a questo percorso, che ritengo sia poetico ma anche personale, non dimentichiamo che Šteger è una sorta di globtrotter della poesia, invitato ai più grandi eventi letterari nel mondo, ed egli stesso un organizzatore di festival.
E la scrittura risente, nella forma e nei contenuti, di questo continuo movimento. Se ci riferiamo solo ai testi poetici, la mia sensazione, rispetto a questo percorso, è doppia: da una parte quella che sia la parola a cercare e trovare il poeta (‘Beseda te najde’ è il verso iniziale di una sua poesia, ‘la parola ti trova’), dall’altra quella che il poeta, ricevendola, la plasmi a suo piacimento, rendendola a volte anche meno gradevole, ma fautrice di stimolanti intrecci di pensiero.
Lo scrivere di Aleš Šteger si muove, formalmente, tra poesia e prosa poetica. Cosa ne pensi a riguardo?
Uso le sue parole, in un’intervista ha affermato che quando la poesia lo stanca, passa alla prosa. E viceversa. In realtà chi leggerà questo libro vedrà che esistono dei brani poetici in prosa.
‘Berlin’, libro di un decennio fa riproposto di recente in italiano da Bottega errante con il titolo ‘Le finestre di Berlino’, è un esempio di come prosa e poesie siano in realtà per lui il prodotto della ricerca di una lingua che sgorga dalla stessa sorgente.
Ho l’impressione che il suo scrivere, così ricco di immagini, crei una sedimentazione immediata. Una ricchezza di spunti che permette anche di ‘vedere’ quello che non si vede. Il suo scrivere si muove sempre fra ciò che (si) è, e ciò che non (si) è ma che (si) potrebbe essere. Cosa ne pensi a riguardo?
Dici bene, c’è inoltre, almeno a mio vedere, sempre un senso di incompiutezza voluta, voluta perché parte del vivere quotidiano. In ogni caso sì: vedere quello non si vede, e anche nascondere un po’, creare una leggera parentesi nel senso della poesia, parentesi che il lettore può riempire (anche se non è facile).

Durs Grünbein nella postfazione al libro scrive di come “Aleš Šteger sia una persona che si lasci volentieri sorprendere da se stesso e dagli eventi”. È questa la sua carta d’identità come autore? Sei d’accordo?
Qui devo dissentire. Conosco Aleš da una ventina d’anni, certo non ci frequentiamo spesso ma i nostri seppur rari incontri sono sempre conditi da lunghe chiacchierate, non solo sulla letteratura. Mi sembra che sia abbastanza capace di dominare se stesso e quanto gli succede attorno.
Penso ad esempio alla sua visione ‘politica’ di quanto sta accadendo in Slovenia e in Europa, che in questa raccolta poetica traspare solo in parte ma che è evidente in un suo recente romanzo, ‘Neverend’, dove tratta il tema del populismo nella politica con uno sguardo direi profetico.
A leggere “Sopra il cielo sotto la terra” si può pensare ad Aleš Šteger come a un visionario – ma lui si ferma sempre prima di perdere contatto con ciò che è reale – in costante ricerca di un qualcosa di unico a cui appartenere. Quale può essere questa ‘verità’, se c’è, di cui sentire e vivere la vicinanza?
Forse sta proprio nell’incertezza, nella sensazione che non esista una verità.
Di fatto Šteger appartiene alla prima generazione slovena che si è messa in luce nella post-Jugoslavia, contraddistinta dall’abbandono di enunciazioni di verità grandi e universali.
Le sue, come di altri poeti della sua età, sono quasi sempre racconti di esperienze private, dove l’individuo non ha un’identità solida e stabile.
Com’è il tradurre in italiano Aleš Šteger?
Come tutta la poesia, difficile. Come tutta la poesia, entusiasmante. Ammetto che questo tipo di poesia mi entra meno nelle vene rispetto ad altra perché molto ‘cerebrale’, non ne ho mai parlato con lui ma dubito che sia un poeta che scrive di getto e lascia le cose come stanno.
Piuttosto, riflette molto su quanto scrive. Così anche il traduttore deve riflettere molto (non moltissimo, perché i tempi degli editori sono sempre stringenti) su quanto traduce. Va bene così.
Ormai lui è un autore riconosciuto a livello europeo e anche oltre. Quali pensi siano gli aspetti del suo scrivere che gli hanno permesso di costruirsi questa attenzione? E in cosa è europeo?
Certamente la possibilità di viaggiare come poeta e come scrittore gli è servita molto. In questo senso è proprio un autore ‘globale’, come fino ad oggi era stato, tra gli sloveni, solo Tomaž Šalamun.
Europeo lo è, credo, soprattutto in senso critico. Come dovremmo esserlo tutti. Quella di cui abbiamo bisogno è questa Europa, spesso inesistente se non quando si parla di mercati? Lo dice, lo diciamo con affetto, perché vorremmo non fosse quella “grassa donna pelosa” di cui parla Šteger proprio nella poesia intitolata ‘Europa’.

L’autore:
Aleš Šteger è nato a Ptuj nel 1973, si è laureato all’Università di Ljubljana in letterature comparate e tedesco.
Attualmente vive e lavora a Ljubljana ed è uno degli interpreti più brillanti ed eclettici della nuova letteratura slovena.
La sua prima raccolta di poesia “Šahovnice ur (Scacchiere di ore)” risale al 1995, e ha rappresentato l’avvio di una nuova generazione di poeti che fino all’adolescenza erano vissuti in Jugoslavia, affermandosi poi come poeti nella Slovenia indipendente.
È inoltre direttore editoriale della casa editrice Beletrina di Lubiana.
Ha al suo attivo diverse raccolte di poesia, tradotte in varie lingue.
Ha curato diverse antologie di poesia slovena e tradotto, tra gli altri, Pablo Neruda, Gottfried Benn e Ingeborg Bachmann.
Il suo libro “Berlin / Le finestre di Berlino”, raccolta di brevi prose, si è aggiudicato in patria il premio Marjan Rožanc, ex æquo per il miglior saggio 2007 ed è apparso per la prima volta in Italia per i tipi di Zandonai editore nel 2009.
(Aleš Šteger “Sopra il cielo sotto la terra”, pp.138, 18,50 euro, Passigli editore 2020)

Il curatore:
Michele Obit è nato nel 1966. Ha pubblicato le raccolte poetiche “Notte delle radici” (1988), “Per certi versi/ Po drugi strani” (1995), “Epifania del profondo / Epiphanje der Tiefe” (Austria, 2001), “Leta na oknu” (2001), “Mardeisargassi” (2004), “Quiebra-Canto” (Colombia, 2004), “Le parole nascono già sporche” (2010) e “Marginalia/Marginalije” (Lubiana, 2010).
Ha curato e tradotto il volume “Quel Carso felice”, antologia di poesie dell’autore sloveno Srečko Kosovel, edita da Transalpina nel 2018.
È direttore del Novi Matajur, il settimanale sloveno della provincia di Udine.
Ha tradotto in italiano i più importanti poeti sloveni della nuova generazione e le opere degli scrittori Miha Mazzini, Aleš Šteger e Boris Pahor.
La sua più recente raccolta è “La balena e le foglie”, edita da Qudu libri nel 2019)
Immagini ——————————-
Senza paura
Otto fotografie
di Alessia Ambrosini

Tempo presente —————————-
Da palazzi e divieti
Nove haiku inediti
di Valentina Mariani

entra l’inverno
tra fessure di freddo
virali assenze
cielo nascosto
da palazzi e divieti –
respiro fermo
tra le primule
immobili passaggi –
tace la pioggia
il buio indugia
le tue mani nodose –
sfioro il piacere
occhi assonnati
visitano la sera –
scorie di luna
bicchiere pieno
corrono le mie dita
sopra il tuo corpo
la notte desta
sì fredda primavera –
mi abbraccia il gatto
timo al limone
tenue fragranza effonde
sogni marini
mattino grigio –
il profumo del caffè
copre il silenzio

L’autrice:
Valentina Mariani è nata ad Avellino. Dopo la maturità linguistica prosegue i suoi studi presso l’Università “L’Orientale” di Napoli, dove consegue la laurea in Scienze Politiche discutendo col docente di Filosofia Teoretica, professor Roberto Esposito, la tesi “Tra Etica e Politica in Kierkegaard, Nietzsche, Weber e Benjamin”.
È esperta di cooperazione internazionale e co-fondatrice dell’Associazione “Zia Lidia Social Club”, cineforum itinerante autofinanziato, finestra aperta sulla realtà culturale irpina, nazionale ed internazionale.
Attualmente vive a Bologna. È consulente filosofica e svolge attività sindacale con la CGIL, dove si occupa anche di Formazione, Comunicazione, Pari Opportunità.
Giornalista pubblicista, collabora come redattrice con “Il Pickwick”, rivista di culture, critica e narrazioni.
Ha pubblicato la raccolta di haiku “Gocce di Notte”, edita da Qudu nel 2017.
È ospite nel disco “Pasolini e la Peste” degli Autostoppisti del Magico Sentiero.
Immagini ——————————-
Leggera
Otto fotografie
di Alessia Ambrosini
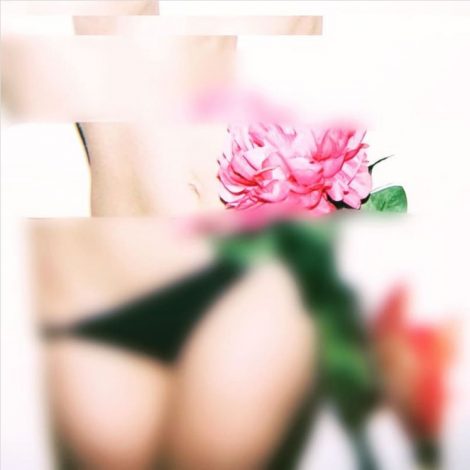
Voce d’autore —————————-
Come ex voto o bave
Pasquale Di Palmo, “Vertebrae”
di Roberto Lamantea

Figure spettrali murate in un’allucinazione cromatica, case in rovina da cui spunta “una vegetazione verde e viola” abitate da morti “che vivono nell’ombra/ di queste abitazioni derelitte,/ di cui nessuno parla, che continuano// i loro gesti assurdi e sempre nuovi,/ condannati a una quotidianità/ che non dà pace e sfuma in questo vento”.
Figure dell’ex manicomio o dell’ospizio che “con il sussurro impietoso degli occhi/ ci chiedono chi sono, dove sono,/ murati nel castello delle vertebre”.
C’è una pietà sotto le righe nel nuovo libro di poesie di Pasquale Di Palmo, “Vertebrae” (Edizioni L’Obliquo, Brescia 2020, 48 pagine, 15 euro). “La carità” è il titolo del libro di Di Palmo pubblicato da Passigli nel 2018: figure di derelitti, persone ai margini, un’umanità di stracci e polvere dimenticata per le strade di Mestre, dove il poeta veneziano (1958) vive. “Trittico del distacco” (Passigli 2015) è il dolce addio al padre malato di Alzheimer (“Da anni parlavi una lingua/ che non è fatta di parole”).
Il tema del margine torna in “Vertebrae” ma qui Di Palmo ha un colpo d’ala che trasforma i 15 testi del libro – composti tra il 2018 e il 2019 – in un canto metafisico, dove il cielo è un abisso rovesciato, la scrittura verbale si rispecchia nei 15 disegni di Giorgio Bertelli, artista ed editore, realizzati con pastelli a olio, tecniche miste e collage su carta, giocando con le poesie di un’altra cartella d’arte di Di Palmo, “Florilegio veneziano” (poesie di Di Palmo e Andrea Longega, L’Obliquo 2020). Se la scrittura rinvia alla pittura di Bacon o alla “vanitas” e la poesia barocca di Ciro di Pers, senza lo spirito religioso del poeta friulano secentesco e con accenti baudelairiani, i disegni di Bertelli ricordano a volte il surrealismo latinoamericano, scene di un aldilà dove l’occhio dell’artista coglie le inquietanti metamorfosi del disfacimento. Bestie macellate, scuoiate, appese ai ganci, dove i fasci di muscoli della carne finiscono con un arto umano; teschi, crani, croci, misteriose divinità che ricordano l’arte azteca, impronte fossili.
È un canto della morte la grafica di Giorgio Bertelli, eco perfetta all’esergo delle poesie, di Jacques Prevel: “Je dois disparaître, il dois rester la vie” (Devo scomparire, deve restare la vita).
(due disegni di Giorgio Bertelli tratti dal libro)
Il libro ha una magnifica nota di Franca Grisoni, che suggerisce come queste poesie e immagini rinviino in controluce ai tanti paesaggi della morte disegnati dalla storia: “La pianura piena di ossa su cui deve profetizzare Ezechiele? Il Golgota? Una delle fosse comuni che rinnovano gli orrori della Storia? O, semplicemente, ciò che attende ognuno arrivato al proprio limite? Dopo l’irruzione violenta della morte portata dalla pandemia che ci ha colpito – così i cadaveri che non hanno potuto essere sepolti ma hanno dovuto essere portati ai forni crematori da camionette militari – i crani protagonisti di molte opere di Bertelli assumono valore di reliquia”.
E sulla poesia di Di Palmo osserva Grisoni: “I ‘morti’, che in una dimensione extratemporale compaiono nei ritagli delle finestre, non sono ombre o ectoplasmi, hanno tratti ancora distinguibili: della loro identità individuale qualcosa si è preservato, come nei ritratti funerari di al-Fayyum a cui rimanda il titolo, straordinarie maschere funerarie pittoriche che riproducono realisticamente i lineamenti delle persone mummificate esprimendone la singolarità, la vita”.
In questo libro la simbiosi tra poesia e grafica è perfetta, il pennino di Di Palmo scarnifica e guarda l’enfer della desolazione che Bertelli trasforma in un canto della materia e della metamorfosi. Ancora Grisoni: “Grazie all’abbondanza di allegorie, metafore e comparazioni, i piani di realtà, sogno e visione si confondono e si fondono. ‘Vermi’ e ‘germi’ non sono solo soggetti del regno animale, ‘corteccia’, ‘linfa’, ‘rami’ e ‘radici’, non appartengono solo alla botanica: i rami hanno ‘dita affilate’, i vecchi hanno ‘dita di ranuncolo’, la loro ‘carrozzina’ è un ‘baccello’ in cui possono solo vegetare; la ‘rosa fiorita in gola’ è il sintomo di una malattia; i ‘ragni’ che un degente sente salire lungo gli arti sono un’allucinazione. Le immagini virano dal regno animale a quello vegetale, la voce si converte in vento, gli oggetti raccontano; gli occhi comunicano, per una poesia che non resta confinata nel regno della parola”.
Le rovine – come in alcune sequenze della “Carità” che ricordano le periferie filmate da Pasolini – del paesaggio, della città e della natura, sono anch’esse immagini del disfacimento: “Talora mi chiedo se la luce/ abbia pietà delle rovine/ che incombono tra erba e spazzatura/ di questa campagna allucinata,/ schiacciata da nuvole/ temporalesche che avanzano/contro un solicello novembrino”.

Dal libro:
Les vers
Versi e vermi,
vermi e versi.
Vermi inermi,
versi inerti.
Versi come vermi
su foglie di lattuga.
Fogli verdi
brulicanti di germi.
*
Visitando con M. una mostra all’ex manicomio di Granzette
“È questa la mia casa?” infila porte
e finestre la domanda
convertita in vento
che avanza silenzioso come un ladro
nei dedali di reparti senza ore.
Fili argentati pendono dagli infissi
come ex voto o bave
di chissà quale degente
morto fra queste travi, qui risorto.
Frugano dita affilate di rami
sfuggite a olmi o platani
che intarsiano il giardino
i cassetti sventrati dei medicinali
impregnati di polvere e larve.
Camminiamo in quel pulviscolo
attoniti, tra geroglifici
scarabocchi prescrizioni,
nell’eco di un sonno da psicofarmaci,
ora bisbiglio d’aghi mentre fuori
non nevica non piove non annotta.
9 settembre 2019
*
Rosa fiorita in gola
Sui campi flagellati
da luce impietosa
ride come un eczema
il volo stordito delle cavolaie.
Si incide contro un cielo
di cartapesta
il fico scheletrito.
Ha pagliuzze di raucedine
la rosa fiorita in gola.
*
Le finestre di Via Litomarino
Nebbia da miope
che anabbaglianti forano a intermittenza
trascinando luci in direzione Trieste…
Divano, ligneo sarcofago
dove a notte rigiri la crisalide
di membra avviluppate tra sonno
e insonnia, movimenti
impercettibili in un fosco
canneto che dirama fruscii, sciabordii…
Cadenza questo stillicidio – le tre, le quattro –
un rombo che evoca
cieli capovolti di limbo,
torpore che simula la mezzavita
di folaga radente l’acqua
un attimo prima della detonazione.

Intervista a Pasquale Di Palmo:
“Vertebrae” è un libro coraggioso, liriche e disegni parlano di un disfacimento fisico e metafisico e insieme di un enfer, un aldilà che sembra il cupo orizzonte di ogni esistenza non solo biologica (vedi le case diroccate, i luoghi abbandonati). Negli altri tuoi libri, “Trittico del distacco” e “La carità”, la tua poesia è più intonata a una terrena pietas, sensibilità che in controluce si legge anche qui, ma meno esplicita. Resta la fiducia nel linguaggio, nella scrittura verbale e visiva. È una nuova fase nella tua ricerca letteraria?
Non è facile rispondere a questa domanda. Non so dirti se si tratti di una nuova fase. Presumibilmente è la naturale evoluzione di un percorso piuttosto articolato, partito da posizioni quasi antitetiche rispetto a quelle cui sono approdato con le ultime raccolte. L’attenzione formale, pur presente in tutte le fasi di questo processo, ha risentito di tali cambiamenti, orientandosi verso un tono più prosastico rispetto a quello degli esordi, atto a rimarcare una maggior aderenza a tematiche condivise, senza tuttavia rinnegare uno scarto polemico, orientato a rivalutare ciò che viene spesso considerato anacronistico, inattuale. Gradualmente il registro linguistico si è fatto più immediato e fruibile.
Sono sequenze, microsequenze, in cui il lettore può riconoscersi, in virtù di alcuni frammenti memoriali che Franca Grisoni ha definito, nella sua nota introduttiva, propensi ad offrire “rivendicazioni di storie e di vite che non potranno mai più essere espresse”.
Ecco, l’intento è proprio quello di misurarsi con la vita (parlando a volte, paradossalmente, di morte e malattia), con l’altro da sé, senza alcun tipo di sovrastruttura, facendo rivivere una serie di personaggi e situazioni con l’ausilio di una parola che non ne snaturi le doti empatiche con cui sono stati colti originariamente. Da qui la scelta di un registro basso, anche se connotato da soluzioni metriche differenziate e adeguate al singolo contesto.
Le “case diroccate, i luoghi abbandonati” diventano allora metafora di una precarietà che attanaglia un uomo sempre più disancorato rispetto a quelli che dovrebbero essere i suoi referenti naturali, che si accontenta, per essere rappresentato, di una parola essenziale, priva di alcun artificio letterario, scarnificata, ridotta all’osso.
Ci racconti come è nato il progetto di un libro di versi e disegni? È il tuo secondo libro con Bertelli dopo “Florilegio veneziano”, scritto con Andrea Longega. Come nasce il confronto tra disegni e versi?
In realtà la collaborazione con l’amico Giorgio Bertelli è di vecchia data, in quanto abbiamo realizzato insieme diverse plaquettes, da lui illustrate attraverso le tecniche più disparate.
Ho pubblicato inoltre con il marchio editoriale l’Obliquo la raccolta “Ritorno a Sovana” nel 2003. Ho altresì curato vari lavori di traduzione (da Artaud a Michaux a Gilbert-Lecomte), oltre a scrivere l’introduzione a un volumetto di Genet. Mi piaceva molto l’idea di realizzare un manufatto che si ispirasse a una grafica un po’ retrò, coniugando rigore espressivo ed eleganza formale. Ero rimasto molto affascinato dalle “Variazioni sull’Ecclesiaste” di Attilio Lolini, libro apparso postumo, stampato fuori commercio dall’Obliquo in occasione del trentennale della nascita della casa editrice, ispirato alle tematiche religiose del Qohélet e illustrato dallo stesso Bertelli. Ci siamo ispirati a tale modello, soprattutto nella scelta di una serie di immagini che non fossero didascaliche ma che si ponessero in aperta dissonanza con i testi presentati.
Coltivavo da tempo il progetto di stampare un libro fuori commercio, svincolato dalle dinamiche “intossicate” del numero di copie vendute, dove fosse possibile riscoprire una dimensione artigianale, presente nella mia stessa scrittura creativa e svincolata da qualsiasi presupposto inerente al profitto. Qualcosa di necessario e, al tempo stesso, di gratuito.
Il volumetto, stampato in 300 copie, ha una tiratura di testa di 40 esemplari contenente una linoleografia originale dell’artista.
Il tuo lavoro di francesista, di studioso, critico e traduttore, incide sul tuo essere poeta?
Considero l’impegno esegetico come qualcosa di profondamente connaturato al mio essere, qualcosa che mi dà l’opportunità di svariare intorno a molteplici argomenti riconoscendo al contempo in essi quella comune origine umanistica che è stata ingiustamente svalutata da un po’ di tempo a questa parte in favore di studi scientifici e tecnologici.
D’altro canto, un autore come Sinisgalli, in tempi non sospetti, ha dimostrato che è possibile conciliare questi due aspetti dello scibile che sembrano idealmente contrapposti. Si pensi alla rivista “Civiltà delle macchine” fondata dal poeta lucano o allo stesso Gadda che era ingegnere.
L’importante è considerare queste attività, apparentemente differenti, con un piglio creativo, alla stregua di un atto poetico tout court.
I tuoi più grandi amori in letteratura?
Le suggestioni in tal senso sono molteplici e non necessariamente univoche, anche se rimango sostanzialmente fedele a quelle figure di irregolari di cui ho approfondito la lezione, occupandomene sia in ambito critico sia sul versante delle traduzioni: Artaud e Desnos in primis, ma anche Landolfi, Vigolo, Sereni, Cristina Campo, solo per fare qualche nome e restare in ambito italo-francese. Con il tempo i gusti cambiano, gli autori che mi entusiasmavano sono stati ridimensionati a favore di altri che, all’epoca, magari venivano snobbati.
In questo periodo mi sto appassionando all’opera variegata, disseminata di molteplici richiami alle scritture sacre ed esoteriche, di un poeta, romanziere e saggista lituano che si esprimeva in francese: O.V. de Milosz.
Con l’amico Maurizio Cecchetti, factotum di Medusa e MC edizioni, stiamo cercando di rilanciare la sua figura anche nel nostro paese.

L’autore:
Pasquale Di Palmo è nato nel 1958 a Venezia, dove vive. Ha pubblicato le raccolte di poesia: “Quaderno del vento” (Stamperia dell’Arancio, 1996), “Horror Lucis” (Edizioni dell’Erba, 1997), “Ritorno a Sovana” (Edizioni L’Obliquo, 2003), “Marine e altri sortilegi” (Il Ponte del Sale, 2006), “Trittico del distacco” (Passigli, 2015, Premio Ceppo Pistoia 2017) e varie plaquettes, tra cui “Addio a Mirco” (con illustrazioni di Pablo Echaurren, Il Ponte del Sale, 2013).
Sue poesie sono apparse in numerose antologie e riviste, tra cui “Nuovi Argomenti”, “Poesia” e “Paragone” e sono state tradotte in diverse lingue.
Ha pubblicato i saggi: “I libri e le furie” (2007), “Lei delira, signor Artaud. Un sillabario della crudeltà” (2011) e “Venezia. Nel labirinto di Brodskij e altri irregolari” (2017).
Ha curato e tradotto diversi volumi, tra cui opere di Artaud, Corbière, Daumal, d’Houville, Gilbert-Lecomte, Huysmans, Michaux e Radiguet. Ha inoltre curato “I surrealisti francesi. Poesia e delirio” (2004), “I begli occhi del ladro di Beppe Salvia” (2004), “La vita, le immagini” (2005), “Saranno idee d’arte e di poesia. Carteggi con Buzzati, Gadda, Montale e Parise” (2006), “Album Antonin Artaud” (2010).
Collabora all’inserto culturale “Alias” del quotidiano “Il manifesto”.
(Pasquale Di Palmo, “Vertebrae” pp. 43, 15 euro, Edizioni L’Obliquo 2021)
Immagini ——————————-
Vanità
Otto fotografie
di Alessia Ambrosini

Voce d’autore —————————
U còri l’àssavvàri tùttu
Saragei Antonini, “A virìna”
di Giovanni Fierro

“A virìna” è un libro con cui fare i conti, poesie con cui è bene confrontarsi, per iniziare a chiedersi se temi come ‘casa’ e ‘famiglia’ possano stare al mondo, e in che modo.
Perché Saragei Antonini, l’autrice di questo volume, porta in superficie parole incise nel profondo della carne del vivere, che sanno stare dentro al sangue, si muovono nel corpo, tagliano in ampiezza ogni verità. Non si fermano davanti a nessun tremare.
Il suo scrivere è una confessione, con ogni sentire esposto, scorticato ma capace di una armonia, necessario ma sempre destinato a creare un luogo dove poter essere accolti.
Saragei Antonini ha ben presente “ca si tùttu ’ncudduriàtu/ quannu mori/ si tùttu cca – che sei tutto attorcigliato/ quando muori/ sei tutto qua”; e che questo sapere diventa una cucitura stretta con “u bèni ca ti vosi/ si fimmàu/ si ràpi u cèlu/ si ràpi a vùcca – il bene che ti ho voluto/ si è fermato/ si apre il cielo/ si apre la bocca”. E questa è una possibile origine di questo suo intenso scrivere.
Scrivere che si rafforza ulteriormente con il dialetto che l’autrice usa, e che non è solo quello della sua Catania, ma anche l’intreccio con il dialetto del padre, nato al confine Emilia-Romagna e Marche.
Una lingua personale, intima e propria, che trova sempre la verità dell’espressione.
“A virìna” è costruire una casa fatta del proprio vivere, dove si possono trovare finestre che non specchiano, che sanno solo separare il dentro dal fuori, il paesaggio dallo sguardo, ma anche l’interno del proprio stato emotivo dall’esterno del mondo.
Questo fare poesia di Saragei Antonini è uno luogo di cui capire i contorni, di cui misurare il perimetro, per dare forma al contenuto.
E la spina dorsale delle propria famiglia può essere tutta contenuta in questo ritratto: “me màtri era vèntu/ me nonna era vèntu/ me pàtri à statu ’na vìta ppì capìri còmu fàri –/ era ’na vàcca sìnza mutùri/ sùlu òcchi e ràzza –/ – mia madre era vento/ mia nonna era vento/ mio padre c’ha messo tutta una vita per capire come fare –/ era una barca senza motore/ solo occhi e braccia –“.
Si, “A virìna” è trovare il ‘costo’ del vivere e del sentire; è il desiderio di potere essere un ‘noi’, anche quando si sa che ogni dialogo è più impossibile che possibile.
Da questo punto è inevitabile iniziare a chiedersi “cosa sono? chi sono?”.
Ed è il momento esatto in cui iniziare a disegnarsi, a fare un possibile autoritratto, dove avere la forza di dire “m’ata scusàri/ si chìddu ca pigghiai era ’nfennu/ rìttu/ lòngu/ ma n’ata crìriri/ ca era càuru – mi dovete scusare/ se quello che ho preso era inferno/ dritto/ lungo/ ma non dovete credere/ che era caldo”.
La poesia di Saragei Antonini non torna indietro, e se lo fa è solo per tracciare una provenienza, una appartenenza a cui non sottrarsi: “me nonna capeva quattru còsi/ e ppi ddi quattru còsi ancùra campa/ acqua ravanti/ vèntu r’arrèri/ e a mòtti ccù sapùni sùtta i pèri – mia nonna capiva quattro cose/ e con quelle quattro cose ancora vive/ acqua davanti/ vento dietro/ e la morte con il sapone sotto i piedi”.
Rimanere in questo libro è anche incontrare una solitudine, umana e temporale. Una soglia attraversata, che libera la propria esistenza dentro un respiro che è definitivamente personale, che risponde solo al proprio nome e cognome. Anche solo per dirsi, magari in silenzio “picchì quannu chiànci còmu quannu canti/ si ’na còsa ammènzu a l’àutri còsi/ ’na còsa nìca – perché quando piangi come quando canti/ sei una cosa in mezzo alle altre cose/ una cosa piccola”.
Ma con tutta la forza di sapere che “Arriminu intra a sacchetta/ attrovu càtta ca mi rici quantu pavai/ ni fazzu nùvuli/ appòi pensu a ttìa/ e chìssu è u sùli/ e mi costa chiassài/ pavu e nun m’arresta nènti – Frugo dentro la tasca/ trovo carta che mi dice quanto ho pagato/ ne faccio nuvole/ poi penso a te/e questo è il sole/ e mi costa di più”.

Dal libro:
A vùci ro friggideri m’agghiaccia –
è chìdda re sali r’aspettu
ri tùtti i còsi c’aspetti
ca ti toccunu
e nun sai ppi ùnni
nun sai màncu
si ti susi appena ti chiàmunu.
La voce del frigorifero mi congela –/ è quella delle sale d’aspetto/ di tutte le cose che aspetti/ che ti toccano/ e non sai per dove/ non sai nemmeno/ se ti alzi appena ti chiamano.
*
Ma u còri nun àvi gnùni
e màncu puttùsa
ùnni ammucciàriti
u còri è tùttu ’na còsa
u còri l’àssavvàri tùttu
nun è fattu ri patti
nun è fattu ri fèrru
macàri ca pìsa chiassài –
ri còri nun si parra
e nun s’avissa màncu scrìviri
u còri l’amaffàri
ppi còm’è
e a mmìa mi pàri u stìssu
’n tutti i cristiani
’na còsa addùmata
ca pàri ca s’astùta
e ’nvèci ammùtta.
Ma il cuore non ha angoli/ e nemmeno buchi/ dove nasconderti/ il cuore è tutto una cosa/ il cuore lo devi conservare tutto/ non è fatto di parti/ non è fatto di ferro/ anche che pesa di più –/ di cuore non si parla/ e non si dovrebbe nemmeno scrivere/ il cuore lo dobbiamo fare/ per com’è/ e a me sembra uguale/ in tutte le persone/ una cosa accesa/ che sembra si spenga/ e invece spinge.
*
U chiòvu –
iù ci pinsu spìssu ’o chiòvu
all’amùri ca àvi
chiantatu
mènzu intra e mènzu fòra –
nùddu àvi ’st’amùri
ri stàrisi fèmmu
fàrisi fòzza –
u chiòvu è sùlu
nasci sùlu
rui chiòva assèmi nun si virunu mai
’nto stìssu puntu –
ru chiòvu iù sàcciu sulu a tèsta
chìdda ca viru
ma u còri l’àvi fòssi ’nta punta
chìdda ca tràsi ’n fùnnu
e à viristi sulu ’na vòta.
Il chiodo –/ io penso spesso al chiodo/all’amore che ha/ piantato/ mezzo dentro e mezzo fuori –/ nessuno ha quest’amore/ di starsi fermo/ farsi forza –/ il chiodo è solo/ nasce solo/ due chiodi insieme non si vedono mai/nello stesso punto –/ del chiodo io so solo la testa/ quella che vedo/ ma il cuore ce l’ha forse nella punta/ quella che entra in fondo/ e l’hai vista solo una volta.
*
A casa è chìddu ca si
nun sunu ’sti mùra
nun sunu tutti ’sti pòtti e ’sti finestra
nun è a vùci ca ti salùta quannu tràsi o nesci
a to’ casa nun accumincia màncu ro putticàtu
nun è a lùci c’addùmi
o chìdda c’astùti
nun sunu i schìgghia
nun è priparariti ri manciàri –
a casa si tu
e sulu tu
si ppòi a casa ti casca ri ’ncòddu
è picchì trimasti e ti scantasti ri tìa.
La casa è quello che sei/ non sono queste mura/ non sono tutte queste porte e queste finestre/ non è la voce che ti saluta quando entri o esci/ la tua casa non comincia nemmeno dal portone/ non è la luce che accendi/ o quella che spegni/non sono le urla/ non è prepararti da mangiare –/ la casa sei tu/ e solo tu/ se poi la casa ti cade addosso/ è perché hai tremato e ti sei spaventato di te.

Intervista a Saragei Antonini:
Leggendo “A virìna” colpisce subito una certa intimità svelata. Il raccontare è questo mettersi a nudo? Quale il ‘perché’ che ti ha spinto a farlo?
Ho sempre scritto quel che vivo e la vita secondo me – credo questo sia naturalmente intimo ed inevitabile mettersi a nudo – in “A virìna” l’intimità, oltre che dal dialetto, è data dall’esigenza di voler rivivere suoni e immagini della mia infanzia, di una storia familiare fino ad oggi.
Mi sembra che in questa tua scrittura ci sia una ricerca dell’essenziale. Che rispecchia una certa determinazione nel volere anche ‘andare all’osso’ dei contenuti e dei significati. Può essere così?
É così. Il dialetto, con il suo spontaneo ed improvviso nominare il mondo, e lo scrivere in dialetto, è stato ed è per me una ricerca personale che riguarda le ossa del mio scrivere nonché di una lingua mia e forse un senso delle cose per me e grazie al quale imparo anche a stare.
Difatti, il dialetto che usi in “A virìna” è molto particolare…. e cosa significa per te il suo uso?
Ho scritto per anni in italiano finché una voce interna sentiva e mi parlava in dialetto – in qualche modo traduceva quel che prima non sapevo – da qui ho cominciato a scrivere in dialetto ed è stato strano, come ricercare i suoni uditi da mia nonna, mia madre e mio padre che non era originario della Sicilia ma nato al confine tra l’Emilia-Romagna e le Marche – inoltre, i miei genitori hanno vissuto per otto anni a Zurigo e il risultato è stato un insieme di dialetti che creavano anche parole e accenti fino a una lingua propria della casa in cui sono cresciuta – dunque scrivere in dialetto è stato rivivere la storia e l’origine della mia famiglia – è stato anche fare i conti con l’italiano fino ad arricchirlo e divertirlo – è stato vedergli le ossa e aggiungere quelle del dialetto – ho creato l’ossatura del mio linguaggio e il sentiero che posso seguire secondo un dialogo ormai fitto e libero tra il dialetto e l’italiano – non sono giunta a questo facilmente perché l’incontro di tutti questi elementi è stato complesso – un lungo periodo di ricerca ascolto traduzione … anche di me stessa, fino a raggiungere una lingua che sento mia e di cui so lo scheletro.
In queste tue intense pagine, si ‘sente’ la costruzione di un luogo dove poter stare e dove trovare la propria identità. È anche un modo per riconoscere una possibile ‘casa’?
Sì. In quasi tutti i miei testi è presente la casa con i suoi interni e variazioni di ombre e luci – scrivere per me è fare casa … abitare ed essere abitati.
In “A virìna” sono entrata nella casa di famiglia e nella casa che sono oggi – nel bene e male delle loro stanze – ho disegnato una mappa, vissuta e presente.

L’autrice:
Saragei Antonini è nata a Catania nel 1973, dove vive, da padre nato al confine tra le Marche e l’Emilia-Romagna e madre catanese.
Ha pubblicato le raccolte di poesie “Il cerino soggetto” (2000, La Vita Felice), “L’inverno apre un ombrello in casa” (2004, Prova d’Autore); “Sotto i capelli una nave” (2010, Forme Libere); “Egregio signor Tanto” (2013, CFR) e “La passione secondo” (2017, Forme Libere).
Ho ricevuto premi per l’edito e l’inedito, in italiano e in dialetto.
Alcuni suoi testi sono presenti in antologie e riviste in Italia e all’estero.
(Saragei Antonini “A virìna” pp. 88, 9 euro, Edizioni Salarchi Immagini 2019)
Immagini ——————————-
Qualcosa sta cambiando
Otto fotografie
di Alessia Ambrosini

Tempo presente ————————————-
Per misurare la distanza
Massimiliano Bottazzo, “Tracce” e “Scalzo per errore”
di Sandro Pecchiari


Massimiliano Bottazzo è nato a Padova nel 1968. Durante gli studi universitari di filosofia ha fondato e collaborato con altri con la rivista “Simplegadi” di filosofia comparata tra pensiero orientale e occidentale. Dal 2005 ha scelto Udine come sua dimora. Scrive poesie da lungo tempo ma solo ultimamente ha portato a termine due raccolte, “Tracce” del 2016 e “Scalzo per errore” del novembre 2020, entrambe con la casa editrice Caosfera, nella collana di poesia diretta dalla poetessa Adriana Gloria Marigo.
Nella prima raccolta, “Tracce”, i tragitti percorsi in tempi e spazi disparati e lontani tra di loro si (con)fondono in una affabulazione continua che tende a enucleare le cose essenziali e indelebili in una rilettura disincantata e ironica: collegare con la sua leggerezza sempre incisiva gli accadimenti e le riletture dell’esistenza a dei momenti ‘culinari’ li rende contemporaneamente scollegati e indistricabili.
Il triste sospetto di sprecare fette o porzioni di vita si rispecchia nella ‘malinconia del budino’, ma viene consolata ‘con grandi pezzi di cioccolata’. Il ‘puzzo di sconfitta’ non regge il confronto con il profumo più reale e salvifico del ‘sugo delle seppie’ in preparazione.
La seconda raccolta da poco in libreria, “Scalzo per errore”, ricostruisce e rilegge il mondo reale e quello degli affetti come contradditori luoghi in fieri, conducendo il lettore in un viaggio simbolico personale e privato, rivolto in gran parte ad una quotidianità questa volta notevolmente più interiore di quella del libro precedente.
Massimiliano scrive di sé che nelle sue poesie il personale e il privato sono entrambi ricorrenti, però, confrontando i due libri, il percorso fatto da Bottazzo nella seconda raccolta presenta delle variazioni, affinamenti e nitidezze in evoluzione in una discesa nel profondo di se stesso.
“Tracce” è senza dubbio un tragitto lungo tempi e luoghi diversissimi uniti con una osservazione attenta dalla quale trasparisce un certo disincanto se non amarezza nella rappresentazione del suo stare al mondo. La realtà esterna e quella privata si intrecciano in modo spesso indissolubile, dalla saudade malinconia anche se vivace e colorata di Lisbona che non offre un posto dove poter sostare e far sostare l’anima alla ostica e pietrosa Orsera che ispira ritratti intagliati e corrosi dal mare della percezione.
Visi
quali visi incontrerai ad Orsera già lo sai
pelli di cuoio modellate dai venti
bruciate dal sole
dalla salsedine invecchiate
della fatica dei campi qualche ruga
a storpiare il sorriso
visi da istriani
alcuni rimpiangono Tito
e tu non capisci perché
delle guerre più recenti
non parlano volentieri
mentre posano gli sguardi altrove
a Brostolade ora abitano i bosniaci
per carità brava gente
ma ognun sa del suo
i visi di Orsera non sanno di riposo
li ho spiati quando guardano il mare
a volte gli occhi restano a terra
perché le lacrime sono troppo pesanti
per alzarli
La memoria di tutte queste impronte non riesce a modificare o correggere la storia e la Storia, nulla sembra ripetersi per poterle redimere, nulla mantiene un’autonomia, un appiglio sul quale poter operare o agire nuovamente, perché tutto appare confuso e confondibile
d’improvviso conosci/ che non c’è ripetizione/ …ogni fatto è per sempre/e già sei morto
dove in un sentore onirico, una possibile idea di morte è amalgamata all’amore prepotente dei versi, uno iato che ci fa vivere “sappiamo restare insieme/ mantenendo infinite distanze” (Après Midi).
I versi luminosi del ‘Diario Elbano’ confermano questa lettura della quotidianità come sostegno alla rilettura della stessa realtà anche nei ritmi rallentati di un periodo di vacanza:
Un lunedì
decidendo di passeggiare
sul lungomare di Marina
accettai che la giornata
fosse malinconica
volendo assecondare il mio umore
il Capanne risucchiò il cono di luce
e il mare prese a farsi di piombo
al Borgo del Cotone
un gatto rosso probabilmente
pensò che il sole
sul promontorio di fronte
fosse uno scherzo
da accettare chiudendo gli occhi
e ancora
la tempesta da due giorni ci sta ingannando
le raffiche che tormentano
gli oleandri invasati
sono tali e quali alle onde
giù alla spiaggia delle Viste
ho recuperato in settantadue ore
la lentezza che fa distinguere
dovrò partire dopo aver visto me stesso?
intanto mi alzo a spegnere
il sugo di seppie
Non è possibile non citare la tenerezza nel suo raccontare e raccontarsi che richiama la scrittura stralunata e tagliente di Simic che invoca in tutto questo vissuto anche la necessità temuta di dimenticare:
I belong to no one (1)
my father and mother who died at birth
that’s the only image
that turns up
goccia a goccia
misuro le parole
come vecchi rubinetti insistono
per ogni tocco un senso prende forma
and nowhere to go back to (2)
ossessivi rintocchi della memoria
svegliano i sensi di colpa
e il timore più grande
dimenticare il tuo viso
tornando una sera dal lavoro
dimenticare la tua voce
dimenticare che sei stata
la mia famiglia dodici anni appena
a large ocean liner caught in the ice
le mie scarpe ferme
a bagnarsi di lacrime
1 A nessuno appartengo
mio padre e mia madre nati morti
questa la sola immagine
che ne salta fuori
2 e nessun luogo a cui tornare
È un libro che ci lascia con la consolazione dell’affetto per le cose, gli animali e le persone con la sensazione inquieta che tutti rimangano assieme e separati:
“Restammo davanti al gelso/ con lo strudel tiepido tra le mani/ guardando negli occhi un asino felice“.


Passando a “Scalzo per errore”, nella postfazione, Simone Furlan sottolinea che la scrittura profondamente onesta di Bottazzo è volta alla ricerca di un significato del nostro vivere e, quindi, dei possibili modi per dirlo. E questo è saper fare una cosa rigorosamente semplice, ma difficilissima da reggere: guardarsi allo specchio, fissare il proprio sguardo senza abbassare gli occhi, mantenere questo rigore e disciplina di osservazione costante e scriversi.
L’apparente disinteresse per i lettori, vista la sua potente focalizzazione in questa discesa verso il proprio mondo interiore, si riscatta forte nella offerta di disponibilità e sincerità e proprio nella stessa condivisione del suo percorso, indicando non soluzioni ma possibili differenti vie di interpretazione del nostro non facilmente definibile e contraddittorio dasein.
E tra l’osservazione della realtà esterna e l’interrogarsi sulla natura della cose interiori si incontra e ci si sofferma nell’angolo cieco delle cose in cui si addensano le diverse strategie: l’osservare, l’osservarsi, il non-fare in una pigrizia coatta, forse addirittura un sapiente ironico wu wei declinato all’occidentale, il saper sottostare alle leggi della sopravvivenza quotidiana, il prepararsi da mangiare, il nutrirsi in una bolla di niente, nel vuoto-pieno di concezione quasi buddista:
tranne l’essenziale ho davvero tutto
eppure sono un meccanismo inceppato
quando la paura di vivere si fa ingombrante
combatto a mani nude
cerco un farmaco
la domenica pomeriggio
sembra che nessuno sia ammalato
quando penso che vorrei rifare con te
ciò che è già stato
recuperare le mancanze
per aggiustare queste crepe
alla fine resto solo
ormai viene ora di cena
ripasso mentalmente le parole
che non saprò mai dire
nello specchio mi osservo
Sono sempre presenti luoghi precisi (citerei Salvore, San Martino) che però sono sostegni al ricordo, alla rilessicazione e tendono ad un percorso che oscilla nel tempo:
a Punta Salvore
c’è un ristorante
che merita
con le luci colorate
da sagra sulla testa
dall’altra parte
della strada
in posizione elevata
il cimitero
insegue l’ombra
sul muro
la tua rincorsa
in fondo al viale
a San Martino andavamo
timidi
ad ascoltare
aspro il Terrano
enormi paste alla crema
l’odore forte dei kipfel
ascoltavo curioso
stazioni radio slovene
intanto ci sono tornato
a cercarci
Questa è la frattura che segue ad un bilancio in cui lo spazio si attorce su se stesso, si contrae, si rivive e ripercorre senza sollievo né soluzione, diventando uno stop and freeze.
Forse sta qui il sollievo, in queste crepe incomplete, riconsiderate e rilessicate, sufficientemente immobili da poterle leggere e da riproporle con rigore agli altri.
E la lettura si piega ad arco con la prima poesia della raccolta che è intitolata “Conclusione”:
in questa quasi estate
nella mia casa troppo
vicina alla tua
basta stendere la mano
per misurare la distanza
del mi manchi
mentre attendo invano
resto come si resta la notte
in silenzio
aspettando che passi
E l’ultima che conclude con la casualità degli incontri, quelli che accadono fuori dagli schemi, senza zavorre dolorose, quelli che coinvolgono i sensi, che fluiscono senza bisogno di spiegazioni, finalmente
dei tanti luoghi a sedere
che il porto consente di scegliere
preferisco da sempre
il più vicino ai pescherecci
la puzza che sale
consente di misurare
la distanza
tra desideri e realtà
ho imparato ad aver cura
di quelle situazioni in cui
ci si incontra per vino e per parole
di quelle cose che si dispiegano
come il corso dell’acqua
che a spiegarle
ci si sente un po’ ridicoli

L’autore:
Massimiliano Bottazzo è nato a Padova nel 1968, ha vissuto a Gorizia e attualmente risiede a Udine. Durante gli studi universitari fonda, assieme ad altri studiosi, la rivista “Simplegadi” di filosofia comparata tra pensiero orientale ed occidentale, contribuendo alla stessa con articoli e traduzioni.
La sua prima raccolta poetica è ”Tracce”, del 2016.
(Massimiliano Bottazzo “Scalzo per errore”, pp. 64, 10 euro, Caosfera edizioni 2020)
Immagini ——————————-
Veins
Otto fotografie
di Alessia Ambrosini
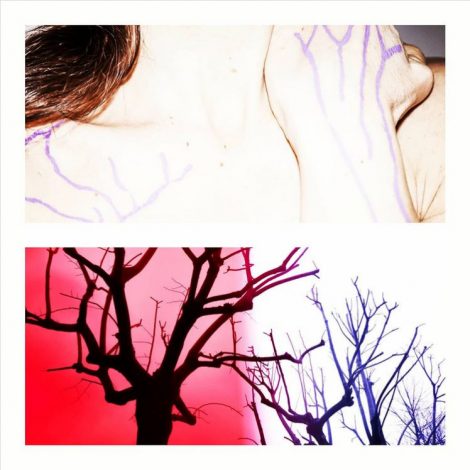
Da qui —————————
Un sole e tanti voli neri
Piera Oppezzo, “Esercizi d’addio, Poesie inedite 1952-1965”
di Roberto Lamantea

Quand’era bambina, Piera Oppezzo aveva il terrore delle bombe. C’era la guerra, e la guerra per lei erano il buio, gli scoppi, il terrore nei volti, le fughe. “Il ricordo della mia infanzia/ è guerra. Un motore/ nel cielo si avvicina/ alla mia testa,/ i giocattoli diventano mostri./ Aiuto! La mia bambola è stecchita” scriverà in una poesia del 1956, “Protesta”. Una giovinezza “senza progetti d’amore,/ di casa e figli sani”. Mentre un’anziana spera di morire.
E oggi “si riparla di guerra”: “Che pazzia, tornare indietro”.
“Protesta”, testo di una struggente amara innocenza, è una delle 84 poesie di Piera Oppezzo mai edite in volume ora raccolte da Interno Poesia di Andrea Cati nella collana Interno Novecento, in “Esercizi d’addio. Poesie inedite 1952-1965”, a cura di Luciano Martinengo, con prefazione di Giovanna Rosadini e postfazione di Gaia Carnevale. È sempre merito di Martinengo l’editing di “Una lucida disperazione”, introduzione di Giancarlo Majorino, pubblicato da Interlinea nel 2016, antologia di testi editi e inediti.
All’autrice torinese (1934-2009), il regista dedica inoltre il video “Il mondo in una stanza – Piera Oppezzo poeta (2018)”, in rete su Vimeo, un delicato viaggio nel mondo della scrittrice con i ricordi dei suoi amici. All’amico Luciano, poco prima di morire, Piera lasciò degli scatoloni, “le mie cose” le chiamava: le riviste che avevano pubblicato i suoi testi, fotografie, riflessioni, appunti, le poesie battute a macchina, ciascuna con la data, in ordine cronologico, senza cancellature o varianti.
Ne è nato questo libro dal titolo bellissimo, stilato dall’editore Andrea Cati. I testi precedono quelli di “L’uomo qui presente”, silloge d’esordio di Piera Oppezzo pubblicata da Einaudi nel 1966 nella “Collezione di poesia”.
Piera Oppezzo fu subito un caso letterario. Nata a Torino nel ‘34 da una famiglia di modeste condizioni economiche – segno di quegli anni era, ricordano i suoi amici, “l’odor di cavolo”, di bollito che sa di rancio, di caserma, simbolo di povertà. Scoperta da Vincenzo Cardarelli che la pubblica sulla Fiera Letteraria, altre sue poesie escono sulla rivista della Rai, dove dal 1962 Piera lavora come dattilografa nella sede torinese – conobbe il lavoro già da bambina: sartina a 9 anni per 9 ore al giorno, ai ritmi del lavoro dedicherà il romanzo dal titolo esplicito “Minuto per minuto” (La Tartaruga 1978) – ed è subito conosciuta nell’ambiente letterario torinese: Carlo Fruttero la presenta a Giulio Einaudi che, con Guido Davico Bonino e Italo Calvino, decide di pubblicarla nella “bianca”.
Dal capoluogo piemontese Piera nel 1966 si trasferisce a Milano, dove vive il decennio ‘68-’78 nel movimento femminista e sposando la contestazione: il libro simbolo di quegli anni è “Sì a una reale interruzione” pubblicato dalla Geiger di Adriano Spatola nel 1976. C’è una bella foto di gruppo dove Piera è insieme ai grandi nomi della letteratura di allora: tra gli altri Giovanni Raboni, Franco Fortini, Giuseppe Pontiggia, un giovane Antonio Prete, Tomaso Kemeny, Adriano Spatola, Cesare Viviani…
A Milano Piera visse un grande amore – il pubblicitario Carlo Marvelli, a cui dedicò “L’uomo qui presente” – poi anno dopo anno, lei che non aveva mai amato i riflettori, si defilò. Morì in solitudine nel 2009 all’eremo di Miazzina sul Lago Maggiore. “Non si può dire che meramente non visse, ma visse scrivendo, chiudendo man mano il mondo fuori dalla sua stanza, come tante prima di lei avevano fatto, rendendosi non disponibile a molti contatti, chiudendo fuori gli altri dalla casa occupata dove viveva a Milano negli anni ‘90 e in quella protetta negli ultimi due anni” scrive Anna Toscano in un saggio molto bello pubblicato su doppiozero.com.

Ora grazie a Martinengo, alla cura appassionata di Giovanna Rosadini e a Gaia Carnevale, che a Milano si è laureata su Piera Oppezzo ed è oggi – come dice Giovanna con affetto – la maggiore esperta della scrittrice, la figura di Piera Oppezzo sta finalmente tornando ad avere il ruolo che merita, che è quello di una delle più intense autrici del Novecento italiano. Una “voce ritrovata” scrive Rosadini.
I testi del libro (1952-1965) preludono e annunciano l’esordio de “L’uomo qui presente” (1966), mentre l’antologia di Interlinea arriva fino alle ultime cose, al 2009, l’anno della morte, partendo dagli anni di Torino (1950-1965).
Ora il lettore ha a disposizione un’ampia parte del corpus oppezziano – in attesa di altri documenti e studi. Esercizi di addio è prezioso perché definisce con ulteriore evidenza la formazione stilistica dell’autrice torinese. È interessante vedere come il libretto einaudiano, primo titolo pubblicato, sia già un punto d’approdo nella scrittura di Piera: la poetica della realtà, la sovrapposizione tra versi e prosa e la riflessione sul linguaggio saranno i temi della neoavanguardia e saranno approfonditi nei testi successivi.
Se già nel loro manifesto (l’antologia einaudiana del 1961 a cura di Alfredo Giuliani) i Novissimi insistono sulla crisi del linguaggio poetico, in una cinquina ne “L’uomo qui presente”, dal titolo “Iterazione”, Piera scrive: “Le parole non si flettono più. Si snodano in una iterazione/ che non precisa il senso delle cose/ ma ci avverte ampiamente/ di un loro possibile futuro”. Versi importanti: Piera metteva la scrittura davanti a tutto.
Nel percorso di “Esercizi d’addio” una svolta si nota nel 1957, con la poesia di pagina 61: lo stile diventa più narrativo, con ritratti, fotografie di vita, riflessioni; cambia la scena e irrompono l’ambiente urbano, la frattura uomo-natura, l’ironia ribelle, ma anche la sofferenza, il dolore, sue parole simbolo.
Nella prima parte l’antologia di Interno Poesia rivela una Piera di formazione simbolista, lettrice di Leopardi e Pascoli, delle sue amate Dickinson e Cvetaeva, con esiti di una bellezza struggente: “In qual gelo, le mani/ circondano il viso:/ ombre d’ali bianche/ per filtro di luci remote. […] Pure, tu, cerchi voci morte/ ed io sogno il tuo sogno/ nell’ora già breve e disciolta” (si noti la bellezza vocativa e invocativa di quel “tu” sospeso tra due virgole); “Ascolta il soffio del vento,/ sarà per te/ l’abbraccio delle lontananze”.
Nel film di Martinengo Giancarlo Majorino definisce Oppezzo un’autrice “difficilissima, enigmatica”.
Per Elena Broseghini “è come se volesse dare un nome alle cose per la prima volta, cercava di snidare un senso nell’assurdità del vivere, cercava l’epica del vivente”. E Maria Martinotti: “Ha cercato l’assoluto”. Giovanni Tesio: “Aveva un’ambizione estrema nei confronti della parola, l’idea che la parola debba trasmettere la cosa senza orpelli, senza decorazioni, spogliandola e arrivando a un’estrema sobrietà del dire”.
Eppure quali risonanze hanno i suoi versi, come un violino nel silenzio, quanto lavoro sulla scrittura per denudare il dolore.
Ci sono due testi che si rispecchiano: l’attesa ostinata (della felicità? dell’amore?) sempre raggelata dalla negazione e sempre pronta a rifiorire, forse si risolverebbe negando il desiderio, smettendo di attendere (è un azzardo sentire in questi versi un’eco di Pavese?): “Anche tu,/ volevo chiederti,/ hai rotto l’attesa/ negando il desiderio?// Eppure, questo,/ non può essere destino…” (giugno ‘54); più arresi i versi di pagina 51: “C’è chi sente dolore / per ciò che non avverrà mai”.

Dal libro:
Inverno
Erano sere di poca luna.
A troppe cose si doveva credere.
Cadevano fiori bianchi
– forse –
ad un petalo solo.
(Chi ha taciuto, per un’ansia,
ha udito il silenzio soffocare.)
Le parole non potevano altro
che morire. Inutile pregare gli assenti.
(febbraio ‘54)
*
Fra poco
Un sole
e tanti voli neri,
ma fra poco
la neve cadrà.
Vedo sempre,
nelle pause,
il mio desiderio:
perché non sono io
questi canti,
questo giallo,
questa pace bianca?
gennaio ‘55
*
Sogno vivo
Quando guardo
e m’incanto.
Quando ascolto
e mi esalto.
Quando soffro
e m’avvicino.
Quando è Bello
e m’inginocchio.
Quando l’amore
fa saette
attorno a me.
febbraio ‘56
*
Presente o assente
Presente o assente
La nostra sofferenza
È qualcosa di intatto
Per sempre.
Mai consumata
Fino al suo esaurirsi
Non arriva nuova
Ma semplicemente tornando
Come una stagione
Torna a compiere
I suoi atti naturali
Nociva e violenta
Per una cosa tenera
Quale la nostra debolezza
La sofferenza ci assorbe.
‘61

L’autrice:
Piera Oppezzo è nata a Torino il 2 agosto 1934, ed è vissuta a Milano dal 1966 fino alla morte nel 2009. Proveniente da un ambiente famigliare popolare, è stata aiuto sarta, commessa ai grandi magazzini, dattilografa in Rai e collaboratrice editoriale (Einaudi, Rai, Feltrinelli, Guanda, SE).
Militante extraparlamentare negli anni ‘60, ha partecipato a un gruppo di autocoscienza femminista.
Dopo alcune coabitazioni, è andata a vivere da sola in un appartamento della storica casa occupata di via Morigi 8 e negli ultimi due anni in una “casa protetta” del Comune in corso Lodi.
È morta in solitudine il 19 dicembre 2009 all’eremo di Miazzina sul lago Maggiore, in seguito a un incidente domestico aggravato da una profonda depressione.
(Piera Oppezzo “Esercizi d’addio. Poesie inedite 1952-1965” pp. 124 pagine, 12 euro, Interno Poesia 2021)
Immagini ——————————-
Senza paura
Otto fotografie
di Alessia Ambrosini

Voce d’autore ————————–
Un volto vero da abitare
Adalgisa Zanotto, “Ho da dirti un segreto”
di Salvatore Cutrupi

Molti poeti da sempre scrivono poesie d’amore, ma non tutti riescono a suscitare emozioni in chi legge. Tante volte nelle loro liriche vengono rappresentati momenti e situazioni che il poeta non ha vissuto in prima persona, e quindi non hanno la potenza espressiva che sorprende e coinvolge il lettore.
Questo non accade nelle poesie del libro “Ho da dirti in segreto” di Adalgisa Zanotto, perché lei scrive di un amore veramente vissuto, di un amore dato e ricevuto e lo esprime senza clamori, senza retorica, con uno stile dimesso ma nello stesso tempo immediato e aderente alla vita.
L’amore permea tutta la sua raccolta poetica, e lei non si ferma a fare un bilancio tra quello dato e quello ricevuto, perché sa che ognuno offre solo ciò che possiede o è capace di dare.
Il suo non è un amore circoscritto soltanto alla dimensione famigliare ma ha un respiro più ampio, e vuole essere anche un invito alla solidarietà, alla fratellanza, al prendersi cura dell’altro.
Una delle caratteristiche delle sue poesie è quella di non avere un titolo, come se volesse farle scorrere libere e lasciare quindi che ciascuno, senza il condizionamento iniziale, possa immedesimarsi nella “storia” che, di volta in volta, viene raccontata.
Un altro particolare insito nelle liriche è la quasi totale mancanza di punteggiatura, che tuttavia non impoverisce né indebolisce la forza descrittiva del libro, perché i versi mantengono un ritmo fluido e hanno le pause giuste, così che ogni lettore può scandirne il tempo.
È come se l’autrice, non mettendo la punteggiatura, volesse dare una continuità al suo pensiero, offrire un susseguirsi di situazioni e immagini che è opportuno non interrompere.
Il desiderio che si ha dopo aver letto il libro della Zanotto è quello di volerlo rileggere subito, di tornare ai suoi testi con lo stesso atteggiamento che adottiamo quando ci avviciniamo ad un dipinto, con il piacere di coglierne tutti i colori, per apprezzarne le diverse sfumature e aggiungere immagini nuove ai nostri buoni pensieri.

Dal libro:
diversamente non ti amerei
non starei con te
dal primo ascolto del mio dire
non saprei quanto ami
la mia non luce
non sarei così indifesa
davanti agli occhi del mattino
non conoscerei la sera
e la gioia – la gioia veramente
non incontrerei il sapore di primavera
perché era di quel profumo
il giorno che ci incontrammo
in tutti i giorni dell’incontro
*
le infinite volte che vengo a cercare
la mia forza fragile
sulla più piccola parte del tuo viso
raccolgo la sorpresa
del respiro
e resto là
con la testa sulla spalla e chiudo gli occhi
poi li apro ancora
senza desiderio di andarmene
*
così innamorato rimani contagioso
ti sento come fuoco, ora una spada,
poi un calice
un parto complice
viene da dentro una cosa mite
bisogna dirla quella mandorla
colorata e feconda
certo una meraviglia
un solo verso
un volo breve dentro un fiordaliso
ti amo
*
lode a te vita che da un arco insonne
hai scoccato di nascosto
tre frecce rosso prediletto
_calde dell’estate
e dei suoi fiori_ lode a te vita
che ci fai gustare
la bellezza delle impronte
lasciate senza polvere
immensamente piccole
una misura che ha dentro le vertigini
•
m’insegni il confine aperto
la fatica feconda di essere nomade
veramente libera di andare
di entrare e di stare dentro
mi chiami bambina mia
mai possessivo l’aggettivo
identifica il tuo sguardo
accogliente e disarmato
quando entro e quando esco
eppure qui la nostalgia

Intervista ad Adalgisa Zanotto
Qual è il motivo che ti ha spinto a raccontare il tuo “segreto”?
Il movimento dell’amore che abita i giorni, a cominciare dalle relazioni quotidiane, dalle cose piccole, dai gesti impercettibili, dalla meraviglia dei germogli, dalle ferite e dai limiti. Tutte feritoie attraverso le quali passa la luce forte dell’amore.
I movimenti dell’amore non possono restare nascosti, segreti, hanno bisogno di uscire, di andare verso…, di scrosciare, di irradiare!
Se desidero amore, io posso essere l’amore che cerco! E l’amore non si stanca mai di raccontarsi e di educarmi.
Ho solo provato a raccogliere dei frammenti di bene che riguardano tutti.
In alcuni versi emerge la realtà della sofferenza, del disagio….
Nella mia esperienza vivo la realtà del “limite”. Questo può sembrare/diventare un freno nella relazione. Davanti al dolore, al disagio possono farsi strada la paura, lo scoraggiamento, fino a preferire il buio. Così ci nascondiamo.
Solo l’amore ci sgama, ci snida, ci spoglia e chiede nudità.
La vita così come si presenta, ora bene ora meno bene, diventa buona palestra per allenarsi nell’amore capace di fare cose tutte nuove.
Nella sofferenza del “mio” Beppe ho scoperto un evento da vivere attivamente, un’occasione preziosa per amare concretamente e per ricevere tutto quel bene senza misura che desidero.
Ho conosciuto un elemento fondamentale della nostra umanità: la fragilità, mia e quella degli altri. E questo ha aperto nuovi spazi per accogliere noi stessi così, accogliere la bellezza che siamo.
Da anni ti dedichi alla poesia e anche alla prosa. Come vivi il tuo rapporto con la scrittura?
Non ho ancora conosciuto le ragioni per cui scrivo. Certamente la scrittura mi tiene sveglia di fronte alla vita, tende le mie forze come un arco. Mi aiuta a pagare il prezzo della pazienza, a coltivare l’umiltà.
Sono grata alla scrittura perché mi fa cominciare sempre da capo, non mi fa restare ferma, mi sprona a cercare altri passi tra i capillari della vita e il cammino apre cammino.
Mi dispiace di poter scrivere poco, ma sono felice di quel poco che sempre mi riempie.
Gusto innanzitutto le parole vive che abitano le conversazioni quotidiane, che a differenza dei discorsi, dei trattati, delle teorie, le parole sono corpo. Sento la passione per le nostre parole vive, abitate, tenaci, resilienti. Parole di carne e di sole.
Le tue poesie non hanno il titolo. Ha un significato particolare questa tua scelta?
Sento che mettere un titolo ad una poesia significa individuare una pista “obbligata” per chi la incontra. Desidero lasciare ampia libertà a chi legge, permettendo di “ritrovarsi” nel ritmo e nel respiro dei propri sentimenti, mosso dalle proprie esperienze e sensibilità.
Spesso ascoltando il riscontro/emozione/critica di chi ha conosciuto qualche mia poesia, scopro con gioia e stupore sensi/significati/stimoli nuovi nei miei versi.
Il titolo del libro “Ho da dirti in segreto” potrebbe essere il titolo di ogni poesia della raccolta stessa.
In questo difficile momento, caratterizzato da lunghi periodi di lockdown, quale spazio per la poesia?
Questo è il tempo della poesia! Non senti, la poesia sta chiamando da molte direzioni…
Tra mille difficoltà, in questo periodo possiamo sperimentare il valore dei volti. Qui sta un segreto! La poesia è negli occhi che incontriamo, negli sguardi, nei silenzi.
Anche la nostra Terra è fragile e forte, è bisognosa di cure e ci dona attenzione. Un altro segreto! La poesia è nel creato, in ogni creatura.
Un’economia diversa, una città che fa vivere e non uccide, include e non esclude, umanizza e non disumanizza. Altro segreto! La poesia vive nelle nostre case, percorre le nostre strade.
La poesia non si ritira, non aspetta tempi migliori. La poesia ci circonda, vive nel quotidiano, sia che parliamo di lei, sia che non facciamo direttamente il suo nome, come un parto lei viene alla luce.

L’autrice
Adalgisa Zanotto vive a Marostica (VI). Suoi racconti e poesie sono inseriti in diverse opere nate dalle kermesse di Fara Editore.
Ha pubblicato nel 2015 il racconto “Rapida.mente” e nel 2016 la raccolta di racconti “Celestina” che, giunta seconda al concorso Versi con-giurati, ha ricevuto la pubblicazione premio di “Sussurri e respiri” (Faraeditore 2017).
Nel 2018 ha pubblicato l’opera poetica “D’ora in poi” (Menzione d’onore al Premio Montano 2018 e Menzione di merito al Premio Di Liegro 2019). È presente in molte antologie.
(Adalgisa Zanotto ”Ho da dirti in segreto”, pp.87, 10 euro, Fara Editore 2020)
Ti racconto ————————–
“La manutenzione dei sensi”, “Passaggi segreti”
Franco Faggiani, Federico Pace
di Luca Buiat

Un incontro casuale, Leonardo vedovo cinquantenne e Martino, un ragazzo taciturno e instabile.
Ma ci sono nuove vite in arrivo: nell’aria pulita c’è un bosco e gli orizzonti disegnati dai profili delle montagne dove le nuvole vanno a grattarsi la pancia nelle cime più alte.
E c’è una malga restaurata con una scrivania antica, composta da parti che avevano protetto uomini, animali e sentimenti. Un “rifugio” dove scrivere e imparare mentre fuori è tutto sfumato nel silenzio.
Fatica, aria e paesaggio in vagabondi necessari per registrare l’ambiente, perché la felicità è semplicemente una salita ripida con un panorama nuovo, questo ora è il presente di Leonardo e Martino.
Un centimetro alla volta come lumache in esplorazione, per osservare un fiocco di neve, la testimonianza più forte ma anche la più mortale della natura, il tempo di arrivare a terra, la sua forma perfetta e unica, perché diversa da quella di qualsiasi altro fiocco di neve che sta cadendo accanto è già distrutta, perciò devi apprezzarlo nel brevissimo tempo che esiste.
Guardano fuori dalla finestra, i larici infiammati dagli ultimi raggi al tramonto, Leonardo e Martino ogni tanto si incontrano, diventano due alianti sostenuti da calde correnti.
Leonardo nei vuoti in cui si ritrova a galleggiare pensando a Chiara, Martino è immerso nei pensieri carsici dove l’Asperger è un pianeta lontano e muto.

È un graffio quello che incide Federico Pace lungo il fluire del tempo, un invito nell’andare a cercare in ognuno di noi un accesso nell’altro.
Cercando qualcosa che non si è ancora scoperto, un passaggio che non abbiamo ancora aperto, un orlo di luce sui bordi di un paesaggio primitivo.
Federico accarezza la corteccia di un albero, e ne osserva i tratti per sentirne la forma, accosta l’orecchio per percepirne la risonanza di una corda vibrante, ascolta un boscoso vociare tra il vento e le foglie.
Guarda sulla linea dell’acqua, il mistero della luce al crepuscolo, tra i mondi di sotto e di sopra.
Attraversa a piedi, una vena scavata in profondità dove assaggia il sangue, misto alla cenere nel centro della terra, il verde illuminato dal giorno ed il suo scomparire.
Immagina, la misura di una preda sotto i denti di una scogliera bianca calcarea, generatrice di percorsi invisibili e sotterranei. L’eterna erosione, creatrice di sculture naturali immense, di terra asciutta e polle di sale cristallizzate solitarie al sole.
Percorre una creuza che sale lungo la frattura delle falesie, nel precipitare della terra al mare, nella sete della pietra mentre l’onda sottrae e aggiunge, scompare e resta perché il mare cerca sempre qualcosa, spazzando via le rive dando l’idea di non averne mai abbastanza.
Sente il sussurro di un sasso raccolto, in una stanza piena di vento dove mulina un dialogo silenzioso di anime raccolte attorno ad un tavolo nudo, dove riempie l’oceano di un giorno d’estate.
(Franco Faggiani “La manutenzione dei sensi” pp. 250, 16 euro, Fazi editori 2018)
(Federico Pace “Passaggi segreti” pp. 176, 15 euro, Laterza 2020)
Immagini ——————————-
Senza titolo
Otto fotografie
di Alessia Ambrosini

Intervista ad Alessia Ambrosini:
di Giovanni Fierro
Questa selezione di tue immagini ha il corpo come principale protagonista. Cosa significa lavorare con la sua figura? C’è un qualcosa di specifico che anticipa, e che ne dà il senso, alla sua presenza in queste foto?
Non ho mai amato essere ritratta o ritrarmi nelle fotografie; mi sentivo a disagio nelle pose, ma anche negli scatti rubati.
Nell’ultimo periodo qualcosa è cambiato, il soggetto sul quale si focalizzano più spesso le mie immagini sono io, è vero, il mio corpo. Negli ultimi anni, in maniera naturale, ho sentito il richiamo di un insistente bisogno di “vedermi”.
Il senso di queste immagini è proprio la necessità di guardarmi, senza soffermarmi all’aspetto esteriore, ma assecondando il desiderio di lasciare che lo sguardo passi attraverso la pelle per incontrare i pensieri e la coscienza.
Fotografandomi raggiungo uno stato di confidenza e comprensione sempre maggiori, con la conseguenza che questo bisogno non si esaurirà, perché c’è sempre qualcosa che resta in disparte dentro di noi e che invece dobbiamo avere cura di illuminare.
In alcune immagini (penso a ‘Senza titolo’, versione ‘tuffatrice’..) c’è una ricerca di movimento. A volte più marcata, altre più impercettibile. Cosa c’è alla base di questa scelta?
Alla base della ricerca del movimento, in queste immagini c’è l’idea di un cambiamento, del lasciarsi andare a una sorta di rinnovamento.
Nella tuffatrice di “Senza Paura” c’è un’idea di fluidità insieme a un capovolgimento, c’è la volontà di esprimere la sensazione che qualcosa sta cambiando. C’è la consapevolezza di questa rivoluzione, perché il tuffo è un’azione voluta e non accidentale.
Il caso, invece, in cui il movimento si avverte in maniera impercettibile dipende da una scelta estetica; come nella foto “Senza Titolo” nella quale il soggetto è fermo e la sensazione del movimento è appena percepito con l’effetto aggiunto in post produzione.
È un’immagine volutamente frivola e giocosa, perché c’è un momento fondamentale per l’introspezione, ma non possono e non devono mancare mai le occasioni di leggerezza e di gioco…guai!
Anche perché, in questi movimenti, mi sembra ci sia anche un lavoro sul tempo, sul suo spostarsi ad attimi, con minimi cambiamenti…. quasi come se con questi ‘frame’ lo si possa misurare….
Qualsiasi messaggio si intenda lanciare con una fotografia, questa ha in sé il concetto onnipresente del tempo, materia che non vediamo ma che nelle immagini possiamo cogliere, con il passare da un istante all’altro, che cambia e ci fa percepire il tempo che passa.
Sì, posso dire che ci sia nelle mie immagini un lavoro sul tempo che mai, come in quest’ultimo sciagurato e surreale anno trascorso, mi è caro; perché conduce al tema principale di queste mie visioni che è il cambiamento: il mio.
I colori, mi sembra, non sono mai invadenti, ma sempre funzionali alla figura, al momento colto. Vivono, mi viene da dire, di trasparenza più che di forza espressiva. Può essere così?
Certo, è esattamente così. La mia idea era che non fosse il colore a richiamare l’attenzione e che non fosse lo stesso a guidare nella lettura.
C’è una sorta di trasparenza che esprime la volontà di non voler nascondere, ma di guardare attraverso.
Amo il colore, spesso è il soggetto in molte mie fotografie, cattura lo sguardo immediatamente acquistando forza espressiva.
Qui ha la funzione di accompagnare lo stato d’animo del soggetto e il suo movimento, generando l’illusione del sogno e la sensazione del lasciarsi andare.
Ho provato a pensare a quali parole, i soggetti qui protagonisti, possano pronunciare. Ma l’impressione è che siano immersi nei loro pensieri, in un silenzio nel quale stare… ma se è così, che silenzio è? E sennò, hanno desiderio di trovare le parole?
Esattamente, sono felice che abbia colto lo stato dei soggetti, il loro voler stare “dentro” il silenzio.
I protagonisti sono a colloquio silenzioso con uno stato di inquietudine nel quale si crogiolano, nel quale io amo a volte crogiolarmi, in un momento intimo in cui riescono a leggere i pensieri, a trovare il loro posto. Considero il silenzio un dono e allo stesso tempo un luogo dal valore immenso, dove posso finalmente sentire quello che mi è sfuggito per tanto tempo: me stessa. Qui mi regalo un intervallo dal caos e mi metto all’ascolto.
E, comunque, la sensazione è che tutte queste immagini siano, ognuna nella propria particolarità ed appartenenza, la narrazione di una attesa…
Tutte queste immagini sono ognuna nella sua particolare dimensione sensoriale, in un’atmosfera che mi piace definire sospesa e quindi di attesa.
Sono la narrazione dell’attesa di un segnale, di un richiamo che la coscienza invia da tempo e che deve essere riconosciuto e ascoltato.
Come sono state realizzate queste fotografie?
Sono immagini che ho scattato con una reflex Canon e con una ‘mirror less full frame Sony’. Per alcune immagini ho usato l’effetto mosso dei tempi lenti, insieme al disturbo creato con photoshop.
In “Veins”, nel paesaggio, ho usato gelatine colorate. Non amo tecniche particolari, mi lascio trasportare dall’istinto.

L’artista:
Alessia Ambrosini è nata a Taranto da genitori romani, oggi vive nella Franciacorta, tra Bergamo e Brescia. Ha frequentato gli Studi Classici e la facoltà di Giurisprudenza, e la sua curiosità e passione per la fotografia l’ha portata a fare altre scelte e incontri, il più segnante con Franco Fontana, suo Maestro e soprattutto un amico raro.
Ha cominciato da autodidatta, guardando set fotografici per riviste di moda, si è dedicata alla fotografia sportiva, che le ha insegnato ad essere veloce nei gesti e nello sguardo.
In seguito è entrata a far parte di “Quelli di Fontana“.
Seguendo l’istinto si è dedicata a progetti più intimi, che ha presentato in alcune mostre collettive e personali e pubblicati su riviste fotografiche.
rivista Fare Voci
curata da Giovanni Fierro
collaboratori:
Roberto Lamantea, Salvatore Cutrupi, Ilaria Battista, Livio Caruso.
ospiti:
Sandro Pecchiari, Luca Buiat.



