
La nuova stagione autunnale di Fare Voci si apre con una delle più importanti voci della poesia italiana, Stefano Dal Bianco.
Con la recente vittoria del Premio Strega Poesia 2024, con il suo “Paradiso”, segna un nuovo e rinnovato momento del suo scrivere, raccontato nell’intervista che ci ha concesso e che vi proponiamo.
La poesia italiana è anche l’autorevole firma di Antonio Prete, con i suoi due volumi “Convito delle stagioni” e “Del silenzio”. L’intervista a lui dedicata è l’occasione per addentrarsi in una dimensione poetica, e non solo, tutta da scoprire.
Importante anche l’attenzione per lo scrivere proveniente dal mondo internazionale: in prima traduzione italiana ospitiamo l’australiana Lisa Gorton e la spagnola Isabel Hualde. Oltre a conoscere l’autrice greca Iulita Iliopulu, con la sua raccolta “Il mosaico della notte”.
E poi Niccolò Nisivoccia con il suo “Un dialogo notturno” e Stefania Licciardello con “Il Libro della Gloria”.
Il tempo presente è quello di Elena Cerkvenič, “Sono schizofrenica e amo la mia follia”.
Le immagini sono quelle del progetto “The Journey” ideato e curato da Enzo Comin. Ed è l’occasione per proporre e presentare l’arte di sei artisti ucraini: Sergey Dobrynov, Alla Volobyeva, Petro Hrytsiuk, Oleksiy Dinnyk, Maria Drozdova, Mikhail Ray e Stanislav Zhalobniuk.
Buona lettura
Giovanni Fierro
(la nostra mail è farevoci@gmail.com)
Immagini ———————–
Once summer evening
The Journey
di Dynny Oleksij

Voce d’autore —————————
E lo restituisce al vento, e a chi resta
Stefano Dal Bianco, “Paradiso”
di Giovanni Fierro

“Paradiso” di Stefano Dal Bianco è un libro destinato a rimanere. E non di certo solo perché fresco vincitore del Premio strega Poesia 2024, ma perché è l’occasione di una profonda riflessione sul nostro tempo contemporaneo, quello di ogni giorno.
E questa riflessione prende vita da un gesto semplice ed universale: entrare camminando in un bosco.
È dentro la natura che tutto “Paradiso” fiorisce, di dubbi e di domande. Di epifanie che si accettano e che si vivono. Di percezioni che si trasformano, trovando nuovo respiro e verità.
Scritto nei giorni della pandemia, “Paradiso” è sostare in una attesa “dove ci porta questa festa di passioni,/ dove ci fa sostare veramente l’immobilità”. Ed è il momento preciso per costruire la possibilità di misurare il proprio stare al mondo, con il creare/ricreare una realtà, dove riconoscere il proprio spazio, il proprio diritto a vivere. Con la chiare sensazione che tutto sia da decifrare di nuovo, da capo: “Ma non è l’indistinto a corteggiarmi, qui,/ è il suo profumo, appunto,/ che respirando entra/ e intacca ogni memoria,/ la sfalda la ricostruisce/ la restituisce a sé mentre svanisce”.
Ogni pagina del libro svela un raccoglimento, una intimità che scopre la dimensione spirituale, nell’indicare che “chi si muove è come fosse spento/ e chi è fermo fonda un alfabeto/ di buio e lampi, brevi nel silenzio”.
La radice profonda di tutto il libro è anche e proprio il silenzio, occasione di luogo da scoprire e dimensione esistenziale da esplorare, dove “si finisce con l’andare molto lenti/ perché lento è il respiro che fa crescere l’erba”.
Così anche la lentezza diventa valore da contrapporre all’accelerazione della società contemporanea, svilente nel suo chiedere, o meglio imporre, tempi sempre più brevi all’esistenza umana, dove emozioni e pensieri ne escono così stritolati e privi di ogni profondità.
Perché solo con tempo che trova la sua giusta durata, l’uomo può coltivare il suo sguardo, nutrimento essenziale per lo stare al mondo, per accorgersi che “l’occhio dopo giorni di pioggia e di grigiore/ è affamato/ e non ha paura più di niente:/ a ferirlo è quella stessa luce/ che lo apre all’invisibile del mondo”.
Ecco, la luce, che nello scrivere di Stefano Dal Bianco è pulsione vitale, apertura all’invisibile, esperienza dove trovarsi, “eppure sofferenti e fiduciosi/ che venisse, venisse per noi/ quella luce che non ci fa dormire”.
Tutto “Paradiso” è un camminare e fermarsi, accorgersi di uno sguardo appropriato, sostare nel momento più adatto al sé, creare il luogo dell’accadimento. E sempre in compagnia del fidato ed amato cane Tito: “Ora stiamo seguendo un canaletto secco per l’irrigazione/ e Tito fa una certa invidia/ perché il suo occhio è all’altezza dell’erba/ e non è costretto a dominare niente/ mentre il suo amico si fa serio/ dall’alto della sua incostante umanità”.
Accettare l’esistenza è renderla unica, gesto primordiale e mai scontato, a cui dare una voce che è anche il costruire la propria identità. Parole da pronunciare e parole da scrivere, e “delle volte nel bosco è obbligatorio/ pensare alla scrittura e dunque immedesimarsi/ in una voce non tua/ che su di te decide di sostare”; il confronto da cui non togliersi, punto di svolta della propria coscienza.
“Paradiso” è questo manifestarsi della vita, tra terra e cielo, in una adesso che si ricompone, assieme all’aria che riempie i polmoni.
E Stefano Dal Bianco nell’intervista che più sotto segue ce lo racconta in ogni minimo dettaglio.
“Perché ogni primavera è assoluta/ e non si lascia adulterare da reminiscenze”.

Dal libro:
Appuntamento al buio
Che cosa sarà mai questo aspettare la sera
con voluttà, questa stanchezza della luce
e delle forme del pensiero:
ricollegarsi a cosa, a chi?
Costituirsi al buio, compromettersi
in un appartamento incerto con se stessi,
comunque senza rete, la coscienza
di ciò a cui si può soltanto alludere,
il coraggio di voler conoscere,
di accogliere altro che non sia
un fatto di legami e di passioni,
che sia pericolosamente qui
e nel contempo totalmente alieno,
fatto di materialità, fatto di sangue,
fatto non di cronaca mondana
e però fatto di tempo intercorso
fra il tramonto di un sole
e l’alba di una stella più sottile.
*
Sono venuto nell’aria ferma
senza farmi illusioni di pace o di guerra
perché ciò che l’aria ferma raccomanda
è soltanto questa notte uno stare
a sentire il silenzio dei prati,
che non sarà il nostro canto per intero
ma è da lì che assieme a noi
vengono le notti, con l’abbaiare dei cani.
*
È difficile stabilire un confine
tra quello che si vede – una pianura
un palo della luce una macchia di bosco –
e quello che si immagina
o che ritorna dopo lunga
frequentazione identico com’era
alla mente passiva,
ma sarà nebbia, nube o fumo di camino
quello che sale dalla valle risolvendosi
in una vaga profezia di luce e vista
in nuce e ridondanza fosca di
sconfinamenti
da visione a visione
nel ricordo o nell’immaginazione?
*
Devo qui ringraziare
quella coppia di daini sulla strada
che mi ha dato una scossa
di paura imprevista
e che non è scappata presto
permettendo alla scossa di durare,
di lasciarsi toccare
dall’anima del mondo
per un lungo momento sulla strada.
*
Sotto le foglie secche cresce l’erba
e le solleva di quel tanto
che basta a farle star sospese,
loro nel loro inverno che diviene un limbo
lei che rinasce a ogni primavera
ultima prova del grande disegno
che tiene conto di tutto ciò che muore
e lo restituisce al vento, e a chi resta.

Intervista a Stefano Dal Bianco:
Mi sembra che tutto “Paradiso” sia un misurare il proprio stare al mondo, il creare/ricreare una realtà possibile, dove riconoscere il proprio spazio, il proprio diritto a vivere. E nella natura in cui sono immerse queste pagine c’è la possibilità che tutto sia da decifrare di nuovo, da capo…
Questo è un bel modo per avvicinarsi al libro. “Paradiso” è nato durante il lock-down da pandemia, in una situazione, per me, di assoluto privilegio. Nel borgo delle colline senesi dove abito siamo una trentina di abitanti, e in pandemia la carenza di umanità intorno si è ulteriormente acutizzata, assieme al prendere piede, come altrove ma più che altrove, di una natura “inferocita e onnisciente”, come la definisco in un verso. Il contatto e il confronto con la natura possono essere importanti per una definizione di sé, un aiuto a circoscrivere la propria interiorità, ma questi effetti non sono automatici: è chiaro che bisogna aver coltivato in sé una dimensione di ascolto. La natura ci parla sempre, è sempre lì a mandarci messaggi. Ma noi abbiamo sempre troppe cose per la testa, e così normalmente ci neghiamo la facoltà di ascolto…
È difficile parlare di questa sorta di incremento di interiorità che si sperimenta in quei rari momenti di grazia, ma la poesia cerca di farlo: è un qualcosa che passa per la lingua, è il riuscire a trasmettere un messaggio per una via che di certo è linguistica, ma sapendo che c’è qualcos’altro sotto, che va oltre l’aspetto puramente comunicativo della lingua stessa. Le lingue naturali, tutte le lingue naturali, conservano in sé la storia dell’umanità, ma c’è di più: nelle religioni orientali la lingua è Dio, e così è nel vangelo di Giovanni, anche se la cultura occidentale sembra essersene dimenticata: “In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio”. Dalla nostra condizione odierna ci sembra impossibile comprendere, penetrare nel senso profondo di questa affermazione, ma credo sia giusto continuare a sbatterci la testa contro; credo che questo sia uno dei compiti della poesia.
“Paradiso” è quindi anche questo raccoglimento, una intimità che scopre la dimensione spirituale, che vi si immerge, che vi si incammina….
Si può dire così, ma in Paradiso non c’è alcuna volontà di meditazione separata dall’esperienza. Credo ci sia l’umiltà dell’ascolto e al tempo stesso una grande presunzione, cioè la fiducia nello stato di grazia che si è coltivato interiormente, nel silenzio che ti sei guadagnato dentro, che poi è la condizione dell’ascolto. È grazie a questa fiducia che la meditazione, se c’è, scaturisce dalla pura descrizione, in modo del tutto naturale, non cercato, non voluto. Come dire che esce direttamente dalla lingua, niente di volontaristico, niente di ‘pensato’.
E qual è la scrittura che ha dato vita a questi testi?
Per scrivere è necessario mantenersi proiettati alla scrittura. Una delle mie ossessioni è sempre stata la non coincidenza del momento dell’esistenza con il momento della scrittura. Nel mio libro del 2001, “Ritorno a Planaval”, c’è una poesia che tematizza questa faccenda: l’esperienza vissuta in una passeggiata, l’epifania dell’incontro con un platano, perde di vitalità e di realtà perché non ho con me carta e penna, e insomma, per scriverne sono costretto a rientrare in casa, perdendo la presa diretta sull’evento.
È questo uno dei motivi per cui scrivo poco: per lunghi periodi mi dà fastidio l’essere proiettato alla scrittura, come dire che preferisco vivere e basta, senza filtri.
La maggior parte delle poesie di “Paradiso” è nata in modo diverso: ho scoperto l’uso del registratore nel cellulare; potevo dettare i versi, a uno a uno, in presa diretta, dal bosco, dai prati, con i piedi nell’acqua del fiume. Nessuna distanza tra l’esperienza e la parola. Il fatto di dover rimuginare ogni singolo verso più volte mentalmente prima di dettarlo in attesa del successivo ha richiamato liberamente una sorta di ron-ron endecasillabico, che fa da sottofondo costante, in dialogo con Petrarca, Ariosto e tutta la tradizione del Novecento.
La voce, non passando per la penna, ha spontaneamente aderito al canone, e vorrei dire all’essenza della lingua, più che della tradizione. Quella perfetta oralità si ritrovava a fondere la voce della tradizione italiana con la voce della natura. È difficile da spiegare, ma nella natura si avverte bene la compresenza di tempi diversi: si è nel presente, e contemporaneamente si sente lì, altrettanto presente, il respiro del passato e del futuro.
Ecco, l’immersione completa nella natura: non lo stupore di cose nuove, ma la conferma di cose primitive, di cui siamo fatti, che ancora dobbiamo conoscere…
Sì, per questo è importante il rapporto che instauriamo con i luoghi. Un luogo non ti parla fino a che non ne hai preso pieno possesso, che vuol dire dopo anni di frequentazione abituale. È la situazione degli ultimi decenni di vita di Friedrich Hölderlin, che Giorgio Agamben ha descritto magistralmente nel suo recente “La follia di Hölderlin“, ma è anche la situazione di Andrea Zanzotto, che non scriveva una riga fuori dalla sua Pieve di Soligo. È l’abitudine che rende sacri i luoghi.
In “Paradiso” è molto importante la presenza del profumo. Un qualcosa che c’è ma che non ha corpo, una presenza forte ma che è anche assenza…
Non lo so questo cosa voglia dire, certo l’olfatto c’è ma non si vede… Ma è forse perché andiamo tutti verso un profumo, che non sappiamo dov’è, ma conosciamo il fatto che ci sia. È possibile che la convivenza con il cane Tito, co-autore più che personaggio di questo libro, abbia dato i suoi frutti. In lui l’olfatto prevaleva sulla vista. L’attenzione costante a queste differenze tra le specie è molto istruttiva. In “Paradiso” tutto è in parte vissuto cercando di entrare nella mente di un cane.

Ecco, la presenza di Tito…
Non sono mai stato il suo padrone: spesso comandava lui. Parecchie volte, quando nel libro si trova un noi, si intende proprio “io e Tito”, ma non c’è alcuna umanizzazione, come non c’è alcuna forma di affettività esplicita. L’animale fa l’animale, svolge il suo ruolo di tramite fra uomo e natura.
Le parole del libro lambiscono il silenzio, gli passano accanto, gli fanno compagnia. Ma che silenzio è?
Non serve a niente nominare il silenzio. Il silenzio detto non è silenzio. La lirica è quel genere di poesia che cerca di produrre da sé i propri silenzi. È un’idea a me cara da tanto tempo, quella per cui sia possibile determinare il valore della poesia lirica (almeno di quella novecentesca europea e contemporanea) dalla quantità di silenzio che essa veicola in sé. È anche possibile che vi sia stata una evoluzione, diciamo dopo Auschwitz, nei modi di veicolare questo silenzio.
Per esempio, quando Ungaretti scrive “Ho popolato di nomi il silenzio” può voler dire soltanto che il silenzio sta al di fuori dei nomi, cioè nello spazio bianco tra una parola e l’altra, tra un verso e l’altro. Con Paul Celan e con Andrea Zanzotto (ma forse già prima con Rilke) il silenzio non è più tra le parole ma dentro. Questo silenzio inerente all’espressione ha molti modi per manifestarsi, ma forse il principale ha a che fare con il trattamento dei suoni vocalici, delle vocali nel verso.
Più è faticosa la pronuncia di certi incontri vocalici, più il verso è rallentato, e più silenzio si respira. Parlo e scrivo di queste cose da trent’anni e non mi posso dilungare. Ma questa è una delle chiavi d’accesso, forse la principale, alla lingua di “Paradiso”.
Il bosco, certo, ma anche il cielo è molto presente in queste liriche. Ma non è mai lontano, né inarrivabile. E non è neanche uno specchio in cui cercarsi. Fa parte del tutto, nel modo più naturale. E lo dice la corrispondenza che esiste tra lucciole e stelle. Una vicinanza, mai lontananza…
È così, la sfera celeste è qualcosa di quotidiano e familiare, fa anch’essa parte del luogo, e con il luogo parla.
In questo suo nuovo scrivere la lentezza ha una grande importanza. Assieme al camminare, allo stare fermi…
“Paradiso” spezza una lancia a favore di una sosta, a tutti i livelli, a partire da quello formale, che prevede una spontanea ricerca di rallentamento nella dizione dei versi. Qui si inserisce perfettamente il discorso sul silenzio vocalico di cui sopra. La sosta è il corrispettivo spaziale/temporale del silenzio. Ma la situazione dello “star fermi”, e in silenzio, è tematizzata ovunque nel libro. Se vogliamo, è una sorta di gesto politico: la fretta è il male del secolo, il mondo corre, ci spinge ad andare sempre più veloci, ma nel correre l’interiorità sparisce.

L’autore:
Stefano Dal Bianco (Padova 1961) vive in provincia di Siena, dove insegna Poetica e Stilistica all’universià. Negli anni Ottanta, con Mario Benedetti e Fernando Marchiori, ha diretto la rivista di poesia contemporanea “Scarto minimo”.
Come studioso e critico militante si è occupato prevalentemente della metrica di Petrarca, Ariosto, Andrea Zanzotto, e di poesia del Novecento. Di Zanzotto ha curato il Meridiano Mondadori nel 1999 (con Gian Mario Villalta) e l’Oscar “Tutte le poesie” (2011).
I suoi libri di poesia sono “La bella mano” (Crocetti 1991), “Stanze del gusto cattivo” (in Primo quaderno italiano, Guerini e associati 1991), “Ritorno a Planaval” (Mondadori 2001 e LietoColle 2018) e “Prove di libertà“(Mondadori 2012).
I suoi saggi di poetica sono raccolti in “Distratti dal silenzio. Diario di poesia contemporanea” (Quodlibet 2019).
(Stefano Dal Bianco “Paradiso” pp. 139, 19 euro, Garzanti 2024)
Immagini ———————–
ЧОРНЕ МОРЕ
The Journey
di Stanislav Zhalobniuk

Tempo presente ———————
Perpetually in the front of light Perennemente di fronte alla luce
Quattro testi inediti in italiano
di Lisa Gorton

Room and Bell IV
In truth, that dreamt-up room has less in common with my
room as it was than it has with those rooms that build themselves
in my mind when I am reading—rooms which, the moment I
pause to examine them, turn out to be made of one or two
furnishings set among struts of light—a notion of depth and
width and height built out of prepositions, out of a speaker’s tone
of voice. Though they are sketched in light, I am conscious of
them not as I would see them but as I would remember the
formation of a room in the dark. My imagination has troubled to
manufacture one detail fully: a blue and white teacup with a
stone fleck in the porcelain an inch from its inside rim. A slightly
tarnished teaspoon in the saucer shows, upside down, the
reflection of a window. These rooms that build themselves in my
mind when I am reading take their effect of truth—which, since
they are not true, is an effect of feeling—from that first room,
which, since it installed itself in me, has stood behind so many
other rooms, concealed itself in so many other places, tricked me
so many times into a feeling of homecoming—which has
travelled so much farther than I have.
Sala e Campana IV
In verità, quella stanza sognata ha meno in comune con la mia
stanza di com’era rispetto a quelle che da sole prendono forma
nella mia mente mentre leggo—stanze che, nel momento in cui mi
soffermo ad esaminarle, mi accorgo essere composte da uno o due
arredi sistemati tra lampi di luce—una nozione di profondità e
larghezza e altezza costruita a partire dalle preposizioni, dal tono di voce
di chi parla. Anche se sono disegnate alla luce, ne sono conscia
non di come potrei vederle ma del come mi potrei ricordare il
formarsi di una stanza al buio. La mia immaginazione è turbata
dal dare forma completa ad un dettaglio: una tazza da tè blu e bianca con
nella porcellana una pietra a forma di macchia a due centimetri e mezzo dal bordo.
Un cucchiaino da tè leggermente ossidato nel piattino mostra, capovolto, il
riflesso di una finestra. Queste stanze che si costruiscono nella mia
mente quando leggo assumono il loro effetto di una verità—che, con il loro
non essere vere, è l’effetto di un sentire—da quella prima stanza,
da quando si è installata in me, è rimasta dietro a tante
altre stanze, nascoste in tanti altri posti, mi ha ingannata
così tante volte in una sensazione di ritorno a casa—ha
viaggiato così tanto più di me e più lontano.

da “Hotel Hyperion”, Giramondo Publishing 2012
*
Empirical I
A factory, the train line curving off
to cross the motorway—between them this
falling away of ground—two or three acres
where for years the council trucks brought
building rubble—mounds of shattered concrete,
brick shards, piping, steel mesh heaped here
where grass succeeds itself and
flowering weeds—and now I walk into the wreckage,
its tricks of scale—broken horizon stone
with head-high fennel, milk-thistle
stark from the mounds, dandelion the colour
of barbed wire self-seeding in wind-shale, in soft
mortar at the level of my eye, its closed array—
and it is the first place, place itself grown
inward to my sight, along the side of the house,
in the playground where dry ground
slants to the fence, out of the history of their names
where these same weeds thrive
which have made for me a heraldry of my forgetting—
tussock rampant in field azure—and set me here
in its abyss giving the bright scenes place—
which is to say I have not seen it yet,
a wilderness to me which is to itself single,
closed in its processes, happening over and
over though not to itself, being to itself a storm
perpetually in the front of light—
Empirico I
Una fabbrica, la linea ferroviaria che curva e
attraversa l’autostrada—e nel bel mezzo questo
rimasuglio di terreno—due o tre acri
dove per anni i camion del Comune hanno portato
i detriti degli edifici—cumuli di cemento frantumato,
schegge di mattoni, tubazioni, reti d’acciaio ammucchiate qui
dove l’erba succede all’erba e
alle erbacce in fioritura—e ora cammino tra le macerie,
i suoi inganni fuori scala—la pietra spezzata dell’orizzonte
con la testa alta di un finocchio, il cardo mariano
nudo dai tumuli, il dente di leone il colore
del filo spinato che si autosemina nella roccia scistosa, in una morbida
malta all’altezza dei miei occhi, la sua chiusa disposizione-
ed è il primo luogo, spazio cresciuto da sé
all’interno della mia vista, lungo il lato della casa,
nel parco giochi dove il terreno asciutto
si inclina verso la recinzione, fuori dalla storia dei loro nomi
dove queste erbacce prosperano
le stesse che del mio dimenticare ne hanno fatto un’araldica—
ciuffo d’erba rampante nel campo azzurro—e mettimi qui
nel suo abisso a dare spazio alle scene luminose—
vuol dire che ancora non l’ho visto,
per me un deserto di per sé unico,
chiuso nei suoi processi, nell’accadere di più e più volte
ma mai accaduto a se stesso, l’essere una tempesta in sé
perennemente di fronte alla luce—

da “Empirical”, Giramondo Publishing 2019
*
House and Home, 1944
On the side verandah Mrs—takes another slice of
letting herself go. Flyscreens make the kindest shade.
They are all gone to history. Paddocks walk about the house.
The house is still in the family. Memory is
small-handed creatures, they unravel shadows down
corridors, in drifting rooms. A neighbour calls at the door.
How politely it comes in, the future—
padding across the boards in soft-soled shoes
till her armchair presides over dunes and swales—
Casa e casa, 1944
Sulla veranda laterale la signora—prende un’altra fetta
del suo lasciarsi andare. Le zanzariere fanno la più gentile delle ombre.
Ognuno è passato alla storia. Recinti tutt’attorno all’edificio.
La casa è ancora di famiglia. La memoria è
creature dalle piccole mani, svelano le ombre
lungo i corridoi, in stanze alla deriva. Un vicino bussa alla porta.
Con quanta gentilezza entra, il futuro—
attraversando da una parte all’altra il pavimento con scarpe dalla suola morbida
fino a quando la sua poltrona non presiederà su dune e valli—

da “Press Release”, Giramondo Publishing 2007
*
Empirical II
From the playing field, stone steps climb
into these acres of rubble where
between the train line and the gully tyre tracks lead away
in among head-high grass—Here where I vanish
into my life again the way a photographer walks off
into his photographs—a vault of light
in which every thing appears
down to its last detail—the smell of fennel, even,
rising where I step over the railway line
and climb the cutting’s side—when with single cries
wrens scatter up out of the grass like the reverse
of something breaking or that idea of place
which persists behind its uses—self-sufficient,
capacious, forever inventing a centre
elsewhere—ground I have seen falling in an instant
from the window of a passing train—
It did happen—It happened once—
Do you see them out there, figures among the stones
and their names for grasses? Out in that
unimaginable field in which wrecked worlds
heap their monuments, an accumulation of fragments
which only here convert themselves into a scene
like pictures on a vase—or is that an urn
in the mounds at their feet where painted Caesar is
gesturing at the curve—‘This victory I call peace
and remember in stone—’
Empirico II
Dal campo di gioco salgono gradini di pietra
dentro questi acri di macerie dove
tra la linea ferroviaria e il burrone le tracce dei pneumatici
portano tra l’erba alta—Qui dove svanisco
nella mia vita di nuovo nello stesso modo con cui un fotografo s’incammina
nelle proprie fotografie—una volta di luce
in cui ogni cosa appare
fino all’ultimo suo dettaglio—l’odore del finocchio, perfino
più intenso nei miei passi sulla linea ferroviaria
e salgo sul materiale di scavo—quando con un singolo grido
gli scriccioli si sparpagliano dall’erba come l’opposto
di un qualcosa che si spezza o di quell’idea di luogo
che persiste dietro all’uso che se ne fa—autosufficiente,
capace, per sempre inventando un centro
da qualche altra parte—terra che ho visto crollare in un istante
dal finestrino di un treno in corsa—
È successo— È successo una volta—
Le vedi là fuori, le figure tra le pietre
con i loro nomi di erbe? Fuori in quell’
inimmaginabile campo dove mondi distrutti
ammucchiano i loro monumenti, un accumularsi di frammenti
che solo qui diventano la scena
come di immagini su di un vaso—o invece è un’urna
nei tumuli ai loro piedi dove un Cesare dipinto
a gesti indica la curva—‘Questa vittoria la chiamo pace
da ricordare nella pietra—‘

da “Empirical”, Giramondo Publishing 2019
(Le traduzioni in italiano dei testi di Lisa Gorton sono a cura di Sandro Pecchiari e Giovanni Fierro)

L’autrice:
Lisa Gorton è nata nel 1972. Australiana, è poetessa, narratrice ed editore letterario.
Ha un dottorato di ricerca sulla poesia di John Donne presso l’Università di Oxford.
È poetessa e scrittrice, saggista e critica. La sua prima raccolta di poesie “Press Release” (2007) ha vinto il Victorian Premier’s Literary Award per la poesia. La sua seconda raccolta “Hotel Hyperion” (20012) è stata premiata con il Philip Hodgins Memorial Medal, e il suo terzo libro “Empirical” (2019) è stato selezionato per il Prime Minister’s and NSW Premier’s Literary Awards for Poetry.
La sua quarta raccolta poetica “Mirabilia” (2023) è stata selezionata per il NSW Premier’s Literary Awards for Poetry.
Il suo secondo romanzo “The Life of houses” (2015), è stato co-vincitore del Prime Minister’s Literary Award for Fiction, nel 2016. È autrice di “Cloudland” (2008), un romanzo per bambini.
Immagini ———————–
Peace
The Journey
di Alla Volobyeva

Voce d’autore ————————
Vi abita, dicono, la poesia
Antonio Prete, “Convito delle stagioni” e “Del silenzio”
di Roberto Lamantea

Il silenzio è tessuto della/nella lingua, scrittura e ascolto/visione della natura; le melodie della luce sono “luoghi” della parola. Antonio Prete insegue quella lingua antica, suoni d’aria, erbe e cieli spesso nella luce della memoria. Ha la sua firma un saggio fondamentale nell’esegesi leopardiana, “Il pensiero poetante”, pubblicato da Feltrinelli nel 1980 (nuova edizione Mimesis 2021) e del poeta di Recanati è oggi il maggiore esegeta. Ma che studi Leopardi o i suoi amati francesi (Jabès, Bonnefoy, Baudelaire…), che rifletta sulla traduzione, che scriva in prosa o in versi Prete ha una cifra stilistica unica.
Nello sguardo sulla natura, il tempo, la lingua – e nel suo tema prediletto, appunto il silenzio – lo studioso e poeta salentino può forse essere accostato – nell’ascolto più che nella scrittura – agli ultimi libri di Chandra Candiani, anche se Prete è meno mistico, è più un musicista, filosofo e filologo della parola. Ed è inattuale, perché scrivere oggi del silenzio implica non solo una grande coerenza di pensiero ma coraggio intellettuale (si sentono già i ronzii beffardi delle avanguardie…). Un opus che riflette su temi come la nostalgia, la lontananza, la compassione.
Per tanti anni docente di Letteratura comparata all’Università di Siena, giramondo ma sempre con il cuore nel suo amato Salento – a cui ha dedicato tra gli altri “Album di un’infanzia nel Salento” (2023) – Antonio Prete è in libreria con il suo ultimo libro einaudiano, “Convito delle stagioni”, che nella “bianca” segue “Tutto è sempre ora” (2019), titolo da un verso di Eliot (dai “Quattro quartetti”), mentre del 2022 è il piccolo prezioso “Del silenzio” edito da Mimesis/Accademia del Silenzio in una meravigliosa collana giunta finora a una cinquantina di titoli.
Partiamo da qui, anche perché, nella scrittura di Prete, poesia, riflessione sulla lingua, esegesi di un testo o di un autore sono la stessa cosa, con una coerenza e unità di visione che attraversa i decenni.
“Del silenzio” è un libro di poesia come le sue raccolte di versi sono testi di poetica. “La forma che raccoglie in unità tutte le modulazioni del visibile è il silenzio. Silenzio delle piante, del canale che scorre nella piana, del cielo. Non coincide con il visibile del paesaggio, questo silenzio. È la sua anima, il suo ritmo. […] Il vento e il volo dell’uccello sono anch’essi nel silenzio, sono figure di quel silenzio. Perché sono, come gli alberi, come l’acqua del torrente, come le nuvole, al di qua della lingua. Della lingua degli uomini. Al di qua, ma anche oltre quella lingua. Sono nella luce di uno stare in cui l’apparire e l’essere si uniscono, e la forma è la natura stessa della cosa. Il silenzio è il legame profondo che unisce in uno stesso respiro l’essere e l’apparire, la forma e la natura. Non lingua del visibile ma, appunto, respiro del visibile”; “La poesia è lingua abitata dal silenzio”: tra i grandi amori di Prete, è facile intuirlo, c’è Hölderlin, che scriveva del “silenzio dei cieli” (ma basta pensare al pentagramma su cui è modulata, per esempio, la poesia di due grandi tragici del Novecento, Trakl e Celan, gli stagni e gli azzurri del poeta di Salisburgo, la cenere dei lager nel poeta della “Sabbia delle urne” e “Microliti”).
Ma la poesia ha radici in un favellare antico, pre-conscio più che inconscio, la lingua della madre, quella che Zanzotto chiama petèl, la lallazione, il canto delle prime sillabe: “La lingua della madre e il silenzio. […] Nella passione del poeta per la lingua – la poesia è amore della lingua – c’è memoria di quei silenzi materni e del loro farsi tappeto per il canto, o per la pura voce: per questo la poesia è lingua intessuta di silenzi. Lingua vocalica e musicale, ‘parlar materno’”. Un suono “libero dalla gravità del significato”.
Che cos’è la lingua materna nella scrittura? “L’incurvarsi di un tono, il farsi vocale del respiro, il timbro di una cadenza, l’indugio su una sillaba, il nesso tra il soffio e la sillaba”: “La ricerca di un’armonia tra il respiro del proprio corpo e il respiro degli alberi”.
Il poeta salentino va più in là (e “più in là” è sintagma zanzottiano): “Il poeta, ‘fabbro del parlar materno’, usa una lingua di vocali. Secondo una medievale etimologia, se auctor viene da auctoritas e designa colui che usa la lingua della legge, autor, riferito al poeta, viene da auieo, che vuol dire lego, raccolgo insieme le cinque vocali. Un verbo fatto di vocali che dice allo stesso tempo la composizione, il canto, l’appartenenza del poeta alla lingua come madre e alla lingua della madre. Il “parlar materno” del poeta è lettura del mondo attraverso una lingua i cui suoni muovono dal silenzio verso il canto, e sono per questo vincolati al ritmo”. È quello che Prete chiama “suonosenso”.
Il libro di Mimesis poi scorre in analisi di testi leopardiani – su tutti “La vita solitaria” – Jabès, la traduzione come ospitalità di un testo in un’altra lingua (alla traduzione Antonio Prete ha dedicato “All’ombra dell’altra lingua. Per una poetica della traduzione”) e conclude con un passo stupendo: se Leopardi ha scritto che la poesia “aggiunge un filo alla tela brevissima della nostra vita”, Prete chiosa: “In quel brevissima il poeta indica il senso della finitudine, indica il tragico: in quell’orizzonte la poesia è un sorriso. Nel tragico della nostra epoca la poesia è un sorriso. Il fiore nel deserto, il profumo nell’aridità, il lampo di una luce – lontanissima, perduta – nelle tenebre”.

“Convito”: il Vocabolario Treccani lo definisce così: “Pranzo sontuoso o solenne di più persone, banchetto”. Come “convivio”, per Dante – annota il vocabolario dell’Enciclopedia Italiana – “quasi banchetto di scienza”. È “Convito delle stagioni” il nuovo libro di versi di Antonio Prete, fresco di stampa da Einaudi, metafora anche delle otto sezioni in cui il libro è tessuto, l’ultima – La lengua, lo ientu (“La lingua, il vento”) – nel dialetto di Copertino, il paese del Salento dove Prete è nato nel 1939. Le altre: Tempo rubato, Per un bestiario, Lezione di tenebre, Quaderno blu marino, Fiori d’aria, mentre il titolo del libro è anche quello della prima parte.
Qui come negli altri libri di poesie Prete adotta vari registri, pur nell’unità stilistica: Tempo rubato accosta brevi pagine di prosa che vanno dall’operetta morale (“Malinconia del cartografo celeste” e “Favola”), al diario (“Intorno al ricordare”), l’apologo, la fiaba, un breve racconto che ha la grazia luminosa delle prose di Pedro Salinas (“Un addio”), tra endecasillabi, versi liberi e poème en prose.
Sebbene le pagine di saggistica, teoria della letteratura e della scrittura, diario, poesia abbiano un’unità stilistica e di pensiero che le lega in un unico corpus, Antonio Prete (come Zanzotto) reinventa la lingua con sintagmi e neologismi verbali: “Come la galaverna, che indiamanta/ la ramaglia del mandorlo al mattino”; “Sei il ricordo che la luce disrama”; “Si spètala come una begonia/ la rosa dell’estate”; “Acqua che diroccia balzando./ Rinasce in rivo, con scaglie di blu,/sfruglia nei cespugli,/ s’avvalla lenta/ lungo greti, il cielo nelle sue anse,// Gorgoglia tra i salici,/ traspare e s’inombra,/ lontanando tra argini che si spengono”, che trovano il culmine nelle composizioni in dialetto: stupendo per esempio un verso come “E ghé iernu, lu iernu ti lu munnu” (“Ed è inverno, l’inverno del mondo”). Tra le liriche in dialetto ce n’è una, “La cumeta” (“L’aquilone”) che naturalmente rinvia a uno dei più famosi testi di Pascoli.
Il tema del silenzio, della lingua e della scrittura: “Le parole camminano con noi. […] Attendono, le parole, in silenzio,/ che appaia, prossima, la terra dove/ la lingua è vento, fiume, albero, stella./ Vi abita, dicono, la poesia”; “Il suono della neve è un silenzio/ che muove verso la voce, sotando/ nel brusio. Soffio che fa cenno al canto”.
Unità stilistica e di pensiero da un libro all’altro, che si tratti di poesia, memorialistica, saggistica, come dicevamo, sono il timbro della voce e della scrittura di Antonio Prete, una voce unica nella letteratura italiana contemporanea. Una lettura superficiale può far pensare a un poeta di una tradizione fuori dal tempo, rispetto soprattutto alle correnti delle avanguardie e alla sperimentazione stilistica che aggredisce il verbo e il linguaggio nei sintagmi logori della tradizione e nella pressione della tecnologia (che muta anche non solo i lemmi e la sintassi ma anche la psicologia del pensiero); in Antonio Prete filosofia, storia del pensiero, etimologia e letterature (al plurale) s’innestano e gemmano l’una nell’altra.
Ampliando la riflessione alla psicoanalisi e frantumando il lessico e la forma logica della sintassi solo Andrea Zanzotto è in Italia un autore imparagonabile ad altri.


Dai libri:
Le forme che non sono
Perché amo le forme che non sono,
la loro trasognata trasparenza,
il battito di luce che le scuote,
visibile soltanto nei pensieri,
è per questo che abito nel paese
della lingua, diceva, dove trema
in quel che accade quel che mai è stato
e nell’acqua del tempo fluttua l’ombra
della vita che non fiorirà mai.
Questo diceva, mentre le parole
come foglie cadevano per terra
e la luce moriva nella sera.
da “Del silenzio”
*
Il libro che non scriverò mai
Il libro che non scriverò mai
ha il vento nelle sillabe, la musica
del mare nelle vocali. Ogni frase
custodisce con cura i nomi delle cose.
Il libro che non scriverò mai
ha fogli d’alga, margini d’aria,
sopra ogni foglio le linee di un volto,
sopra ogni margine voli di uccelli.
Tra le righe, il profilo dei paesi
che non ho mai conosciuto.
Il suono, tra le parole, della lontananza.
Il libro che non scriverò mai
si apre con una parola che è anteriore
alla prima parola, ha sempre una parola
che viene dopo l’ultima parola:
libro mai cominciato,
libro da sempre incompiuto.
Il libro che non scriverò mai
ha una lingua innamorata di ogni
altra lingua. Nella sua punteggiatura
c’è il disegno delle costellazioni.
«Disponi ogni parola che tu scrivi
all’ombra di quel libro», mi dice
una voce che viene ora da un libro.
*
Le parole, in cammino
Y tienen las palabras su verano
su invierno…
(E hanno la loro estate le parole
il loro inverno…)
Ida Vitale
Le parole camminano con noi.
Hanno nel suono il segno degli inverni.
Ogni autunno continua a dispogliarle
della gloria.
Ma c’è nel loro passo
la letizia della meta: un giardino
dove sempre risplende primavera.
Il senso, in quel giardino, è un fiore, il suono
è il suo profumo, la sua propria luce.
Lo stormire è il pensiero delle foglie.
Attendono, le parole, in silenzio,
che appaia, prossima, la terra dove
la lingua è vento, fiume, albero, stella.
Vi abita, dicono, la poesia.
*
Il suono della neve
Nevica. Si ritraggono le forme
in una loro quieta essenza. Scendono
nella dolcezza del non apparire.
Un mormorio di luce bianca cade
in batuffoli danzanti. I volteggi
infiorano di lampi il velo d’aria.
Il suono della neve è un silenzio
che muove verso la voce, sostando
nel brusio. Soffio che fa cenno al canto.
Un sibilo che insegue le vocali,
le sfiora, torna frusciante sciacquio.
Velata musica d’afoni fiati.
Quando la neve cessa di cadere
del suo suono hanno memoria i sentieri
cancellati, gli uccelli nel riparo.
*
Gli alfabeti
Alfabeti di antiche lingue
che inseguono il suono perduto.
Alfabeti che stormiscono come alberi al vento.
Alfabeti vigorosi: ogni lettera un urlo.
Alfabeti che in ogni lettera
custodiscono il grido di una passione.
Alfabeti in cui risuona la voce del mare,
delle onde alla scogliera, della risacca.
Alfabeti che sanno la tempesta, i bisbigli
notturni dei boschi, i versi degli uccelli.
Alfabeti in cui ogni lettera è soglia
di un silenzio infinito.
Le lettere di tutti gli alberi
cercano un suono che un poco somigli
al soffio che fa essere le cose.
da “Convito delle stagioni”

Intervista ad Antonio Prete:
Il tema del silenzio è simbolo e filigrana della tua scrittura come studioso e come poeta e il silenzio s’intreccia con il “pensiero poetante”, titolo del tuo più importante saggio leopardiano. Al silenzio hai dedicato anche il libro pubblicato da Mimesis. Silenzio visione, tessuto (texte) e pratica della poesia, pensiero e scrittura: sei d’accordo?
Con questa tua prima domanda sento che vai subito al cuore di quella avventura, o ricerca, che da tanti anni tento di perseguire, cioè interrogare i confini della parola, e dunque anche del discorso, quei confini che sono il prima e il frattempo del senso, ma anche il vuoto del senso, e che il silenzio può in qualche modo indicare, senza impossessarsene, attraversare senza restare prigioniero.
Il silenzio è il respiro del pensiero che non si chiude nella gravità della parola discorsiva, ragionevole, dimostrativa: pensiero del mondo che non muove dal sé, ma dalla presenza creaturale delle cose, e pensa il sé vivente solo nella comune appartenenza al vivente naturale, animale, astrale.
La poesia è la lingua che accoglie questo soffio e lo porta, musicalmente, in un dire che è ospitalità del visibile, ma anche esperienza che sosta sulla soglia dell’invisibile. Senza il silenzio questo movimento della parola verso l’oltre non è possibile. Per questo ho voluto mettere sulla copertina di “Convito delle stagioni” una poesia in cui il silenzio è per dir così l’anima della stessa musica terrestre che stormisce, un silenzio che è “specchio/ del cielo, dei suoi silenzi”.
Quanto al rapporto con il lontanissimo “Pensiero poetante” – ricordo in proposito un antico nostro incontro – c’è da dire questo: per Leopardi attraversare il sapere, i saperi, è anzitutto dislocare il proprio punto di vista in una lontananza estrema o, come direbbe il Baudelaire di “Élévation”, “par-delà les confins des sphères étoilées”.
Questo sguardo dall’alto, e dall’altrove, è un atto contemplativo che permette di interrogare dalla soglia del silenzio la conoscenza, e le passioni, e le contraddizioni dell’esistenza, cioè l’essere nella finitudine portando in sé un’irrisolvibile domanda di infinito. Intorno al silenzio continuo a riflettere: per frammenti (quei passaggi raccolti nel taccuino che citi sono parte di un libro al quale lavoro).
Il tema e la scrittura del silenzio attraversano anche l’opera degli autori che più ami, da Leopardi a Jabès, Bonnefoy, Celan, sino alla pittura di Morandi e di Cézanne, che citi nel “Convito delle stagioni” e in “Del silenzio”. Nelle tue riflessioni parli anche di lingua materna, come amava ripetere Zanzotto (il petèl). Altri temi (sguardi, visioni, intonazioni della mente e della lingua) che sento centrali nel tuo lavoro sono la natura, il paesaggio e la memoria: leopardianamente interroghi gli astri, il cielo della notte, e nel paesaggio irrompono i ricordi: quanto i tuoi studi e le letture di una vita hanno inciso sulla tua produzione poetica?
Certo, c’è una connessione tra i miei studi e quel che cerco di scrivere, sia nella forma del saggio sia nelle forme della poesia o della prosa. Quel che mi preme dire – e la tua domanda me ne dà l’occasione – è che per me l’atto della scrittura in quanto tale ci chiama, ogni volta, a una sorta di responsabilità assoluta, la quale va al di là dei singoli codici o delle singole tradizioni.
Insomma, la stessa disposizione interrogativa, “silenziosa”, la stessa sospensione e “elevazione” occorre avere, a mio parere, dinanzi alla parola che si muove nell’ordine del sapere e dinanzi alla parola che è movimento della lingua nelle terre dell’immaginazione e del sentire.
Gli autori che citi, da Leopardi a Zanzotto, compresi pittori come Cézanne e Morandi, sono uniti da una forte tensione nella loro ricerca: il pensiero che si fa forma, il vivente che pulsa nella lingua, il dialogo tra visibile e invisibile. Certo, quei luoghi o temi che nomini – natura, paesaggio, memoria – sono tessuti, o interrogati, nei versi di “Convito delle stagioni”, come nelle precedenti mie raccolte poetiche.
Ma qui ho cercato, non so se ci sono riuscito, di fare della loro presenza una compresenza, un convito, un dialogo: il vivente che è respiro della natura è anche anima del paesaggio visibile e di quello che è oltre (l’arriére-pays su cui Bonnefoy ha scritto pagine molto belle), e la memoria è essa stessa vita di ogni elemento naturale e umano.
Inoltre il tempo, in tutte le sue declinazioni, compreso il tempo non vissuto, è quel che trascorre come basso continuo nel mio interrogare: in “Convito delle stagioni” ho inserito dieci brevi prose sul tempo, sul tempo interiore e quello fisico, sul tempo che è ricordo e sul tempo che sfugge alle nostre definizioni. E tuttavia la poesia deve portare tutto questo nella vita della lingua, nella leggerezza di un dire che sia insieme pensiero e musica.
In “Convito delle stagioni” le sezioni vorrebbero essere altrettanti movimenti di una partitura musicale: il grave si distende dolorosamente nella sezione “Lezione di tenebre”, cercando di sporgersi sul tragico del nostro tempo, tempo di insensate e orribili guerre.

Ti ricordi quali sono state le tue prime letture e innamoramenti letterari da bambino e adolescente?
Dopo le poesie mandate a memoria per presentarsi a quello che era l’esame di ammissione alla scuola media, ricordo la lettura, dai quattordici anni in su, per lunghe serate, delle poesie in traduzione italiana raccolte nel grande volume “Orfeo. Il tesoro della lirica universale”, curato per Sansoni da Vincenzo Errante e Emilio Mariano (con uno stuolo grandissimo di traduttori, che andavano da Montale a Ripellino, da Ungaretti a Luzi a Sereni a Landolfi, e si estendevano ad aree ispano-americane, giapponesi, cinesi, indiane, e così via).
Ma più di ogni cosa, nell’adolescenza, amavo la poesia di Leopardi, di Jimenez, di Lorca. Mandavo a memoria il “Canto notturno” e “Il tramonto della luna”, come del resto avevo fatto con “I Sepolcri” di Foscolo (ma erano i versi leopardiani, non quelli foscoliani, che mi portavano l’esperienza di un vero incantamento).
Accanto ai poeti, leggevo molto, intorno ai quindici-sedici anni, i narratori russi, ma anche Victor Hugo e Jules Verne. Ma la mia formazione letteraria adolescenziale dovrei dire che viene soprattutto dal fascino che dai tredici anni ai diciotto hanno avuto su di me alcuni scrittori toscani, i cui libri trovavo sulle bancarelle a Lecce e mi facevo regalare: Giovanni Papini, anzitutto, Lorenzo Viani, Nicola Lisi, Enrico Pea.
A questi aggiungevo Tommaso Landolfi (tra l’altro in quegli anni Landolfi viveva in Toscana). Ero preso dall’energia di quella loro lingua, dall’invenzione linguistica, dalle forme inconsuete del dire.
Mi segnavo su un quaderno le nuove parole, e spesso si trattava di un toscano delle campagne. Poi, negli anni dell’Università, la lettura ha dilatato i suoi confini, e accanto a Croce, moltissimo Croce, leggevo Gramsci, e Sartre, accanto a Flaubert leggevo Pavese o Alvaro, accanto a Gide, Proust e così via.
Posso dire che è stata la passione della lettura che naturalmente mi ha portato alle prime scritture, sin dagli undici anni (a quell’età risale il primo breve racconto, perduto, scritto su un quadernetto a quadretti con la copertina nera e il bordo delle pagine rosso, intitolato “Lo sconosciuto”).
Viviamo (purtroppo) nell’inciviltà del rumore. Nei sentieri di montagna e nei boschi scorrazzano motociclisti, nei rifugi c’è musica ad alto volume: è come se persino in vacanza ci facesse paura ascoltare il silenzio. E non parliamo delle spiagge e delle città. Ho un profondo senso di disagio e inappartenenza. Come spieghi questo “bisogno di rumore”?
Ricordo che quando anni fa, nel 2016, presentavo una mattina al Festivaletteratura di Mantova il mio libro “Il cielo nascosto. Grammatica dell’interiorità”, avendo nominato tra l’altro il tema del silenzio, tra le domande del pubblico ce ne fu una di un signore che disse che il silenzio era più che mai un problema politico: il diritto al silenzio era un diritto civile, e i politici e gli amministratori dovevano agire urgentemente per sottrarre le città al dominio del rumore.
Occorrevano, aggiungeva, battaglie civili per il pubblico silenzio. In effetti, davvero bisognerebbe fare del silenzio nelle città più una grande questione politica.
Se tu, come Rilke, dovessi scrivere una “Lettera a un giovane poeta” quali sono i primi consigli che gli daresti?
Consiglierei anzitutto la lettura assidua della poesia, la lettura dei classici della poesia, naturalmente non solo italiana. E consiglierei che, scegliendo secondo la propria inclinazione e passione, qualcuno di quei classici – in lingua italiana o altra lingua – si ritorni più volte e in diversi momenti su quei testi.
Studiandone forme, modi espressivi, immagini, ritmi, modalità di pensiero. Insieme a questo, assolutamente non separato da questo studio, è importantissimo abituarsi a osservare la natura, nei suoi particolari, in tutte le sue manifestazioni, e dare nomi a quel che appare.
Allo stesso tempo coltivare la propria interiorità: dedicando molto tempo all’osservazione di sé nel rapporto con gli altri e con il visibile, e nel contempo abituarsi a fare dell’immaginazione, come diceva Baudelaire, la “regina delle facoltà”.

L’autore:
Antonio Prete è nato a Copertino, nel Salento, nel 1939. Per molti anni ha insegnato Letteratura comparata all’Università di Siena. Come poeta ha pubblicato “Menhir” (2007) e “Se la pietra fiorisce” (2012), entrambi da Donzelli e, con Einaudi, “Tutto è sempre ora” (2019).
Studioso di Leopardi, al poeta di Recanati ha dedicato diversi saggi, tra cui “Il pensiero poetante” (Feltrinelli 1980, nuova edizione Mimesis 2021).
Tra gli altri titoli: “All’ombra dell’altra lingua. Per una poetica della traduzione” (2011), “Trattato della lontananza” (2008), “Compassione. Storia di un sentimento” (2013), “Album di un’infanzia nel Salento” (2023), “Torre saracena. Viaggio sentimentale nel Salento” (2018), “Il demone dell’analogia” (1986), “Nostalgia. Storia di un sentimento” (1992-2018), “Il cielo nascosto. Grammatica dell’interiorità” (2016), “Carte d’amore” (2022), “L’ospitalità della lingua. Traduzioni con testo a fronte” (2014).
(Antonio Prete “Convito delle stagioni” pp. 140, 12 euro, Einaudi 2024)
(Antonio Prete “Del silenzio” pp. 108, 9 euro, Mimesis/Accademia del Silenzio 2022)
Immagini ———————–
JULY 22. KHERSON TV
The Journey
di Mikhail Ray

Margini. Di poesia ed altro —————————–
Della tensione verso un orizzonte
Niccolò Nisivoccia, “Un dialogo notturno”
di Roberto Lamantea

Lei dormiente: figura dell’ascolto, la immaginiamo come una scultura di Canova, nell’ombra della stanza. Una stanza nella notte, una camera tra milioni in una grande città. Lui le parla: parla di sé, di politica, d’amore, che sono la stessa cosa: scoperta e dialogo con l’altro, ascolto, condivisione. Chissà se le parole entrano nel sonno o nel sogno di Lei. Mentre l’aria s’inazzurra, l’alba schiude gli occhi di là dalla finestra: “È giorno: ed è sul fare del giorno, ogni giorno, che ci lasciamo e ci ritroviamo”.
Niccolò Nisivoccia sa cantare il tempo. Le variazioni della luce come un cristallo, le ali invisibili dei pensieri, voci senza voce che danzano, libellule nei sogni di Lei. Pensieri come fili di ragno, reti d’argento. Illuminations, e citare Rimbaud è più che mai appropriato. Nel 2021 Nisivoccia ha pubblicato un libro bellissimo da Interno Libri, “Quasi una cosmologia”; nel 2022, da Mimesis-Accademia del Silenzio, un breve saggio – ma forse è più appropriato definirlo una riflessione – sul silenzio che stiamo perdendo, che è, prima di tutto, incapacità di ascoltare l’altro, pensare l’altro, sentirsi parte di un “noi”: “Il silenzio del noi”. Questo nuovo piccolo libro, “Un dialogo notturno”, conferma che le etichette di genere a Nisivoccia vanno strette. Lo si potrebbe definire leopardiano, forse, per come “vede” i pensieri nella sua mente e sa annotarli, ma i riferimenti più corretti, per il suo pensiero-scrittura, sono gli amati francesi: Blanchot, Barthes, Bonnefoy, Char, non solo per l’affinità stilistica, la poetica del frammento, ma per come il pensiero, lo sguardo-concetto, si compone sulla pagina: non importa se tecnicamente va definito prosa poetica o altro.
Questo rispetto per il pensiero-sguardo dona alla pagina un’intensità straordinaria e la lettura si trasforma in canto.

“Un dialogo notturno” – che esce nella collana “Extra Moenia”, titolo perfetto per testi che sfuggono a definizioni di genere – esce con la prefazione di Luciana Castellina, che chiama queste pagine “poesie in prosa” e annota: “L’aspetto più importante della vita sono le parole. E cioè il rapporto con l’altro e il prendersene cura, sentirsene responsabili”.
Amore e politica, dice Nisivoccia, sono la stessa cosa, entrambi sono rivolti all’altro: “La politica”, scrive Castellina, “deve essere declinata al plurale”. L’esergo è di Wisława Szymborska: “Siamo figli dell’epoca,/ l’epoca è politica.// Tutte le tue, nostre, vostre/ faccende diurne, notturne/ sono faccende politiche”. Politica: dal greco antico politikē, da polis, città-Stato, e téchnē, arte o tecnica del governo. Per estensione, nel senso più nobile, il governo con l’altro che nasce anche dall’ascolto dell’altro.
“L’amore è una conversazione”, scrive Nisivoccia, e viene in mente un altro grande francese, Rohmer. Politica e utopia: “Anche l’utopia deve sprofondare nel reale: ed è anzi nel reale che l’utopia stessa può trovare la sua forza, il suo valore. Troppo spesso ci si rassegna al dato di realtà, e lo si accetta come elemento fermo, immutabile. […] Troppo spesso confondiamo l’utopia con la speranza, disimpegnata, e rinunciamo a noi stessi, all’immaginazione: alla possibilità di pensare davvero ad altro che non abbiamo già pensato, già immaginato. […] L’una e l’altro [politica e amore] è di fiato che hanno bisogno, della tensione verso un orizzonte”.
L’altro e il noi sono (sarebbero?) il senso della politica e dell’amore. C’è una pagina stupenda, in questo libro, che va letta per intero (p. 39):
“L’amore è dare un seguito alle parole dell’altro, è proseguirne il discorso. È non interromperlo, accompagnarlo, riprenderlo, non lasciarlo: farlo nostro conservandone l’alterità. […] L’amore assomiglia a una preghiera – e che cos’è una preghiera se non una conversazione con un’Alterità, qualunque sia, cui chiediamo di ascoltarci e verso la quale ci mettiamo in ascolto? Pregare, come ascoltare, è anche immaginare. È cercare di dare un nome all’Alterità che ci ascolta e che ascoltiamo; è trovarne il nome anche in un vuoto, anche nell’assenza, nella dissolvenza. È una tensione verso un mistero, un bagliore, un’origine. È venire incontro a te, infine, incontro a noi. Siamo qui, dentro questa notte, dove siamo sempre stati”.

Pagina che richiama un altro magnifico passo di questo piccolo libro (p. 66):
“Ti parlo per parlare ancora. Ti parlo da ogni dove, da ogni nascondiglio, da ogni me; anche a nome di tutti gli altri io che mi attraversano o mi hanno attraversato, chiamati a raccolta ora e qui. Ti parlo da dove ogni altro io si è insediato dentro di me, e dunque anche da dove sei tu; dal tuo io da cui mi sento abitato anche in assenza, che mi parla e mi ascolta anche nella lontananza. È la vita che esorbita, che brucia, che preme. È la vita che un io, da solo, non contiene”.
Si chiamano “stanze”, i capitoli del libro – sono 40 – come nella lirica medievale e rinascimentale.
I rumori della strada e i chiarori che filtrano dai vetri dicono che la città si sta risvegliando, Lei sta uscendo dal sonno. L’aria è fresca, di primavera. Lei ha sentito le parole di Lui? “Entro a volte nel tuo sonno” è un titolo stupendo di Sergio Claudio Perroni (la Nave di Teseo 2018), l’ultimo libro dello scrittore siciliano (1956-2019). “L’infinito di amare” (Due vite, una notte), edito sempre dalla casa editrice di Elisabetta Sgarbi e uscito postumo nel 2020, racconta i pensieri di due amanti al risveglio. Piace pensarlo come un abbraccio.

L’autore:
Niccolò Nisivoccia è nato nel 1973 a Milano, dove vive e lavora. Avvocato, scrittore, poeta, collabora con il manifesto e Il Sole 24 Ore. I suoi libri: “Sulla fragilità” (Le Farfalle 2019); “Variazioni sul vuoto” (Le Farfalle 2020); “Quasi una cosmologia” (Interno Libri 2021); “Il silenzio del noi” (Mimesis-Accademia del Silenzio 2022); “Il diavolo mi accarezza i capelli” (con Adolfo Ceretti, Il Saggiatore 2019).
(Niccolò Nisivoccia “Un dialogo notturno”, prefazione di Luciana Castellina, pp. 104, 12 euro, Industria&Letteratura 2024)
Immagini ———————–
Brightness of memories
The Journey
di Sergey Dobrynov

Latinoamericana ——————————-
Las paredes del corazón se adelgazan Le pareti del cuore si assottigliano
Quattro poesie inedite in italiano
di Isabel Hualde

Verano
Amenaza bochorno
y es un riesgo perderse en la tarde.
Algunos escapan hacia el río.
El sopor el sopor que no el sueño
¡tum-tum tum-tum!
sobre patios y naranjos.
Los niños entreabren los visillos
al olor de la tormenta.
Duerme el patriarca
en su hamaca de luna
el cinturón
descansa justiciero en la mesilla
-ni asomo de culpa-.
Su orondo vientre respira panzudo
arriba y abajo
arriba y abajo
hondo balanceo
¡tum-tum tum-tum!
ignorado por el ojo cegado de Dios.
Estate
Minaccia l’afa
ed è un rischio perdersi nel pomeriggio.
Alcuni scappano al fiume.
Il sopore il sopore che non è il sonno
tum-tum tum-tum!
nei cortili e sugli aranci.
I bambini socchiudono le tendine
all’odore della tempesta.
Dorme il patriarca
nella sua amaca di luna
la cinghia
riposa giustiziera sul tavolino
– né un indizio di colpa –
Il suo pienotto ventre respira panciuto
su e giù
su e giù
profondo dondolio
tum-tum tum-tum!
ignorato dall’occhio cieco di Dio.
*
Jefe
Has conspirado documentos
con la oscura eficacia de un tirano
has roto la casa de tu amigo
con el peso total
de tus carros de combate
has escondido la basura
en siniestros apartados
y aniquilado la voz
no adaptada a tus rutinas.
Con ardor extraordinario
bailas sobre tu fiel orquesta
de chismosas cacatúas.
Eres un duro jefe de estado
perfecto
tan arrogantes tus leyes chatarra
discursos amantes.
En ese círculo extravagante de gaviotas
y a vista de pájaro
hoy me quedo de nuevo sin desayuno.
Il capo
Hai tramato documenti
con la oscura efficacia di un tiranno
hai distrutto la casa del tuo amico
con l’intero peso
dei tuoi carri da combattimento
hai nascosto la spazzatura
in sinistri commi
e annichilato la voce
non adeguata alla tua routine.
Con straordinario ardore
balli sulla tua fedele orchestra
di pettegoli pappagalli.
Sei un duro capo di stato
perfetto
le tue leggi bidone così arroganti
discorsi amanti.
In quel cerchio magico di pappagalli
a guardare dall’alto
oggi mi ritrovo di nuovo senza colazione.
da “El ojo cegado” (“L’occhio Accecato”), Editorial Eunate, 2015
*
Diario de las fronteras
Aquí
las paredes del corazón se adelgazan.
No seré yo quien escriba versos
con los dedos carbonizados por la heladura.
El azar persigue constantemente nuestro paisaje
avanzamos o retrocedemos como si bailáramos
sobre la línea divisoria.
Aquí
nadie ha visto señalar la luna
o florecer un cerezo
y el brillo de la escarcha a menudo significa
aprender a leer la muerte.
La nada acecha
los ojos cegados por los reflectores
y el soplo del diablo ahuyenta la esperanza.
Nos devuelven al infierno los muertos entre los vivos.
Un óscar para esta película de rostros sin nombre.
Herida fotografía en blanco
y negro
y gris.
Diario delle frontiere
Qui
le pareti del cuore si assottigliano.
Non sarò io a scrivere versi
con le dita carbonizzate dal gelo.
Il caso insegue costantemente il nostro paesaggio
avanziamo o retrocediamo come se ballassimo
sulla linea divisoria.
Qui
nessuno ha visto indicare la luna
o fiorire un ciliegio
e il brillare della brina spesso significa
imparare a leggere la morte.
Il nulla minaccia
gli occhi accecati dai riflettori
e il soffio del diavolo fa fuggire la speranza.
Ci restituiscono all’inferno i morti tra i vivi.
In oscar per questo film de volti senza nome.
Ferita fotografia in bianco
e nero
e grigio.
*
Prostíbulo
Alguien pierde la cabeza
y recorre el contorno del miedo
(lo absurdo del sueño de vivir).
Detrás confabula el hambre.
Alguien llora y ríe ¿quién?
-todo dentro del protocolo-.
La mancha blanca se vuelve oscura
en esta cama sin flores.
Otro alguien bajará el pulgar
y la convertirá en polvo sin perspectiva.
Nadie canta sobre nada
de noche me como mi propio llanto
y leo una a una las estrellas.
Tiéndete junto a mí
país de la buena suerte.
Postribolo
Qualcuno perde la testa
e percorre il perimetro della paura
(l’assurdo del sogno di vivere)
Dietro confabula la fame.
Qualcuno piange e ride chi?
– tutto fa parte del protocollo –
La macchia bianca si fa scura
in questo letto senza fiori.
Qualcun’altro abbasserà il pollice
e lo trasformerà in polvere senza prospettiva.
Nessuno canta sul nulla
di notte mi mangio il mio pianto
e leggo una ad una le stelle.
Stenditi di fianco a me
paese della buona sorte.
da “Reconstrucciones” (“Ricostruzioni”), Editorial Vitrubio, 2017
(Tutte le poesie di Isabel Hualde sono state selezionate e tradotte in italiano da Antonio Nazzaro).

L’autrice:
Isabel Hualde (Spagna), appartiene all’Associazione degli Scrittori della Navarra ANE-NIE e al Gruppo “Ángel Urrutia” dell’Ateneo di Pamplona.
Ha pubblicato: “El juego y el vuelo”(infantil), “El entramado luminoso” (Irache, 2011), “Cisne azul o cisne negro” (1° Premio XX Certamen Internacional María del Villar 2015), “El ojo cegado” (Eunate, 2015), “Reconstrucciones” (Vitrubio, 2017), “Caminar horas” (Eunate, 2019), “Código deontológico”(Círculo Rojo, 2022 e Ulzama digital, 2023), “Ashwayats” (Pez soluble, 2022 e Edic. 4 de Agosto, 2023, bilingue euskera-castellano).
Di prossima pubblicazione “Canto delle piccole voci” (Edic. El escorpión azul) e “Desbordamientos” (Nautilius).
Suoi testi fanno parte di diverse antologie nazionali e internazionali. Tra i tanti riconoscimenti ricevuti ricordiamo: 1° Premio XX Certamen internacional “María del Villar” de Tafalla 2015 e il 1° Premio IV Certamen internacional de microrelatos Amnistía Internacional – Valladolid, 2023”.
La sua poesia “Mujer-escritura” è incisa sulla scultura “Mujeres y libros” nel parco della memoria della donna di Peralta (2020).
Parte della sua opera è stata tradotta in basco, asturiano, francese, italiano, arabo e olandese.
Immagini ———————–
Introverted worm
The Journey
di Petro Hrytsiuk

Voce d’autore ————————–
In un giorno che è notte
Stefania Licciardello, “Il libro della Gloria”
di Giovanni Fierro

“Il libro della Gloria” di Stefania Licciardello è questa sorpresa che sempre si rinnova, ogni sua poesia sfuma nella seguente, e continua quella che la precede, è una gemmazione continua, che si mostra nel suo sbocciare. Il suo è un dire che esplora ogni possibilità di espressione, “Cerniere di trebbie aprono le colline/ il frastuono è del fiore del seme,/ sbucano bucano palpebre orli ingombri,/ il grano è alto anche disteso”, per scardinare ogni apparenza, per trovare la radice che è stata seme, che sarà significato.
Tutto “Il libro della Gloria” è pura bellezza al lavoro, Stefania Licciardello costruisce e riconosce luoghi dove le parole sono liberi accadimenti di mondo, una frontiera di percezioni e scoperte, dove si possono indicare “i pesci sugli alberi fino alle stelle”.
“Non posso prometterti niente/ per questo scrivo”, ma non c’è mai incertezza, anzi, la scrittura che anima queste pagine è coraggiosa e sa osare. Rinuncia ad ogni confort, rifugge da ogni riparo, sceglie l’aperto di ogni scommessa e l’efficacia di ogni tensione. Sa riconoscersi “nel regime delle acque che è quello delle parole”, perché lo scrivere è un ulteriore luogo in cui lasciarsi andare, possibile esperienza per nuove e rinnovate epifanie: “Sia la luce sia il buio/ è speranza concreta/ intorno le cose tutte”.
Ed è la luce nella sua essenza più vera, che sia quella che permette di vedere o quella di una dimensione interiore, a nutrire le pagina di questo sorprendente libro. Luce che non acceca mai, capace di trovare la giusta ed equilibrata intensità, luogo anche lei dove “si staglia il campo del cielo/ fiorisce ingrana ride mentre il sole scava”.
Perché Stefania Licciardello ci racconta di una realtà che non è mai miraggio ma nuova visione, occhi da aprire meglio, sguardo da far crescere con fiducia per trovare la verità nelle immagini che viviamo, “vorrei vederti in un grande formato/ ti copio a matita/ andiamo al cinema”.
È tutto acceso, è tutto importante in questo libro, anche le minime note sono appunti a cui fare continuamente riferimento, “nel mese più corto/ con straordinario trasporto sparire” e “il sacrificio degli uomini è ammarare,/ ce la siamo cavata per luminosità/ diurna notturna”.
La dimensione della soglia è sempre presente, il passaggio tra un dentro e un fuori si fa movimento essenziale per andare incontro alla meraviglia o al silenzio più intimo. Movimento necessario per trovare un qui ed ora dove tutto ha più valore, dove ogni cosa è precisa, esatta: “In un quadrato di mare/ lo spillo ricurvo pesca/ alghe ferite”.
Ecco, terra e mare trovano una vicinanza che si fa desiderio reciproco, anche qui una frontiera di incontro, “dentro casa/ una libreria aspetta boschi/ i divani aspettano il mare”.
Sì, rimane un unico gesto, scegliere la propria Gloria da vivere.

Dal libro:
2
Una mano, un suono
apre la finestra
fanciulli tolti al sole
danzano
con le orecchie poggiate alle nuvole
verdi si fanno,
le case crollano.
*
13
Tantissime volte per sbaglio
mi son chiusa fuori casa
tutte le altre volte per sbaglio stavo chiusa dentro.
*
32
E di tanto animale fra me e te
bolle di sapone
parole stravaganti
biglie.
Mi squarcia il dialogo.
*
35
Schermare la luce con il suo rigore
Il suo sorriso.
Le parole germinano ramificano
libri figli frutto.
I fiori schiudono poi sfanno
la poesia a volte si avvera.
Ci sono così tante cose da scrivere.
Immane la primavera.
*
57
Baciami nel sonno
quando sono solo cuore
in un giorno che è notte
baciami aurora
Aurora io voglio vederti dormire.

Intervista a Stefania Licciardello:
“Il Libro della Gloria” costruisce pagina dopo pagina un luogo dove terra e cielo, mare e terraferma si incontrano, creando un luogo unico, una vera e propria frontiera di percezione. Dove ogni esperienza è l’occasione per vivere questa preziosa dimensione. È così?
Appartiene al mare, ma anche al cielo, una verticalità che non è ascensione ma andirivieni. Forse quello è il sentiero della divinità nel senso di cosa diventerà. In questa indeterminatezza precisa la parola genera l’apice di innocenza, la poesia. Senza epiteti. Di questa convinzione mi ha nutrita Piero Ristagno, poeta e maestro.
E il libro è anche una riflessione sullo scrivere in sé, e in special modo sullo scrivere poesia. Cosa significa dunque avere fiducia nella poesia, affidarsi ad essa, permetterle di dire e raccontare?
La poesia non è necessaria, sarebbe poco, ma sempre possibile, non esiste un momento storico, un’età, un tempo qualsivoglia impoetico, anche questo l’ho preso da Piero.
A volte la poesia è spontanea zampillante irruenta, a volte vereconda come quella del “Libro della gloria”; è andare a un banchetto regale con quello che si ha, altissimi con una corte di cani, i cani sempre, sempre i poeti, i ballerini, i pittori, i contadini.
Un testo come quello di pagina 42 (“Cerniere di trebbie caute aprono le colline/ il frastuono è del fiore del seme/ sbucano bucano palpebre orli ingombri/ il grano è alto anche disteso […]”) dice bene di come il tuo scrivere sappia molto bene scardinare le apparenze, di come sia capace di trovare la verità nelle immagini che crea. È questa una prerogativa del tuo fare poesia? O cos’altro?
IL FRASTUONO È DEL FIORE, DEL SEME. Per quello che opero la poesia è qualcosa che ingegnosamente sovverte e unisce: i contraddittori generano lo sbalordimento.
Importantissimo il procedere in una trilogia Libro di campo-Libro dei bisogni-Libro della gloria che accompagna ad una vetta, la gloria; il capo di un fazzoletto scrollato libera la terra, protagonista della prima raccolta.
La luce è molto importante in questo tuo lavoro. Che sia luce che permette di vedere o che sia la luce di una dimensione interiore, è sempre molto presente. Che identità ha la luce che si respira in “Il Libro della Gloria”?
Non esiste il buio, cerco di guardare bene, c’è una quantità di mondi, cerco di rappresentare bene la sostanza, la gloria delle cose, che non può essere fissa; splende turbata da alberi e stelle, i miei versi stringati asciutti fanno una baraonda di luci una notte di San Lorenzo.
Mi sembra che nelle pagine de “Il Libro della Gloria” ogni poesia fecondi quella che la segue, che ci sia una impollinazione continua, uno spingere nella poesia seguente la radice di quella che la precede. Fino al punto in cui ogni testo è uno sbocciare, pieno ed ampio. Ti ci ritrovi in questo?
Il libro della Gloria è ri-creazione, inchinarsi alla bellezza, alla poesia e lasciare opere. Questo è il teatro, per quello che è il mio vivere il teatro di Gaetano Impallomeni prima e poi di Monica Felloni cui è dedicata la raccolta. Come si fa a scrivere ancora di poesia se ogni fantasia è realizzata? Quale l’altezza? Una radice sa del cielo e il cielo sa della radice: Gloria!
(Il testo di Stefania Licciardello dell’intervista è dedicato a Massimiliano Frumenti)

L’autrice:
Stefania Licciardello vive a Catania.
Ha pubblicato “Libro di campo” (2017), “Libertinia”, con foto di Eletta Massimino (2019), “Il libro dei bisogni” (Nèon edizioni, 2020).
Fa parte del gruppo di teatro Neon.
(Stefania Licciardello “Il libro della Gloria” pp. 85, 10 euro, Nèon edizioni 2023)
Immagini ———————–
Dead Milk #3
The Journey
di Maria Drozdova

Tempo presente —————————-
Finché all’improvviso il tempo cambia
Iulita Iliopulu, “Il mosaico della notte”
di Antonello Bifulco

Il libro di Iulita Iliopulu, edito da Donzelli Editore, è capace di evocare luci, colori, movimento, in un luogo dove lo stare pare essersi comunque fermato, il narrare poetico si perfeziona poi mostrandosi in una ripetitività di immagini, simboli, parole che danno forma al vivere una vita, altre vite, il tempo dell’anima.
La poesia prende subito ritmo tracciando delle linee, delle graffiature, dei vuoti, creando spessori che vanno ad abbracciare temi e cronache di silenzi che ti hanno cercato, di finestre lasciate aperte in una casa in perenne statico movimento.
Il mosaico è una tecnica che ci racconta la capacità di unire pezzi di diversa natura convogliandoli in un’unica opera dove le varietà dei materiali diventano valore fondamentale dell’insieme, un’arte che fa dello scarto uno dei suoi punti di forza così come fa l’autrice in questa silloge. Un mosaico di emozioni, acrobazie tra gli stati d’animo, nostalgie calate dentro mura di affetti, tessere tante buttate a comporre quadri dinamici, tessere che sono i sogni di una vita, i sogni di un’isola, quelli delle notti dove le stelle, quando si alza il vento, rotolano giù.
La silloge si compone di due capitoli, il primo prende il titolo del libro, “Il mosaico della notte”, seguito da “La casa”. Bella la presenza del testo originale nella lingua madre della poetessa, il greco, con traduzione della curatrice del libro Paola Maria Minucci e di Chiara Catapano.
Nel primo capitolo la poetessa ci accompagna tra una moltitudine di tematiche, la notte è il fulcro, la spina dorsale che tutto ingloba, come lei stessa dice “un’immagine di parole che chiedono di esprimere i tanti e intensi colori della notte, dell’assenza, del desiderio, del giudizio, della paura, dell’amore, del silenzio”. Poi i temi si allargano e ci muoviamo tra Isole, Mari, Albe, Tramonti, Sogni e una infinità di ombre.
E così attraversiamo ogni sua isola vissuta, amata, straziata nelle “Voci di bambini/ Bagnate dal mare/ In un cortile che apre/ Per un attimo/ La porta alla felicità/ E poi di nuovo non resta/ Che lo steccato, chiusa ovunque/ La casa/ Lasciando fuori/ Sempre più forte/ Il profondo sciabordio della notte”, poesia forte che inizia il libro con il sapore della felicità, libro che continua nelle sue ricerche raccontandoci che l’onda sprofonda all’improvviso e torna giù forte, come certi vecchi aspetti della vita.
Ci fa volare e guardare ai sogni in maniera differente ci mette di fronte alla notte fonda, tra le pietre, e d’improvviso un solo papavero bianco riesce a disarmare tutte le stelle; crea momenti che non ti aspetti, gioca con le parole come i gatti fanno col gomitolo lasciato cadere per terra.
C’è tutta la foga dell’estate lungo le case di questa sua terra, c’è la solitudine dell’isola dopo l’abbandono dei turisti, c’è il mare d’autunno che stanco dei nuotatori, si calma.
Poi irrompe la casa a raccontarci in prosa la visione della poetessa nei confronti di ciò che è il nostro vissuto tra le quattro mura. Seguendo sottili rotaie della memoria ci porta nei frammenti che formano la storia, le storie della casa.
La casa come geografia della nostra esistenza, partendo dal letto di un bambino al piano di sopra, dove solo il sonno dorme. Quelle case che il più delle volte nessuno abita, eccetto la pioggia e il vento, case dove un vaso abbandonato diventa il luogo dove la luna si annuncia colorandolo di giallo un po’ come fanno i limoni quando arriva la loro stagione. La casa che è quella delle distanze, quelle a cui non si vuole dare una vicinanza, quelle della società che si ammanta di legalità bruciando le baracche, quasi case, di un gruppo di senzatetto, clandestini.
Casa e ancora casa quella sognata con solo un pianoforte e te come sua voce, quella dove mai nessuno ha potuto descrivere la sua estensione, la casa di un amore, il nostro. Nuotare di casa in casa per trovarsi all’estremità delle labbra. Case appesantite dal tempo immobile, con vecchie fotografie sulle ginocchia che vengono messe frettolosamente in una valigia, casa la sua vita. Protezione. Prigione.
Poesia quella della Iliopulu che ti pone davanti ad uno specchio e ti fa tremare, ti fa attraversare il tempo e ogni tormento, ma lo fa sfiorandoti le labbra. Ed è subito notte.

Da “Il mosaico della notte”:
(traduzioni di Paola Maria Minucci)
Stelle
Tanto piccole che appena tira vento
Rotolano giù
Dal cielo le stelle quasi a precipizio
Riportando di nascosto, in notti simili,
L’oro spento delle statue
Insieme a tracce violette di baci
Negli incavi, nell’ondeggiare leggero dei tessuti
Nelle sillabe di parole rimaste soffocate in bocca
In fretta nello splendore di un attimo
Perché nessuno le veda e si svegli
Spaventato per quella strana luce.
*
Mare
Gocce di mare
Portate dal vento
Fin là dove non è quasi mai arrivata
Dentro più dentro delle case
Un’insolita tempesta
Con ciottoli, frammenti di vetro, conchiglie, granelli di sabbia
E salsedine
Lontano sui bianchi pavimenti
In alto sulle coperte, sul letto
In profondità nel silenzio dei baci
– Così tanto che soffrii aspettandoti –
Nel muto cullare
Nel sorriso soffocato di bambini mai nati
Nel pianto
Nell’attimo senza fine di una goccia
Finché all’improvviso il tempo cambia
Bonaccia
Che in un quadro ora cupo
Un tempo azzurro guarda
Fuori di casa
Mare…
*
Vuoto
Nessuno
Solo una luce dà vita al vuoto
E tanti ripiani di legno
Con i segni lasciati dall’antico peso
Vetri rotti, una testata di letto in ferro ribaltata
E più in alto sulla parete un piccolo triangolo di un vecchio specchio
Che non riflette più. Niente
Ombre quadrangolari e altre che alla prima ventata
s’ingrandiscono
Spegnendo colore dopo colore le viscere scoperte
Di questa casa. Spegnendo parola dopo parola
L’inganno degli uomini passati di qua
Per qualcosa che – non – avrà
Più di nuovo… vita.
*
Fine dell’estate
Quasi sui ciottoli
Con ricci ingannati sull’aiuola del davanzale
Con cancelli sempre semiaperti per la salsedine
Con un camioncino di plastica abbandonato in fondo al cortile
A scaricare – da solo – tutta la tristezza della casa
In un andirivieni senza fine dentro e fuori dai sogni dei bambini
A distribuire ancora un po’ di fiducia
Con detriti restituiti alla vita… una promessa
Orme sulla sabbia sottile
E stridio di gabbiani che camminano tranquilli e poi
all’improvviso con uno scatto
Adocchiano dall’alto l’autunno che arriva
Il vento appena cambiato
I leggeri graffi lasciati dagli aghi di pino sulla tela marrone
Punture nel sacrario del tuo cuore
Finché sempre di notte chiudono tutta la casa a doppia mandata
E una mattina come fossero spariti
Sacchi, sedie, panni stesi, salvagenti
Perfino quel camioncino in fondo al cortile
Niente. Soltanto
Lontano, altrove, qualche gallo dimenticato
Cerca di aprire – per istinto – la sua gabbia
E alza al vento la sua voce
Portandosi dietro tutta l’isola
Nel nuovo giorno
Si è fatto nuvolo… Non c’è più nessuno.
*
Da “La Casa”:
(traduzioni di Chiara Catapano)
VECCHIO VALZER delle parole con voce d’accordéon.
E sussurri di ragazzi che sono rimasti fuori la
notte. Dalla casa… Chi insegue stasera la luna che
non si decide a uscire? Ad annunciarla solo un po’
di giallo dentro il vaso di limoni. Poca luce dal
cortile. Si distinguono appena – “vie-ni-tor-na-a
pren-der-mi” – ombre, sillabe che passano. Coloni
d’amori stranieri dipingono i sogni: Porte pesanti
che lievemente apre il sospiro. Persiane ancora più
rosse, dipinte con l’inchiostro della notte. Una stanza
che sembra senza soffitto. Baci e altri baci la scoperchiano.
E molto in alto le piccole stelle addormentate
sugli alberi mormorano… Silenzio. E poi
foglie d’un vecchio arancio calano giù e si stendono
a soffocare il letto vuoto.
*
PRENDE QUALCOSA. Cose da niente. Un bicchiere,
un golf fatto a maglia. «Il bricco, prendi il bricco»,
le grida la madre. E lei lo prende e dentro ci nasconde
una bambola di pezza, piegata in quattro. E la
croce d’osso di sua nonna. Poi avvolge la coperta,
la sua casa. Tutta la casa. E iniziano tre giorni di
marcia fino al mare. Di notte, passando sotto il filo
spinato la coperta s’impiglia, rimane agganciata. E
resta per sempre indietro la casa. Ora sale con gli
altri sulla barca, reggendo tra le mani solo la sua
sorte. Ignota.

L’autrice:
Iulita Iliopulu, poetessa greca nata nel 1965, ha studiato letteratura bizantina e neogreca all’Università di Atene e teatro alla Scuola d’arte drammatica dell’Accademia di Atene.
Scrive poesie, saggi e fiabe per bambini. Suoi componimenti sono tradotti in inglese, francese, spagnolo, italiano in antologie e riviste letterarie.
Autrice di otto raccolte poetiche, ha tradotto “In difesa della poesia” di Percy B. Shelley e ha scritto diversi saggi e uno studio critico sulla poesia del Premio Nobel Odisseas Elitis.
Si è occupata dell’opera del poeta anche con numerose conferenze e letture di suoi versi in Grecia e all’estero, oltre a curare l’edizione di molti suoi libri.
(Iulita Iliopulu “Il mosaico della notte”, traduzioni di Paola Maria Minucci e Chiara Catapano, pp. 192, 16 euro, Donzelli Editore 2022)
Immagini ———————–
Entrance
The Journey
di Alla Volobyeva

Tempo presente ————————
Che cos’è la follia? È un’identità, credo, più che una malattia
Elena Cerkvenič, “Sono schizofrenica e amo la mia follia”
di Anna Piccioni

“Sono schizofrenica e amo la mia follia“: già il titolo è un grande atto di coraggio di Elena Cerkvenič, ammettere la propria malattia e inoltre aggiungere di amarla credo sia una rarità; soprattutto in questa realtà che ci circonda, in cui la ricerca della perfezione e dell’apparire ineccepibili sono i canoni fondamentali per essere accettati.
Ma ad Elena tutto questo non interessa; credo che la ragione principale che l’ha spinta a mettere per iscritto il suo percorso di sofferenza, di tragedia, sia un grande atto d’amore per tutti: se non è possibile guarire dalla schizofrenia è bene saper tenerla a bada, e sapere riconoscere i sintomi prevenendo le crisi è un modo per convincersi che una vita normale sia possibile.
In questo racconto autobiografico Elena ci racconta il momento in cui la malattia si è manifestata: così all’improvviso a una donna non ancora trentenne, mentre stava costruendo il suo futuro. Insegnante di tedesco, si trovava a Monaco di Baviera per un corso di perfezionamento, quando all’improvviso durante la lezione vengo presa da un malessere, come una pressione allo stomaco[…]all’istante comincio ad avere dei deliri […]credo di venir trasportata nei campi di concentramento in Siberia… (pag. 12).
Subirà la triste esperienza del ricovero nella clinica psichiatrica di Haar. D’improvviso la giovane ragazza, che si impegnava molto per diventare una brava insegnante di tedesco e una brava ricercatrice ( pag. 14) si trova ad affrontare un vuoto disumano. Vittorio, suo marito, verrà a prenderla per portarla a Trieste, dove sarà accolta dalle strutture e dal personale che portano avanti la rivoluzione di Basaglia.
Ritornare a casa e cominciare a vivere non è facile, ma la costante presenza di Vittorio, che Elena chiama Formichino, presente e vigile, mai insistente o invadente, sarà, e lo è tutt’ora, un grande conforto.
Elena sa che deve riprendere la sua vita, il suo ruolo di moglie e di madre; costano fatica questi ruoli, ma grazie alle persone che le stanno intorno un po’ alla volta comincia ad uscire dal suo mondo. Con grande poesia Elena ci racconta la gioia di entrare nella sua cucina, al mattino, e prepararsi il caffè: gesti semplici ma importanti per lei che si ritrova nella quotidianità.
Oppure l’importanza di riconquistare il piacere di bere un bicchiere d’acqua; la descrizione particolareggiata mi ha fatto pensare a “sorella acqua, pura e casta” de Il Cantico delle creature di Francesco d’Assisi.
Ricordare quei momenti, metterli per iscritto hanno ancora il potere di far soffrire, ma la sua forza sta proprio nel metter nero su bianco, come fosse un modo per esorcizzarli.
All’inizio ho sottolineato il coraggio della Cerkvenič di mettere a nudo la sua fragilità mentale, ma allo stesso tempo questo diario ha anche un valore politico, in quanto rende onore e merito alla struttura sanitaria per le malattie mentali, con personale preparato e pronto ad intervenire umanamente. Questo è un manifesto a sostegno di quella che è stata ed è la legge 180, e un riconoscimento a Franco Basaglia che ha saputo vedere lontano nel dare dignità umana ai cosiddetti “matti”.

Dal libro:
“Era tempo che mi premeva dentro. Ma solo oggi, all’improvviso, è diventato urgenza. Il pensiero di consegnare la storia della mia sofferenza mentale alle pagine di un diario. Mi è faticoso, a volte, ricordare. Mi è faticoso scrivere. Tutti i giorni, mi rendo conto, è impossibile. Ma so che nel dolore sono stata fortunata e voglio continuare, come posso, quando posso.”

Intervista a Elena Cerkvenič:
Come è nato il titolo del libro?
A dire il vero è capitato che il titolo sia nato spontaneamente, dopo che ho finito di scrivere la mia testimonianza. In realtà esso rispecchia la mia massima accoglienza del mio disturbo, e io credo che la prima cosa utile da fare per guarire da un disturbo psichico è accoglierlo serenamente, approfondire la sua conoscenza e, se non passa, convivere pacificamente con lui.
Ho sviluppato questo mio atteggiamento nei confronti della malattia ad un certo punto del mio processo di guarigione. Non è stato sempre così. Per lungo tempo ho combattuto questo mio disturbo, come se fosse un acerrimo nemico, vergognandomene e avendo sensi di colpa. Ma per fortuna non è più così.
Ma cos’è la schizofrenia, quali sono le sue cause?
Non saprei. Per me la schizofrenia fa parte della mia identità. È parte di me. Sono proiettata nel presente e un po’ anche nel futuro. Rimuginare sulle possibili cause, sulle origini del mio disturbo è un’attività che non mi appartiene, non fa per me. Se lo facessi perderei l’intensità del piacere che ti offre la vita quando vivi il qui ed ora.
Vivere intensamente il presente, questo è anche il mio modo per stare bene con me stessa e con gli altri.
Nel libro racconti con nomi e cognomi le persone che ti hanno aiutato, ma anche chi sembrava essere lì “per caso”…
Sì, moltissimi mi hanno sostenuta, incoraggiata, stimolata, rassicurata. Questo è stato fondamentale per il mio percorso di guarigione. Prendere un aperitivo in un caffè storico del centro città con la psichiatra, è stata una strategia terapeutica nei miei confronti, caratterizzata da una relazione tra me e lei alla pari, dove la psichiatra è stata capace di togliersi il ruolo di medico e indossare il ruolo di una persona amica e affettuosa nei miei confronti.
Percepivo la sua gentile accoglienza nei miei confronti, la sua disponibilità ad essere in empatia con me. È questo mi ha fatto molto bene. Ho ancora un bellissimo ricordo di questa esperienza terapeutica.
È capitato anche di incontrare un medico che, mentre ero a colloquio, guardava incessantemente l’orologio e percepivo la sua distanza di mille miglia dalla mia persona, e questo non va bene, questo atteggiamento fa molto male, non è un atteggiamento finalizzato alla cura.
Questa tua esperienza quanto ti ha permesso di imparare di te?
Ho imparato che niente è determinato, niente è fissato per sempre, né in me, né fuori di me. Tutto si trasforma, attimo dopo attimo. Mi metto sempre nell’ottica di imparare su di me, perché tutto in me e fuori di me è sempre in movimento e in cambiamento, niente è fisso, niente è così per sempre.
E la conoscenza di me stessa è per me una costante attività di ricerca ed esplorazione di ciò che io posso essere, di ciò che io posso fare.
La tua famiglia è un punto fermo, ma quanto ne ha risentito?
Non saprei, sarebbe il caso di chiedere ai miei famigliari. Sicuramente trovarsi di fronte a una persona cara, mentre questa è in crisi psicotica, non è sicuramente una passeggiata rilassante nel bosco. Mio marito si è trovato accanto una donna che per lunghissimi anni non riusciva né a lavargli né a stirargli le camicie, perché il peso del disturbo rendeva impossibile qualsiasi attività quotidiana anche quella più semplice come preparare un pranzo o lavare i piatti.
Ero del tutto paralizzata nei miei movimenti: era come se il mio cervello, la mia mente non riuscissero a dare il comando alle mie gambe, alle mie braccia e alle mie mani per attivare il movimento. Rimanevo ore e ore stesa inerte sul divano a contemplare i miei libri nella libreria del mio soggiorno nell’attesa dell’ora in cui, con un peso infinito e una fatica senza misura, sarei andata con l’auto a prendere mio figlio da scuola e saremmo venuti assieme a casa.
Attorno alla mia persona c’era un muro ben spesso, che mi impediva di entrare in una anche minima relazione con l’alterità, sia con elementi dell’ambiente esterno a me e sia con le persone, anche con quelle a me molto care, mio figlio e mio marito.
Mio figlio comunque è cresciuto accanto a una madre che, sebbene per molti aspetti impalpabile, nutriva per lui, sin da ancora prima che nascesse, un amore infinito.
Il tuo impegno culturale quando è nato?
È nato circa dieci anni fa grazie alle moltissime persone amiche, per lo più intellettuali, che hanno creduto nelle mie capacità creative e organizzative. Queste persone, che sono state e sono tuttora tantissime, hanno dimostrato grande fiducia in me, mi hanno dato degli stimoli intellettuali che io ho saputo cogliere e poi concretizzare. Sono molto felice di questo.

L’autrice:
Elena Cerkvenič è nata a Trieste, dove ha sempre vissuto e vive tuttora impegnandosi nell’organizzazione di iniziative culturali e presentazioni di libri.
Ha collaborato e collabora con associazioni culturali, biblioteche, librerie e scuole, ai fini dell’organizzazione di incontri culturali. È di origini slovene, bilingue. Ha una laurea in lingue, un’
esperienza di lavoro come insegnante di tedesco e traduttrice. Ha pubblicato due raccolte di poesie, “Amore chissà se” (Editrice San Marco, 2009) e “Sapor di.vini” (Ibiskos Editrice 2012).
(Elena Cerkvenič “Sono schizofrenica e amo la mia follia” pp.128, 12 euro, Meltemi Editore 2024)

Il libro di Elena Cerkvenič “Sono schizofrenica e amo la mia follia” verrà presentato a Gorizia martedì 29 ottobre alle 18 presso l’Auditorium Formedil, in via del Monte Santo 131.
L’iniziativa è inserita nell’Edizione Autunno 2024 degli appuntamenti letterari organizzata dall’Associazione culturale Il Libro delle 18.03. Dialogherà con l’autrice Marco Menato.
Immagini ———————–
Let everything not seen be seen
The Journey
di Dynny Oleksij

Gli artisti ucraini proposti su questo Fare Voci e protagonisti del progetto The Journey:
Sergey Dobrynov è nato a Lugansk. Con l’inizio della guerra in Ucraina, si è trasferito da Lugansk a Poltava.
È un maestro di arti decorative e applicate. La sua specialità è la pittura su vetro.
Nel suo lavoro, utilizza vetro, colori a olio e inchiostro. Ha partecipato a molte mostre in tutto il mondo.
Alla Volobyeva è nata a Kiev. Nel 2002 si è laureata alla Republican Art School intitolata a T.G. Shevchenko. Dal 2003 studia alla National Academy of Fine Arts and Architecture nel laboratorio di Huyda (insegnanti: M. Huyda, O. Yasenev). Lavora nel campo della pittura.
Petro Hrytsiuk ha iniziato la sua formazione artistica alla Kosiv School of Applied and Decorative Arts.
In seguito ha studiato al Department of Art Metal presso la Lviv National Academy of Arts e, nell’ambito del programma di scambio Erasmus, ha studiato all’Academy of Fine Arts di Lodz, in Polonia.
Oleksiy Dinnyk è nato nel 1988 nel villaggio di Stuzhytsia, distretto di Velikobereznya, regione di Zakarpattia. Dal 2015 lavora come insegnante presso la Transcarpathian Academy of Arts. Vive a Uzhgorod.
Maria Drozdova è nata nel 1988 a Kharkiv, Ucraina. Ha studiato pittura monumentale alla Kharkiv State Academy of Design and Art e performance art come parte della borsa di studio del Ministro della Cultura polacco “Gaude Polonia”.
Mikhail Ray è un artista e curatore multidisciplinare di Kherson. Dall’inizio dell’assalto russo su vasta scala all’Ucraina, Ray è rimasto nella Kherson occupata per usare la sua arte come forma di resistenza. Le sue opere sono state premiate ed esposte in tutto il mondo e sono conservate in collezioni private in Germania, Paesi Bassi, Stati Uniti e Ucraina.
Stanislav Zhalobniuk è nato nel 1976 a Odessa. Ha ricevuto la sua educazione artistica presso la Scuola statale d’arte e di teatro di Odessa M.B. Grekov (dipartimento “pittura”) nel 1996-2001. Nel 1999 inizia la sua attività espositiva. Le sue opere sono conservate in collezioni private di Ucraina, Germania, Stati Uniti e Russia.

Intervista ad Enzo Comin:
Ideatore e curatore del progetto The Journey
Come nasce il progetto “The Journey”? E da cosa è animato?
Il progetto “The Journey” nasce dall’osservazione, nel corso degli anni di attività come artista visivo, di quanto sia poco o inesistente lo spazio dedicato alla vita degli artisti nelle pubblicazioni di settore. Intendendo proprio quanto accade all’artista al di là della sua attività e produzione artistica.
Quando frequentavo Venezia, mi relazionavo molto con varie figure come curatori, galleristi e critici, eppure, anche se la vita degli artisti e i loro “dietro le quinte” erano motivo di interesse, questi non potevano poi trovare sufficiente spazio quando veniva spiegata la mostra d’arte o l’artista veniva intervistato. Ritengo che quello che succede nella quotidianità, anche ciò che è apparentemente trascurabile, nasconda sempre una imprevedibilità di cui vale la pena raccontare. Specialmente se è parte della quotidianità di una persona, come un artista, di cui spesso non si sa bene come viva o come trascorra le giornate.
È così che ho cominciato a immaginare una pubblicazione che ospitasse ciò che capita a me e ai miei colleghi, al di là… degli orari di lavoro nell’atelier. Spesso, infatti, anche un evento banale, come uno positivo e un altro drammatico concorrono a creare la rete di esperienze e sentimenti che l’artista adopererà quando entra nel proprio atelier. Oppure no, ma poter scoprire cosa succede è un modo per conoscerlo oltre al semplice visitare la sua mostra.
Così, l’anno scorso ho pubblicato una open call in varie piattaforme visitate da artisti in Italia e all’estero con la semplice proposta di contribuire al primo numero di una fanzine condividendo fatti accaduti nella propria vita mentre si lavora a qualche progetto artistico.
Ammetto che non è stato facile, molti artisti non capivano come partecipare e credo che il motivo è legato al non essere abituati a parlare di sé ma solo del proprio lavoro. Infatti, mi mandavano immagini delle loro opere ma “The Journey” non è quel genere di vetrina, di quelle ce ne sono già tante.
Quale la prima impressione dei lavori degli artisti ucraini che hai ricevuto?
È stata una forte suggestione, perché il mio obiettivo, come avevo precisato anche nel testo del bando per poter prendere parte al numero 1 della fanzine, era di condividere il dietro le quinte della propria vita come artista… e la prima persona che mi scrisse è stato appunto un pittore dall’Ucraina.
Si chiama Sergey Dobrynov, e mi ha raccontato che il suo “dietro le quinte” è, ovviamente, quanto sta accadendo nel suo paese, e il suo inaspettato ritrovarsi chiuso in una casa circondata dall’esercito. Non mi sarei mai aspettato una testimonianza simile.
Si può dire che con quel primo contatto, “The Journey” avesse già raggiunto un risultato che andasse ben al di là di quanto immaginato. Cosa poteva esserci, infatti, di più imprevedibile… Non avevo idea che potesse diventare davvero uno spazio per parlare di qualcosa di cui non si parla.
Non è che la guerra non sia discussa, ci sono media che hanno autorità per farlo, al posto di una fanzine. Però, siccome i giornali di arte trattano della scena artistica e gli artisti ucraini non hanno occasioni dirette per raccontarsi poiché isolati, è come se scomparissero.
In “The journey”, viene mostrata la vita degli artisti e possono tornare sotto ai riflettori. E così, ho pensato di dedicare il primo numero agli artisti ucraini che avrebbero risposto alla call. Alla fine, oltre a Sergey se ne sono aggiunti altri sei. Ho voluto mostrare i loro lavori artistici degli ultimi anni perché questi, infatti, narrano, attraverso il modo in cui sono stati realizzati, cosa hanno provato sulla pelle nell’attuale scenario del loro Paese.
Nella fanzine, sono riportati anche dei testi che mi hanno inviato per condividere a parole vicende e sentimenti. Tuttavia, la cosa che più mi colpisce è vedere come la interiorità e quanto succede esteriormente si unisce in una immagine e con quanta forza e chiarezza si esprima. Specie in chi è stato obbligato a cambiare tecnica perché non trovava i soliti materiali o non poteva lavorare con l’elettricità.
E cosa emerge di più, in modo più determinato, dai loro lavori?
Non sono un critico d’arte, ma un artista proprio come loro. Quello che a me ha attirato l’attenzione è stato quanto da loro sperimentato. “The journey”, in fin dei conti, tratta di questo.
Tuttavia, è la loro arte a raccontare di tutto ciò, molto più di quanto si potrebbe fare con un reportage delle città bombardate, o almeno questo vale per noi che ricerchiamo l’esperienza dell’artista. In effetti, ognuno di loro non ha potuto o voluto ignorare quanto i pensieri e i sentimenti abbiano subito una prova che nell’opera riesce a esprimersi.
Lo so perché la stesura del primo numero mi ha impegnato a una relazione con loro che è durata vari mesi. Ad esempio, Dobrynov dipinge i paesaggi che ama all’aria aperta e ora è stato costretto a impararlo a fare al chiuso, evocandoli con la memoria; Zhalobniuk è diventato estremamente prolifico facendo sì che ogni suo lavoro colpisca chi lo guarda aggiungendo elementi che facciano ricordare la guerra, il suo Paese dev’essere meraviglioso proprio per la forza nel trasformarlo in una stesura di colore rosso fuoco; Ray propone fotografie con all’interno piccole modifiche assurde, però, essendo immagini del contesto della guerra, possono essere confuse come reali… poi, leggi il diario che condivide sul suo sito e tutto diventa tragicamente chiaro; Drozdova vive a Charchiv, una delle città più colpite dai bombardamenti, lei è stata obbligata a tornare a realizzare i propri lavori manualmente ritrovandosi senza elettricità, acqua e quant’altro; Volobyeva ha riprodotto in varie versioni l’immagine di un toro fuori controllo, è consapevole che rappresenta la sua angoscia durante l’invasione russa, fatto che ha vissuto nel periodo in cui doveva partorire; Hrytsiuk continua a produrre come se fosse un’azione di resistenza, spesso i suoi lavori sono in vendita al fine di raccogliere fondi per chi è al fronte; Oleksij è colui che propone dipinti di soggetti che in apparenza paiono quasi romantici, e infine rivelano un’atmosfera inquieta.
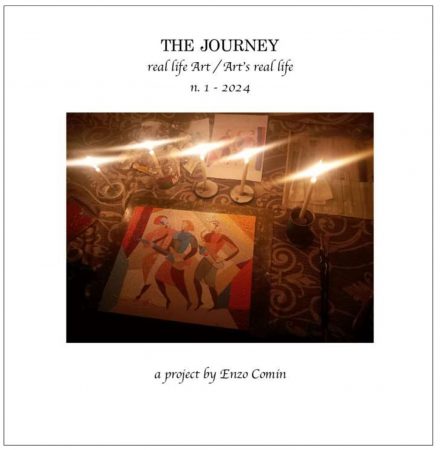
In che modo, pensi, si pongano nel panorama odierno dell’arte contemporanea?
Ciascun artista ha dimostrato di anteporre un’urgenza nel mettere in scena ciò che registra nel proprio mondo interno in relazione con quello esterno. E questo è a mio avviso qualche cosa di molto contemporaneo, specialmente perché gli artisti ucraini si sentono componenti di un processo molto più grande di loro.
Sanno di avere gli occhi puntati dell’intero mondo, per via della trasformazione del loro paese in un campo di battaglia. Eppure, proprio per questo, lavorano con la consapevolezza di essere finiti isolati, tagliati fuori dalla scena artistica caratterizzata da scambi, confronti e un mercato. Infatti, il solo fatto di aver accettato di venire coinvolti nel progetto della fanzine, benché autoprodotto e di nicchia, fa capire quanto siano pronti e incuriositi a lavorare su più piani e mettendo davanti gli interessi creativi.
Questi, però, comunque subiscono il rendersi conto che alcuni fra loro sono al fronte a occuparsi di qualcosa di incredibile fino a poco prima: la difesa del paese.
In Ucraina, continuano a esserci gallerie d’arte, eventi culturali vengono in un qualche modo organizzati e trasferte all’estero. Inoltre, sono vari i curatori d’arte che organizzano in giro per l’Europa eventi per mostrare l’arte creata in quel contesto. Io stesso, dopo l’uscita della fanzine, ho ricevuto vari inviti da centri culturali per presentare questo progetto ed eventualmente organizzare una mostra con questi artisti. Infine, interviste per poter parlare di quanto gli artisti mi hanno raccontato.
Tuttavia, nulla di ciò è stato per me realizzato con un qualche intento politico, ma solo artistico. O meglio, ho percepito che gli artisti in quelle aree soffrivano per un essere finiti di forza nell’ombra e il mio pensare a un’idea che potesse essere d’aiuto era un modo per dare una mano a un collega, un amico, un componente di un gruppo al quale io stesso faccio parte. E anche questa azione, questa posizione, è molto contemporanea.
Quale, secondo te, è il tratto che li accomuna, e cosa invece li distingue ciascuno nella propria identità?
Il tratto che li accomuna è il considerarsi parte attiva di una resistenza. Quindi, è come se i propri strumenti culturali che si manifestano attraverso i progetti artistici siano delle azioni o delle armi vere e proprie contro il pericolo che percepiscono di subire.
L’arte è intesa come una opportunità comunicativa di un’efficacia che travalica quanto possa essere in grado di mostrare un notiziario o un bollettino di guerra. I supporti deformati oppure la pittura che accusa un calo di qualità denunciano l’esercito aggressore più di un’operazione propagandistica mirata.
Sia l’artista che si è ritrovato in una zona di guerra, sia quello che per motivi geografici ne è molto lontano hanno affrontato quasi in un modo uguale una crisi sul senso stesso di fare arte. Di fronte allo scenario che si dispiega oggi, che valore ha continuare a proporre dell’arte? Tutti loro, se lo sono domandato. Attraverso esperienze che per ciascuno sono risultate distinte, sono tutti giunti alla conclusione che l’arte è quanto li contraddistingue.
Ed è quanto permetterà di fornire loro il contributo a una reazione che, forse, in principio era immaginata solitaria e, pertanto, priva di conseguenze, ma poi nel tempo si è rivelata compatta. Per la quale, presumo, anche “The journey” ha dato un apporto fornendo dello spazio. Prima dell’attuale scenario, erano artisti che non sarebbe stato così scontato vederli insieme in una stessa mostra, per via delle differenze estetiche e di espressione.
Ora, tali differenze rendono più incisivo un messaggio, che spesso cela rabbia, che finisce in un modo o in un altro per farsi strada.
Quale sarà il prossimo passo di “The Journey”?
Il prossimo passo di “The journey” sarà la condivisione del primo numero e, così, il racconto degli artisti ospitati. In concomitanza con l’uscita di questo numero di “Fare Voci”, è stata festeggiata una presentazione ufficiale durante la ventesima Giornata del Contemporaneo, 12 ottobre 2024, presso gli spazi di CasaNetural Gorizia, e con una mostra di lavori miei e di altri due artisti della zona: Roberto Cantarutti e Aleksander Velišček.
In realtà, dopo l’uscita del primo numero della fanzine, parecchie figure in giro per l’Europa mi hanno contattato per esprimere l’interesse per il progetto. Questo passa dai complimenti ricevuti da associazioni culturali, fino a proposte di organizzare qualcosa insieme.
Ammetto che creare connessioni tra gli artisti presenti nella fanzine e la scena dell’arte europea era un mio sogno fin dal principio, e forse diventerà davvero concreto con una loro mostra d’arte.
Confesso, però, che sono rimasto sorpreso per tutte queste attenzioni, come ad esempio per l’intervista richiesta dal Wilson Center, uno dei centri studi più importanti al mondo sul dialogo internazionale, perché quello che ho fatto non è stato nulla di eccezionale se non cercare di rapportarmi con altre persone… per vedere cosa fare insieme.
Probabilmente, nella prossima Primavera uscirà una nuova call per il secondo numero, in una modalità che ancora non so prevedere poiché nel frattempo ho ricevuto proposte di collaborazione per contribuire nella grafica o nella commercializzazione della versione stampata.
Per ora, è stato tutto realizzato in modo artigianale e a chi ha richiesto una copia, si è vista recapitarsela spedita direttamente da me.

L’artista e curatore di The Journey:
Enzo Comin vive attualmente a Gorizia, dopo aver viaggiato negli ultimi vent’anni. È interessato a unire più realtà espressive, così frequenta l’Accademia di Cinematografia di Bologna e la Summer Academy di Salisburgo.
Oltre a essere un artista visivo e performer, è autore di testi poetici che spesso sono alla base dei progetti artistici.
Ha ricevuto premi, riconoscimenti e la pubblicazione de “La magia ha sempre due nomi” (Montedit). Affianca la proposta di racconti e romanzi, mentre l’aspetto filosofico del proprio lavoro è condiviso attraverso saggi, come “Vangelo pratico” (Anima Edizioni) e il podcast “Vita creativa esoterica”.
A settembre 2024 è uscito il suo primo romanzo per la casa editrice Lifebooks: “Armonia delle resistenze”.
rivista Fare Voci
curata da Giovanni Fierro
collaboratori:
Roberto Lamantea, Anna Piccioni, Antonio Nazzaro, Antonello Bifulco, Luigi Auriemma, Laura Mautone, Massimiliano Bottazzo, Ilaria Battista, Livio Caruso.

